 Mappare lo sceneggiato televisivo di questi ultimi vent’anni è un’impresa ardua che nemmeno sogno di tentare. Mi limito ad alcune considerazioni, appunti appunto, sul genere giallo/thriller e le sue mutazioni; inoltre preferisco concentrarmi sulle fiction RAI, dal sapore maggiormente istituzionale, legate a un certo discorso ufficiale sulla società italiana.
Mappare lo sceneggiato televisivo di questi ultimi vent’anni è un’impresa ardua che nemmeno sogno di tentare. Mi limito ad alcune considerazioni, appunti appunto, sul genere giallo/thriller e le sue mutazioni; inoltre preferisco concentrarmi sulle fiction RAI, dal sapore maggiormente istituzionale, legate a un certo discorso ufficiale sulla società italiana.
Anzitutto mi pare che il giallo, così come il genere poliziesco, goda di ottima salute. I primi anni 2000 vedono ancora fiction legate a un certo gusto cinematografico. Il giallo (leggiamo pure thriller) pare ancora legato agli ultimi fuochi di un genere che nei primi anni ’70 ha dato il meglio di sé per poi spegnersi e cambiare forma nei decenni successivi; penso a prodotti come Tutto in quella notte, una miniserie in due puntate andate in onda nel 2002 con la regia di Massimo Spano e un bel cast che vede tra i personaggi principali attori come Enzo DeCaro, Simona Cavallari e un sempre efficace Franco Castellano; Spano è bravo a costruire una storia insolita per il piccolo schermo, con un’impresa di pulizia, un palazzo della zona Eur e brutali omicidi dal sapore molto thrilling. Si vede che il modello inconscio è ancora Argento, anche perché la sceneggiatura è di una coppia d’oro degli sceneggiati degli anni ‘90, ossia Laura Toscano (già autrice di numerosi thrilling negli anni ’70 pubblicati nella collana dei KKK) e Franco Marotta. Massimo Spano, prima di passare dietro alla macchina da presa è stato un importante scenografo del cinema italiano, e qui è attento a costruire gli spazi attorno ai personaggi, girando una vicenda quasi claustrofobica, ambientata nella prima parte quasi tutta di notte; i personaggi sono ben delineati e hanno tutti delle ombre oscure che gravano sul loro passato.
 Non dissimile il discorso per uno sceneggiato come La donna che ritorna (miniserie trasmessa tra l’ottobre e il novembre del 2011 su Rai Uno), con la regia di Gianni Lepre e nel cast Virna Lisi e Fabio Testi. Lepre (già regista di trasmissioni storiche come Telefono giallo e Chi l’ha visto?) e il soggettista della serie Peter Exacoustos (autore anche del soggetto di serie di Scomparsa, altra fiction gialla incentrata su torbidi intrighi in una località all’apparenza linda e pulita come San Benedetto del Tronto, dove spariranno due ragazzine minorenni e verranno a galla sinistri festini a cui partecipano i personaggi più importanti e altolocati della zona) lavorano a una storia che riesce a riportare il sapore degli anni ’70 dentro il mondo di oggi. Virna Lisi, in una delle sue ultime apparizioni, è una donna anziana che porta dietro di sé i segreti di un passato ingombrante che richiama il clima politico agitato degli anni ’70; senza anticipare troppo, la storia allude da vicino a certi episodi di cronaca nera di allora, mescolandoli con un plot dal forte sapore thriller, con tanto di mano guantata dell’assassino.
Non dissimile il discorso per uno sceneggiato come La donna che ritorna (miniserie trasmessa tra l’ottobre e il novembre del 2011 su Rai Uno), con la regia di Gianni Lepre e nel cast Virna Lisi e Fabio Testi. Lepre (già regista di trasmissioni storiche come Telefono giallo e Chi l’ha visto?) e il soggettista della serie Peter Exacoustos (autore anche del soggetto di serie di Scomparsa, altra fiction gialla incentrata su torbidi intrighi in una località all’apparenza linda e pulita come San Benedetto del Tronto, dove spariranno due ragazzine minorenni e verranno a galla sinistri festini a cui partecipano i personaggi più importanti e altolocati della zona) lavorano a una storia che riesce a riportare il sapore degli anni ’70 dentro il mondo di oggi. Virna Lisi, in una delle sue ultime apparizioni, è una donna anziana che porta dietro di sé i segreti di un passato ingombrante che richiama il clima politico agitato degli anni ’70; senza anticipare troppo, la storia allude da vicino a certi episodi di cronaca nera di allora, mescolandoli con un plot dal forte sapore thriller, con tanto di mano guantata dell’assassino.
In questi sceneggiati la forma del giallo è ancora contaminata col thriller di matrice argentiana (le soggettive del killer, l’occhio del pazzo, la mano guantata, le coreografie visive degli omicidi) annacquato in storie molto lunghe riempite di personaggi, relazioni, amori, tradimenti e le solite lungaggini sentimentali. Tuttavia ne esce un prodotto godibile, soprattutto se si pensa che è pensato e prodotto per un pubblico di prima serata. Simile il discorso per una fiction come Zodiaco, miniserie di Rai Due affidata a Eros Puglielli (che nel 2004 aveva diretto benissimo Occhi di cristallo, uno degli ultimi thriller ad arrivare sul grande schermo e che al thriller tornerà con un capolavoro come Il bosco, miniserie prodotta per Canale 5 nel 2015); si tratta di un thriller interessante, girato a Torino e dintorni, costruito su una storia più in sintonia col grande racconto televisivo (tra i soggettisti figura anche Riccardo Donna, forse uno degli autori più rappresentativi di questi ultimi anni) fatto di saghe di famiglia, intrighi e tradimenti in cui tutti sembrano nascondere qualcosa; la vicenda infatti gira intorno a una grande casata di banchieri presi di mira da un misterioso assassino ossessionato dai segreti di quella Torino bene. Il cast è dei migliori (su tutti segnalo un prezioso Vanni Corbellini, qui tornato a suo agio nel genere dopo Le foto di Gioia di Lamberto Bava).
 Sul genere anche La terza verità, miniserie di Rai Uno di Stefano Reali (già assistente di Leone in C’era una volta in America), con Enzo DeCaro e una splendida Bianca Guaccero. La terza verità recupera le suggestioni del caso sul mostro di Firenze senza citarlo apertamente, mescolandone la storia con le indagini (allora abbastanza recenti) sul medico perugino Narducci; DeCaro interpreta una sorta di Narducci ancora vivo (non è un caso che la trama sia ambientata in una splendida Perugia, già capitale del thriller anni ’70 con I corpi presentano tracce di violenza carnale) sospettato dei delitti di un maniaco che si accanisce sulle coppiette. L’ombra della cronaca, la capacità di sfruttare la provincia o le località italiane (Torino, Roma, Perugia) più diverse caratterizzano un primo elemento di qualità di questi prodotti, vicini per sintassi e gusto a certo cinema thriller del passato (è sintomatico che pure Argento, ormai appannato, giri nei primi anni Duemila un film come Il Cartaio, simile nell’estetica a una puntata di Distretto di polizia).
Sul genere anche La terza verità, miniserie di Rai Uno di Stefano Reali (già assistente di Leone in C’era una volta in America), con Enzo DeCaro e una splendida Bianca Guaccero. La terza verità recupera le suggestioni del caso sul mostro di Firenze senza citarlo apertamente, mescolandone la storia con le indagini (allora abbastanza recenti) sul medico perugino Narducci; DeCaro interpreta una sorta di Narducci ancora vivo (non è un caso che la trama sia ambientata in una splendida Perugia, già capitale del thriller anni ’70 con I corpi presentano tracce di violenza carnale) sospettato dei delitti di un maniaco che si accanisce sulle coppiette. L’ombra della cronaca, la capacità di sfruttare la provincia o le località italiane (Torino, Roma, Perugia) più diverse caratterizzano un primo elemento di qualità di questi prodotti, vicini per sintassi e gusto a certo cinema thriller del passato (è sintomatico che pure Argento, ormai appannato, giri nei primi anni Duemila un film come Il Cartaio, simile nell’estetica a una puntata di Distretto di polizia).
Un certo cambiamento è impresso dal successo sempre crescente delle fiction incentrate sul personaggio fisso di un commissario di polizia. Nel Commissario Montalbano (fiction chiave di RaiUno andata in onda per la prima volta nel 1999 e ancora in produzione), Camilleri e il regista Alberto Sironi confezionano un prodotto perfetto in cui le gesta del maniaco, i traumi e l’intreccio sincopato del thriller sembrano oscurati dalle gesta del personaggio principale. Montalbano, come i suoi doppi Rocco Schiavone (RaiDue, 2016) o i Bastardi di Pizzofalcone (RaiUno, 2017) o ancora il Soneri di Nebbie e Delitti (RaiDue, 2005), è la figura del commissario per antonomasia; assorbe e inonda la trama, la riempie e la piega su di sé; il personaggio televisivo interpretato da Zingaretti (quindi con una somma in più rispetto al corrispettivo letterario, perché qui lo ricordo, non mi interessa il testo scritto alla base di questi lavori, bensì la sua resa visiva, l’essere testi destinati a un consumo televisivo e seriale, quindi di genere) è una figura dentro le regole, ma capace, all’occasione di infrangerle o aggirarle. Lo spettatore resta affascinato e quasi desidera finire sulla sedia degli interrogatori e scontare le sue colpe segrete, espiare i propri piccoli peccati da uomo medio che tradisce la moglie, froda il fisco e deride qualche collega. I gialli televisivi di Andrea Camilleri sono uno specchio mediatico di una certa realtà: delitti e intrighi comuni, tribolazioni quotidiane, cose che accadono o possono accadere; i volti dei sospetti sono i nostri e Vigata è un’Italia in miniatura, un angolo di mondo (perché tutta l’Italia è un angolo di mondo) affastellato di paesaggi e brogli burocratici su cui Montalbano indaga imponendosi per carisma e intelligenza; su di lui si riflettono i valori istituzionali (e pedagogici) di una certa società civile e riformatrice che contrasta con le bassezze ruffiane del profittatore di turno; eppure lo stereotipo di una certa italianità è sempre dietro l’angolo e anche se tutto è cambiato, le cose restano sempre uguali; le nostre facce saranno meno iconiche rispetto ai vari Sordi e Gassman, ma non meno colpevoli. I lori ritratti ispiravano almeno simpatia, questi di oggi no! Colpisce comunque, in tanta fiction gialla di oggi, l’immedesimazione nelle figure di commissari, poliziotti integerrimi, carabinieri e magistrati che ci raccontano un paese reale alternativo a quello corrotto, clientelare e di mantenuti che si ricava dal vivere giorno dopo giorno nello stivale; e colpisce anche la lontananza di questi tutori dell’ordine dai truci fantasmi col manganello di Bolzaneto o di quelli nella cella di Cucchi, povero cristo che fino all’altro giorno ci volevano raccontare essersi ammazzato di botte da solo…
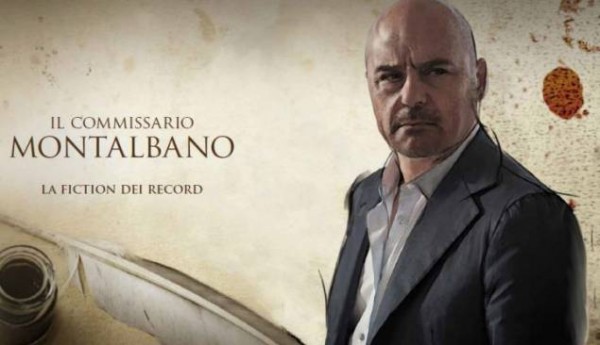 Dunque, fin qui abbiamo visto un primo tipo di giallo che ancora riprendeva gli ultimi stilemi di certo cinema thriller del passato; poi con Montalbano la figura del maniaco s’è asciugata fino a sparire e le storie sono diventate dei gialli classici, con intrecci complicati, personaggi di contorno e il mistero puro di un enigma non necessariamente condito con litri di sangue (e non è un caso che Montalbano sia probabilmente l’ultimo classico della televisione italiana, un classico non a caso nato dalla letteratura e per questo assimilabile a un giallo con aspirazioni letterarie praticato dagli anni ’70 ad oggi da autori imprescindibili come Fruttero & Lucentini, Piero Chiara, Paolo Levi e Camilleri appunto).
Dunque, fin qui abbiamo visto un primo tipo di giallo che ancora riprendeva gli ultimi stilemi di certo cinema thriller del passato; poi con Montalbano la figura del maniaco s’è asciugata fino a sparire e le storie sono diventate dei gialli classici, con intrecci complicati, personaggi di contorno e il mistero puro di un enigma non necessariamente condito con litri di sangue (e non è un caso che Montalbano sia probabilmente l’ultimo classico della televisione italiana, un classico non a caso nato dalla letteratura e per questo assimilabile a un giallo con aspirazioni letterarie praticato dagli anni ’70 ad oggi da autori imprescindibili come Fruttero & Lucentini, Piero Chiara, Paolo Levi e Camilleri appunto).
Tuttavia Montalbano è un prodotto ormai seriale, immutato in questi vent’anni. Si sono costruite varianti, ma il sugo è sempre quello. La vera novità è venuta in questi ultimi anni, dopo True Detective (2014), serial thriller che ha riscritto le regole di questo genere. Ancora oggi vedo fiction italiane che ne scopiazzano spudoratamente i titoli di testa, senza riuscire ad assorbirne altro. 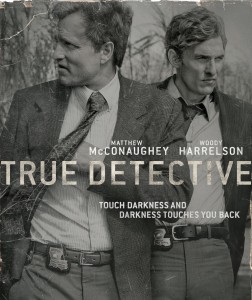 La novità di True Detective si è svelata nel tempo, in particolare nella terza stagione. Nic Pizzolatto, il creatore della serie, ha concepito un thriller che via via si è spogliato della fascinazione occulta del serial killer delle indagini procedurali, del lerciume della cronaca nera, creando un contesto visivo e letterario maggiormente affascinato da concetti come il tempo, lo spazio e la perdita della memoria. In un’epoca come la nostra, affastellata di informazioni in tempo reale, è l’oblio ciò che veramente aneliamo e ci manca. Nic Pizzolatto ha puntato tutto sulle ambientazioni, dando loro un peso non secondario ai personaggi e alle loro psicologie. Anche il thriller letterario delle ultime generazioni ha lavorato sul senso della perdita, della memoria, dello spazio e del tempo, abbandonando i modelli di certo cinema anni ’70 e ’80, penso a modelli fino a non molti anni fa considerati insuperabili come L’uccello dalle piume di cristallo o Il silenzio degli innocenti. Scrittori come Donato Carrisi, Lars Kepler, Sebastian Fitzek, Jean Christophe Grangé e Wulf Dorn, lavorano su trame piene di buchi, sconnesse, in cui la presenza reale di un colpevole diventa sempre più aleatoria e incerta, tanto che i fantasmi, gli unici che realmente esistono, provengono dalla nostra mente, o dall’inconscio digitale del mondo virtuale che ci circonda. In questa letteratura psyco-thriller poi l’ipnosi, le neuroscienze e la neurobiologia si affacciano sempre di più, quasi a ridisegnare i confini di un territorio in cui inconscio e neuroni sono i nuovi tropi di un genere, quasi a traslare l’idea che i manicomi sono chiusi per legge dal 1978, ma adesso il manicomio è chimico e imprigiona ognuno di noi, visto l’uso e l’abuso di farmaci antidepressivi nel mondo occidentale (soprattutto utilizzati per resistere alle avvilenti e usuranti condizioni di certe fasce di lavoratori schiacciati dagli algoritmi della grande distribuzione e dell’e-commerce). Questa letteratura thrilling si affianca a un mondo in cui la narrazione sociobiologica disegna organismi impegnati in una lotta per l’esistenza senza limiti; la dominante è la conservazione della società così come la conosciamo, individualismo possessivo, sfruttamento dei corpi e delle loro sopportabilità lavorative, geni e cellule studiate e mappate per rivendicare uno sciovinismo universale, una xenofobia universale. La società che fa da sfondo in queste narrazioni è la nostra, in poche parole, competitiva, gerarchica e imprenditoriale…
La novità di True Detective si è svelata nel tempo, in particolare nella terza stagione. Nic Pizzolatto, il creatore della serie, ha concepito un thriller che via via si è spogliato della fascinazione occulta del serial killer delle indagini procedurali, del lerciume della cronaca nera, creando un contesto visivo e letterario maggiormente affascinato da concetti come il tempo, lo spazio e la perdita della memoria. In un’epoca come la nostra, affastellata di informazioni in tempo reale, è l’oblio ciò che veramente aneliamo e ci manca. Nic Pizzolatto ha puntato tutto sulle ambientazioni, dando loro un peso non secondario ai personaggi e alle loro psicologie. Anche il thriller letterario delle ultime generazioni ha lavorato sul senso della perdita, della memoria, dello spazio e del tempo, abbandonando i modelli di certo cinema anni ’70 e ’80, penso a modelli fino a non molti anni fa considerati insuperabili come L’uccello dalle piume di cristallo o Il silenzio degli innocenti. Scrittori come Donato Carrisi, Lars Kepler, Sebastian Fitzek, Jean Christophe Grangé e Wulf Dorn, lavorano su trame piene di buchi, sconnesse, in cui la presenza reale di un colpevole diventa sempre più aleatoria e incerta, tanto che i fantasmi, gli unici che realmente esistono, provengono dalla nostra mente, o dall’inconscio digitale del mondo virtuale che ci circonda. In questa letteratura psyco-thriller poi l’ipnosi, le neuroscienze e la neurobiologia si affacciano sempre di più, quasi a ridisegnare i confini di un territorio in cui inconscio e neuroni sono i nuovi tropi di un genere, quasi a traslare l’idea che i manicomi sono chiusi per legge dal 1978, ma adesso il manicomio è chimico e imprigiona ognuno di noi, visto l’uso e l’abuso di farmaci antidepressivi nel mondo occidentale (soprattutto utilizzati per resistere alle avvilenti e usuranti condizioni di certe fasce di lavoratori schiacciati dagli algoritmi della grande distribuzione e dell’e-commerce). Questa letteratura thrilling si affianca a un mondo in cui la narrazione sociobiologica disegna organismi impegnati in una lotta per l’esistenza senza limiti; la dominante è la conservazione della società così come la conosciamo, individualismo possessivo, sfruttamento dei corpi e delle loro sopportabilità lavorative, geni e cellule studiate e mappate per rivendicare uno sciovinismo universale, una xenofobia universale. La società che fa da sfondo in queste narrazioni è la nostra, in poche parole, competitiva, gerarchica e imprenditoriale…
 Su questa strada (in modo blando, politicamente corretto, senza troppi scossoni per le coronarie di un pubblico generalista che forse non esiste nemmeno), credo si sia incamminata una serie come La strada di casa (RaiUno, 2017) diretto da Riccardo Donna (già regista del bellissimo sceneggiato Nebbie e delitti, anche quello prodotto da Luca Barbareschi); il cast, azzeccato, vede un ottimo Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e un Sergio Rubini in stato di grazia. La strada di casa è sicuramente una fiction pensata e ideata nel dopo True Detective. Come quella americana lavora sulla frammentazione del tempo, assumendo l’amnesia (il lungo coma del personaggio di Boni, grosso allevatore di bovini da qualche parte nella Padana superiore, in un contesto agricolo e naturale che ricorda le paludi stigie in cui si aggirano Matthew McConaughey e Woody Harrelson) come una metafora dell’uomo contemporaneo, digitalizzato e frazionato da un mondo in continuo movimento, dominato da un capitalismo invisibile e ubiquo che tutto strozza e stritola (in particolare i piccoli commercianti, i bottegai, i contadini, figure di artigiani che sopravvivono alle nuove regole di un mercato globalizzato). Certo, la parte “gialla” della Strada di casa è annacquata da un certo contesto melodrammatico alquanto banale e noioso, con la solita tiritera della famiglia italiana, polarizzata dal solito padre padrone che pensa quel che è bene per tutti; oltre al padre padrone abbiamo il catalogo completo di banalità, col figlio che vuole affrancarsi facendo birra artigianale, la figlia che voleva studiare medicina e ha un fidanzato di colore, la moglie che ha una relazione con l’amico del cuore e la classica ex fidanzatina perbene che si scopre escort di lusso. Nonostante i soliti inciampi e le lungaggini, La strada di casa ha l’intelligenza di guardarsi intorno, percepire i cambiamenti imposti al genere da una fiction innovativa come True Detective e riportare tutto in un contesto italiano, evitando le solite ambientazioni meridionali (che in qualche modo sono lo stereotipo dello stereotipo della nostra fiction). Mentre il personaggio di Boni ricostruisce i buchi della sua memoria (e fa avanzare il plot giallo), noi ricostruiamo con lui, muovendoci in uno spazio/tempo dal sapore algoritmico, con indosso abiti identitari scelti a seconda della comodità e delle convenienze; un andirivieni in avanti e indietro nei luoghi della memoria, una memoria più immaginaria che vissuta: questo credo sia il sale del nuovo giallo del dopo True Detective; non più maniaci massacratori di corpi, ma indagini sul nostro io, il nostro passato, un riappropriarsi di quel che siamo stati, siamo e forse non saremo più.
Su questa strada (in modo blando, politicamente corretto, senza troppi scossoni per le coronarie di un pubblico generalista che forse non esiste nemmeno), credo si sia incamminata una serie come La strada di casa (RaiUno, 2017) diretto da Riccardo Donna (già regista del bellissimo sceneggiato Nebbie e delitti, anche quello prodotto da Luca Barbareschi); il cast, azzeccato, vede un ottimo Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere e un Sergio Rubini in stato di grazia. La strada di casa è sicuramente una fiction pensata e ideata nel dopo True Detective. Come quella americana lavora sulla frammentazione del tempo, assumendo l’amnesia (il lungo coma del personaggio di Boni, grosso allevatore di bovini da qualche parte nella Padana superiore, in un contesto agricolo e naturale che ricorda le paludi stigie in cui si aggirano Matthew McConaughey e Woody Harrelson) come una metafora dell’uomo contemporaneo, digitalizzato e frazionato da un mondo in continuo movimento, dominato da un capitalismo invisibile e ubiquo che tutto strozza e stritola (in particolare i piccoli commercianti, i bottegai, i contadini, figure di artigiani che sopravvivono alle nuove regole di un mercato globalizzato). Certo, la parte “gialla” della Strada di casa è annacquata da un certo contesto melodrammatico alquanto banale e noioso, con la solita tiritera della famiglia italiana, polarizzata dal solito padre padrone che pensa quel che è bene per tutti; oltre al padre padrone abbiamo il catalogo completo di banalità, col figlio che vuole affrancarsi facendo birra artigianale, la figlia che voleva studiare medicina e ha un fidanzato di colore, la moglie che ha una relazione con l’amico del cuore e la classica ex fidanzatina perbene che si scopre escort di lusso. Nonostante i soliti inciampi e le lungaggini, La strada di casa ha l’intelligenza di guardarsi intorno, percepire i cambiamenti imposti al genere da una fiction innovativa come True Detective e riportare tutto in un contesto italiano, evitando le solite ambientazioni meridionali (che in qualche modo sono lo stereotipo dello stereotipo della nostra fiction). Mentre il personaggio di Boni ricostruisce i buchi della sua memoria (e fa avanzare il plot giallo), noi ricostruiamo con lui, muovendoci in uno spazio/tempo dal sapore algoritmico, con indosso abiti identitari scelti a seconda della comodità e delle convenienze; un andirivieni in avanti e indietro nei luoghi della memoria, una memoria più immaginaria che vissuta: questo credo sia il sale del nuovo giallo del dopo True Detective; non più maniaci massacratori di corpi, ma indagini sul nostro io, il nostro passato, un riappropriarsi di quel che siamo stati, siamo e forse non saremo più.
 L’indagine di questi nuovi gialli sembra maggiormente affascinata dal costruire, quasi un labirinto testuale di fatti possibili, verosimili, ipotesi, verità e mondi alternativi paralleli al nostro, una snocciolatura di alternative, perché la soluzione degli enigmi non scioglie la possibilità che i peccati nascosti siano molti e che lo snodo narrativo avrebbe potuto prendere mille altri sentieri… Dietro queste amnesie, questi oblii c’è la causa di una società frammentata e sempre più veloce. L’amnesia narrativa di queste fiction e di questa narrativa è connessa alla biologia stravolta della veglia e del sonno: in questi ultimi venti anni, allo spazio-tempo dei corpi, s’è aggiunto uno spazio-tempo virtuale regolato da logiche identitarie diverse che hanno introdotto dissociazioni identitarie radicali e permanenti. Lo spazio, il tempo e la velocità del mondo virtuale sono al servizio di un potere economico colonizzante e totalizzante di cui sembriamo cavie per un inquietante esperimento a cui nessuno si sottrae. Ognuno di noi, entrando nel continente virtuale dei social, stravolge la trama del proprio vissuto quotidiano, sperimentando una sorta di dissociazione identitaria non dissimile da quella descritta in tanti romanzi psycho-thriller. Ciò che è vero nel mondo reale può non esserlo nella rete e viceversa. Nel web abbiamo altre identità, parliamo in modi diverso, ci sentiamo fintamente liberati dai pudori della luce del giorno, sottratti agli sguardi degli altri; nell’illusione di essere liberi da qualunque controllo (dal nostro vissuto biografico) o coercizione delle nostre scelte (economiche e politiche), ci muoviamo in community virtuali che ci liberano dal peso e dalle difficoltà di avere rapporti faccia a faccia, lontani dall’attrito dei corpi e dalle fatiche relazionali con persone reali che ci portano a costruire immagini di noi stessi che spesso vanno al di là di ciò che siamo veramente (pensiamo alle interazioni sessuali su chat come Badoo, non luogo per eccellenza del thrilling odierno). Anche la consapevolezza che abbiamo di noi si alleggerisce, svanendo poco alla volta, inghiottita da un oblio online fatto di maschere e finte identità. Ecco allora che la frammentazione narrativa imposta da molte fiction attuali trova una sua spiegazione in una società e in una realtà sempre più dominata da web company ubique, caleidoscopici contenitori di freddi algoritmi e fantasmi di desideri reali e immaginari, pulsioni profonde…
L’indagine di questi nuovi gialli sembra maggiormente affascinata dal costruire, quasi un labirinto testuale di fatti possibili, verosimili, ipotesi, verità e mondi alternativi paralleli al nostro, una snocciolatura di alternative, perché la soluzione degli enigmi non scioglie la possibilità che i peccati nascosti siano molti e che lo snodo narrativo avrebbe potuto prendere mille altri sentieri… Dietro queste amnesie, questi oblii c’è la causa di una società frammentata e sempre più veloce. L’amnesia narrativa di queste fiction e di questa narrativa è connessa alla biologia stravolta della veglia e del sonno: in questi ultimi venti anni, allo spazio-tempo dei corpi, s’è aggiunto uno spazio-tempo virtuale regolato da logiche identitarie diverse che hanno introdotto dissociazioni identitarie radicali e permanenti. Lo spazio, il tempo e la velocità del mondo virtuale sono al servizio di un potere economico colonizzante e totalizzante di cui sembriamo cavie per un inquietante esperimento a cui nessuno si sottrae. Ognuno di noi, entrando nel continente virtuale dei social, stravolge la trama del proprio vissuto quotidiano, sperimentando una sorta di dissociazione identitaria non dissimile da quella descritta in tanti romanzi psycho-thriller. Ciò che è vero nel mondo reale può non esserlo nella rete e viceversa. Nel web abbiamo altre identità, parliamo in modi diverso, ci sentiamo fintamente liberati dai pudori della luce del giorno, sottratti agli sguardi degli altri; nell’illusione di essere liberi da qualunque controllo (dal nostro vissuto biografico) o coercizione delle nostre scelte (economiche e politiche), ci muoviamo in community virtuali che ci liberano dal peso e dalle difficoltà di avere rapporti faccia a faccia, lontani dall’attrito dei corpi e dalle fatiche relazionali con persone reali che ci portano a costruire immagini di noi stessi che spesso vanno al di là di ciò che siamo veramente (pensiamo alle interazioni sessuali su chat come Badoo, non luogo per eccellenza del thrilling odierno). Anche la consapevolezza che abbiamo di noi si alleggerisce, svanendo poco alla volta, inghiottita da un oblio online fatto di maschere e finte identità. Ecco allora che la frammentazione narrativa imposta da molte fiction attuali trova una sua spiegazione in una società e in una realtà sempre più dominata da web company ubique, caleidoscopici contenitori di freddi algoritmi e fantasmi di desideri reali e immaginari, pulsioni profonde…
 Meno polifonica la serie Non uccidere, andata in onda su RaiTre tra il 2015 e il 2018; qui siamo in presenza di una fiction classica nell’impostazione delle storie (dei bei piccoli gialli con certe venature thrilling ambientati a Torino e dintorni), impreziosita da un’atmosfera cupa e plumbea, una malinconia di fondo e la figura negativa del commissario Valeria Ferro, interpretata da una sofferta e brava Miriam Leone, quasi una variante femminile del Rustin Cole di True Detective 1.
Meno polifonica la serie Non uccidere, andata in onda su RaiTre tra il 2015 e il 2018; qui siamo in presenza di una fiction classica nell’impostazione delle storie (dei bei piccoli gialli con certe venature thrilling ambientati a Torino e dintorni), impreziosita da un’atmosfera cupa e plumbea, una malinconia di fondo e la figura negativa del commissario Valeria Ferro, interpretata da una sofferta e brava Miriam Leone, quasi una variante femminile del Rustin Cole di True Detective 1.
Mentre ero via è una serie trasmessa nel marzo del 2019 su Rai1. Alla sceneggiatura c’è quel maneggione di Ivan Cotroneo e c’è poco altro da dire: i difetti sono sempre quelli delle fiction italiane, ossia sei lunghe puntate in cui il plot giallo (qui davvero poco intrigante, quasi un complotto aziendale di cui poco frega) è annacquato dalle solite tiritere melodrammatiche: figlie anoressiche che prima odiano la madre e poi la amano, figli bambini mezzi geni che frequentano scuole 3.0 che farebbero la gioia della famiglia Renzi (tanto da far pensare che Agnese Renzi è assurta al ruolo di Ministro dell’Istruzione; in una scena in cui il figlio piccolo della Puccini frequenta un istituto privato per la classe dirigente del futuro, si vede il bambino mentre ascolta la maestra che gli legge la pagella, una sorta di lettera – si chiama valutazione dialogica – in cui non ci sono più voti e si cerca di raccontare l’alunno a tutto tondo, privilegiando qualunque cosa possa servire a dire tutto senza dire niente, soprattutto evitando quei brutti “4” classisti della scuola di una volta…), famiglie della Verona bene, gente che fa aperitivi in piazze bellissime, va in barca a vela, sfoggia bei vestiti, ecc. Mentre ero via sembra quasi un romanzo del miglior Romolo Bugaro (per chi non sa chi è: il Breat Easton Ellis italiano, autore di un capolavoro come La buona e brava gente della nazione); gente coi soldi, belle ville, lavori da super manager che praticamente si alzano all’ora che vogliono, fanno quel cazzo che vogliono, ecc. Mentre ero via sembra il manifesto di un’Italia ruffiana e corrotta, di una nave alla deriva che continua a folleggiare, ostentare e non lavorare in attesa di schiantarsi sui ghiacci e sprofondare in qualche abisso. Ed è così. Eppure Mentre ero via è la fiction che più mi ha preso. Come? Merito di quel Michele Soavi cresciuto alla corte di Joe D’Amato, Lamberto Bava, Dario Argento. Quel Michele Soavi che già da molti anni aveva venduto il culo al mondo delle fiction, dirigendo obbrobri revisionisti o spudorate fiction dal sapore istituzional/religioso. Tuttavia, nel pieno di una maturità espressiva, Soavi non è del tutto svanito. 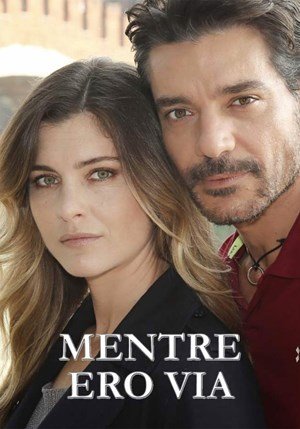 Il regista de La chiesa e La setta sembra cogliere quest’occasione per tornare a frequentare quel thrilling anni ’80 in cui è cresciuto e ha imparato il mestiere. Non è una questione di trama (Cotroneo non è certo un Carrisi e tantomeno un Fitzek), o di cast (comunque buono, a partire dalla Puccini e dal sempre valido Giuseppe Zeno), quanto di mera regia. Soavi è bravo e personale. Il suo modo di illuminare la villa notturna della casata protagonista della vicenda, le ombre delle inferriate e delle cancellate che scivolano lungo le facciate, i muri, i corridoi, le luci basse, certi carrelli nei corridoi, primi piani di oggetti, lo scivolare della mdp sui pavimenti, certe luci e ancora i flashback (ancora una vicenda di amnesie, di uno spazio e un tempo che la protagonista deve riconquistare, di cui si deve riappropriare per riappropriarsi di sé) sul doppio col vestito rosso, tutti piccoli indizi dispersi nel corso della visione, scelte estetiche precise che potranno sfuggire a un pubblico generalista e distratto ma che comunque ci sono e sembrano un lungo omaggio, il bisogno di fare una sorta di personale rivisitazione (all’interno delle strutture narrative di oggi, lontane da certi eccessi e libertà del passato) di un cinema giallo e thrilling. In particolare Mentre ero via sembra un atto d’amore nei confronti di un gemello scomparso, di maestro interiorizzato e mai veramente eguagliato. Oggi Argento è morto, inutile star lì. Soavi non ha la libertà per spingersi oltre le colonne d’Ercole, ma in questa fiction, lavorando su un materiale noioso, una sorta di autobiografia di una società benestante di massa (persino mentre i personaggi camminano per strada i figuranti sembrano pescati da qualche quota ideale, una sorta di catalogo di una nuova Italia in cui il modello liberista e individualista di Tenebre ha trionfato da un pezzo, con la ragazza extracomunitaria bella e ripulita, anziani ancora in forma e senza un briciolo di grasso, bei ragazzi, belle ragazze e giusto la comparsata, alquanto finta e posticcia, di pseudo adolescenti problematici, forse soffocati dai troppi soldi accumulati in nero da mamma e papà) qualcosa rimane, per poco appare dinanzi agli occhi chiusi/spalancati della mente. Ecco, davvero il cuore è questo: Mentre ero via avviene nel medesimo universo diegetico di film come Tenebre o Phenomena. Gli anni ’80 sono collassati dentro Tangentopoli, la Prima Repubblica s’è sbriciolata nelle reclames di Berlusconi. La seconda repubblica ha cambiato tutto per non cambiare niente, il debito è aumentato, il numero di gente che lavora è diminuito, il nero ci sta soffocando. Eppure, se si gira per strada, l’Italia comunica tutto fuorché un paese allo sbando: la gente frequenta palestre, fa aperitivi, riempie ristoranti e località turistiche. I soldi ci sono ancora. Sommersi, nascosti, ereditati, fatti fruttare. Non so per quanto durerà: il futuro della mia generazione e di quelle a venire non c’è; non avremo una pensione adeguata, lavoreremo fino a schiattare sul posto di lavoro, il tutto per quattro lire. Mentre ero via ha una luce obliqua al suo interno; un qualcosa che avrebbe potuto essere e non è più stato; poco importa che la trama non sia più una lunga catena di delitti e non ci sia la mano guantata dell’assassino. La figura del killer nerovestito è sfumata in un presente fatto di suocere avvelenate, mogli ammazzate perché ci volevano lasciare, infermieri killer che uccidono per somministrare una loro personale cura al dolore, madri che ammazzano i propri figli, carabinieri che ammazzano una ragazza in una caserma e coprono tutto, o ancora dolcissimi ragazzi disabili inghiottiti e spariti da qualche parte a Roma. E intanto nuove categorie di lavoratori sfruttati dalle multinazionali digitali soffrono in silenzio e non arriveranno mai a fare la vita degli attori delle fiction. Del thrilling rimane un involucro e quell’involucro, fatto di volti e fantasmi, è Mentre ero via.
Il regista de La chiesa e La setta sembra cogliere quest’occasione per tornare a frequentare quel thrilling anni ’80 in cui è cresciuto e ha imparato il mestiere. Non è una questione di trama (Cotroneo non è certo un Carrisi e tantomeno un Fitzek), o di cast (comunque buono, a partire dalla Puccini e dal sempre valido Giuseppe Zeno), quanto di mera regia. Soavi è bravo e personale. Il suo modo di illuminare la villa notturna della casata protagonista della vicenda, le ombre delle inferriate e delle cancellate che scivolano lungo le facciate, i muri, i corridoi, le luci basse, certi carrelli nei corridoi, primi piani di oggetti, lo scivolare della mdp sui pavimenti, certe luci e ancora i flashback (ancora una vicenda di amnesie, di uno spazio e un tempo che la protagonista deve riconquistare, di cui si deve riappropriare per riappropriarsi di sé) sul doppio col vestito rosso, tutti piccoli indizi dispersi nel corso della visione, scelte estetiche precise che potranno sfuggire a un pubblico generalista e distratto ma che comunque ci sono e sembrano un lungo omaggio, il bisogno di fare una sorta di personale rivisitazione (all’interno delle strutture narrative di oggi, lontane da certi eccessi e libertà del passato) di un cinema giallo e thrilling. In particolare Mentre ero via sembra un atto d’amore nei confronti di un gemello scomparso, di maestro interiorizzato e mai veramente eguagliato. Oggi Argento è morto, inutile star lì. Soavi non ha la libertà per spingersi oltre le colonne d’Ercole, ma in questa fiction, lavorando su un materiale noioso, una sorta di autobiografia di una società benestante di massa (persino mentre i personaggi camminano per strada i figuranti sembrano pescati da qualche quota ideale, una sorta di catalogo di una nuova Italia in cui il modello liberista e individualista di Tenebre ha trionfato da un pezzo, con la ragazza extracomunitaria bella e ripulita, anziani ancora in forma e senza un briciolo di grasso, bei ragazzi, belle ragazze e giusto la comparsata, alquanto finta e posticcia, di pseudo adolescenti problematici, forse soffocati dai troppi soldi accumulati in nero da mamma e papà) qualcosa rimane, per poco appare dinanzi agli occhi chiusi/spalancati della mente. Ecco, davvero il cuore è questo: Mentre ero via avviene nel medesimo universo diegetico di film come Tenebre o Phenomena. Gli anni ’80 sono collassati dentro Tangentopoli, la Prima Repubblica s’è sbriciolata nelle reclames di Berlusconi. La seconda repubblica ha cambiato tutto per non cambiare niente, il debito è aumentato, il numero di gente che lavora è diminuito, il nero ci sta soffocando. Eppure, se si gira per strada, l’Italia comunica tutto fuorché un paese allo sbando: la gente frequenta palestre, fa aperitivi, riempie ristoranti e località turistiche. I soldi ci sono ancora. Sommersi, nascosti, ereditati, fatti fruttare. Non so per quanto durerà: il futuro della mia generazione e di quelle a venire non c’è; non avremo una pensione adeguata, lavoreremo fino a schiattare sul posto di lavoro, il tutto per quattro lire. Mentre ero via ha una luce obliqua al suo interno; un qualcosa che avrebbe potuto essere e non è più stato; poco importa che la trama non sia più una lunga catena di delitti e non ci sia la mano guantata dell’assassino. La figura del killer nerovestito è sfumata in un presente fatto di suocere avvelenate, mogli ammazzate perché ci volevano lasciare, infermieri killer che uccidono per somministrare una loro personale cura al dolore, madri che ammazzano i propri figli, carabinieri che ammazzano una ragazza in una caserma e coprono tutto, o ancora dolcissimi ragazzi disabili inghiottiti e spariti da qualche parte a Roma. E intanto nuove categorie di lavoratori sfruttati dalle multinazionali digitali soffrono in silenzio e non arriveranno mai a fare la vita degli attori delle fiction. Del thrilling rimane un involucro e quell’involucro, fatto di volti e fantasmi, è Mentre ero via.
Una considerazione: sul numero 1662 de il Venerdì di Repubblica, un bel servizio di Riccardo Staglianò sulla sede americana di Netflix, roccaforte del racconto digitale globalizzato. La sensazione che ne esce è di un fortino di manager, creativi e algoritmi perennemente alla caccia di ciò che piace alla gente. Netflix e queste serie Tv, come dice Carlo Verdone, sono belle ma non hanno un’anima; lo streaming da milioni di dollari è costruito sulle nostre abitudini infinitesimali di consumatori (non solo cosa guardiamo, quando lo guardiamo, in che punto abbiamo messo in pausa e per quanto tempo, ecc). Tutti, da Ryan Murphy e Scorsese si sono fatti conquistare dalle possibilità di Netflix, in un’indigestione digitale di contenuti costruiti a tavolino e per questo perfetti e scintillanti; di contro, un articolo su La Stampa del 25 gennaio 2020 spiegava che il palinsesto Rai, negli ultimi tre anni, è stato invaso da repliche, con un calo degli investimenti sui prodotti originali e un conseguente calo di ascolti, tanto che la Rai è l’unico editore (rispetto a Mediaset, Sky, La7, Discovery) col segno meno davanti. Ed è un peccato, perché, pur coi loro limiti, con certe stucchevoli banalità e luoghi comuni (il bisogno di incensare commissari, poliziotti, carabinieri, il bisogno istituzionale e dogmatico di riraccontare il passato, le bombe, le stragi, i personaggi politici, con uno spirito revisionista ed edulcorato), la fiction italiana, in particolare quella prodotta dalla Rai, è ancora un prodotto artigianale, l’ultimo rimasto direi, in qualche modo un estremo anelito, almeno in alcuni generi (nel giallo sicuramente, cominciato nei ’60 con quei meravigliosi sceneggiati, quasi teatro filmato, con attori dalle dizioni e dalle movenze perfette, su tutti penso a quel capolavoro formale che è stato il Nero Wolfe di Giuliana Berlinguer), di un certo modo di affrontare i generi…
 Certo, anche solo per guardare ai nostri cugini d’Oltralpe, serie come Le chalet, La mante o La forèt sembrano venire da un altro pianeta, tanto sono un prodotto di genere e basta, senza inutili spot educativi sulla famiglia, la patria e l’amore. La mante ad esempio, sembra un Cartaio argentiano (quindi già qualcosa di molto televisivo e piatto) incrociato con alcune derive anni ’70, i manichini, la mano guantata, i traumi famigliari… C’è lo zampino di Netflix e l’utenza è diversa da quella di prima serata Rai, però anche una serie come Le chalet, pur nei suoi limiti e nella sua noiosità, è uno slasher che incrocia Stephen King e Agatha Christie, ossia cose che farebbero venire un attacco alle coronarie degli amministratori delegati delle nostre reti generaliste.
Certo, anche solo per guardare ai nostri cugini d’Oltralpe, serie come Le chalet, La mante o La forèt sembrano venire da un altro pianeta, tanto sono un prodotto di genere e basta, senza inutili spot educativi sulla famiglia, la patria e l’amore. La mante ad esempio, sembra un Cartaio argentiano (quindi già qualcosa di molto televisivo e piatto) incrociato con alcune derive anni ’70, i manichini, la mano guantata, i traumi famigliari… C’è lo zampino di Netflix e l’utenza è diversa da quella di prima serata Rai, però anche una serie come Le chalet, pur nei suoi limiti e nella sua noiosità, è uno slasher che incrocia Stephen King e Agatha Christie, ossia cose che farebbero venire un attacco alle coronarie degli amministratori delegati delle nostre reti generaliste.































