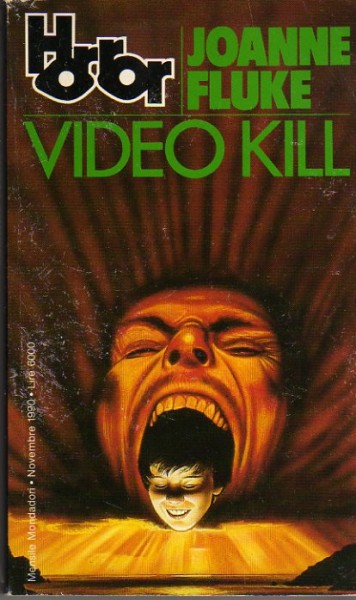 Video Kill è un romanzo psychothriller scritto Joanna Fluke nel 1989 e tradotto prontamente dalla Mondadori l’anno seguente, nella collana Horror curata da Giuseppe Lippi. Il romanzo ritraeva molto bene l’ambiente hollywoodiano coi suoi sceneggiatori, produttori, editor e aspiranti attrici. Un assassino seriale iniziava a filmare i suoi delitti, mettendoli in video e ricalcando quelli immaginati e scritti da una coppia di sceneggiatori. Il romanzo è fortemente debitore di Robert Bloch (penso soprattutto a Psycho 2, dove una serie di delitti sconvolgono il lavoro di una troupe impegnata a girare un film sulle gesta del folle Norman Bates) e sembra immaginare, in quei primi anni ’90, un cambio di passo del thriller.
Video Kill è un romanzo psychothriller scritto Joanna Fluke nel 1989 e tradotto prontamente dalla Mondadori l’anno seguente, nella collana Horror curata da Giuseppe Lippi. Il romanzo ritraeva molto bene l’ambiente hollywoodiano coi suoi sceneggiatori, produttori, editor e aspiranti attrici. Un assassino seriale iniziava a filmare i suoi delitti, mettendoli in video e ricalcando quelli immaginati e scritti da una coppia di sceneggiatori. Il romanzo è fortemente debitore di Robert Bloch (penso soprattutto a Psycho 2, dove una serie di delitti sconvolgono il lavoro di una troupe impegnata a girare un film sulle gesta del folle Norman Bates) e sembra immaginare, in quei primi anni ’90, un cambio di passo del thriller.
Già Argento, in Opera (1987), aveva sentito il bisogno di riflettere sulle pulsioni di morte legate alla visione, al bisogno di spingersi oltre. Lo psycho-thriller (così come la letteratura true crime) ci fa immedesimare nelle vittime o nei carnefici, ci fa provare, all’ombra rassicurante delle nostre vite piccolo borghesi di massa, l’eterna ossessione per il male.
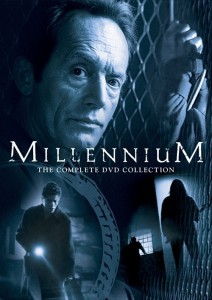 Altri killer (reali o immaginari) avrebbero provato a utilizzare e piegare le nuove tecnologie ai propri orribili scopi. Penso a due puntate fulminanti di Millennium (la serie TV creata da Chris Carter, quello degli X-Files), andate in onda verso la fine degli anni ‘90: una si intitolava Il killer di internet e immaginava uno Zodiac reincarnato (lo sceneggiatore Michael Perry l’aveva chiamato però Avatar) utilizzare internet per adescare e filmare il martirio delle sue vittime (Argento avrebbe rifatto la medesima cosa qualche anno dopo col suo techno Cartaio). In un’altra puntata della terza e ultima serie, Il maniaco dell’horror, il profiler Frank Black (sempre l’ottimo e allucinato Lance Henriksen) avrebbe dovuto fermare i delitti di un misterioso killer nascosto tra la troupe di un film thriller di serie B.
Altri killer (reali o immaginari) avrebbero provato a utilizzare e piegare le nuove tecnologie ai propri orribili scopi. Penso a due puntate fulminanti di Millennium (la serie TV creata da Chris Carter, quello degli X-Files), andate in onda verso la fine degli anni ‘90: una si intitolava Il killer di internet e immaginava uno Zodiac reincarnato (lo sceneggiatore Michael Perry l’aveva chiamato però Avatar) utilizzare internet per adescare e filmare il martirio delle sue vittime (Argento avrebbe rifatto la medesima cosa qualche anno dopo col suo techno Cartaio). In un’altra puntata della terza e ultima serie, Il maniaco dell’horror, il profiler Frank Black (sempre l’ottimo e allucinato Lance Henriksen) avrebbe dovuto fermare i delitti di un misterioso killer nascosto tra la troupe di un film thriller di serie B.
Dinamiche simili in altri prodotti di quegli anni, penso al nostrano Fatal Frames di Al Festa, allo snuff di Roger Fratter in Anabolyzer, o agli americani Urban Legend final cut e al terzo capitolo della serie di Scream (quasi un rifacimento in grande della puntata di Millennium, con Lance Henriksen questa volta nella parte di un losco produttore di filmacci a un passo dallo snuff).
 Anche nella realtà gli assassini seriali hanno sentito la necessità di filmare o fotografare le proprie gesta. Un modo contemporaneo per immortalare qualcosa delle loro gesta. L’omicidio diventa così un feticcio, una merce, consumabile comodamente nelle visioni domestiche, replicabile all’infinito. Questa commistione di fiction e cronaca nera era già emersa nel caso di Zodiac, un assassino sadico e sessuale che iniziò ad uccidere nella baia di San Francisco dal 1968 e che non fu mai catturato. Alcuni sospettarono di un proiezionista cinematografico affascinato da certe pellicole di Lon Chaney, questo per via di un certo gusto cinefilo dimostrato dal maniaco in alcune delle sue numerose lettere alla polizia. Anche il BTK americano, nascosto sotto la rassicurante facciata di un fedele luterano, andò collezionando, nel corso della sua trentennale carriera omicida, numerose fotografie e disegni che ritraevano donne torturate, legate e messe in pose che ricalcavano le copertine pruriginose delle riviste poliziesche degli anni ’70. E che dire della mescolanza tra media e delitti, fin dal 1978, quando l’editorialista Jimmy Breslin aizzò David Berkowitz alla ripetizione dei suoi crimini scrivendo editoriali sul Figlio di Sam; il killer prese a scrivergli personalmente e finì per essere etero-diretto dai media, i quali continuarono a tener viva la storia per incrementare le vendite e a suggerirgli in quali quartieri di New York colpire.
Anche nella realtà gli assassini seriali hanno sentito la necessità di filmare o fotografare le proprie gesta. Un modo contemporaneo per immortalare qualcosa delle loro gesta. L’omicidio diventa così un feticcio, una merce, consumabile comodamente nelle visioni domestiche, replicabile all’infinito. Questa commistione di fiction e cronaca nera era già emersa nel caso di Zodiac, un assassino sadico e sessuale che iniziò ad uccidere nella baia di San Francisco dal 1968 e che non fu mai catturato. Alcuni sospettarono di un proiezionista cinematografico affascinato da certe pellicole di Lon Chaney, questo per via di un certo gusto cinefilo dimostrato dal maniaco in alcune delle sue numerose lettere alla polizia. Anche il BTK americano, nascosto sotto la rassicurante facciata di un fedele luterano, andò collezionando, nel corso della sua trentennale carriera omicida, numerose fotografie e disegni che ritraevano donne torturate, legate e messe in pose che ricalcavano le copertine pruriginose delle riviste poliziesche degli anni ’70. E che dire della mescolanza tra media e delitti, fin dal 1978, quando l’editorialista Jimmy Breslin aizzò David Berkowitz alla ripetizione dei suoi crimini scrivendo editoriali sul Figlio di Sam; il killer prese a scrivergli personalmente e finì per essere etero-diretto dai media, i quali continuarono a tener viva la storia per incrementare le vendite e a suggerirgli in quali quartieri di New York colpire.
Brevemente, anche da noi nel caso di via Poma, prese piede una pista del videotel (una sorta di primordio di internet), in quanto si sospettava che la vittima – Simonetta Cesaroni – avesse conosciuto il suo assassino on-line, tanto che un uomo, dopo l’omicidio, si vantò per la sua morte, utilizzando un nick name simile alle parole ritrovate scarabocchiate sulla scena del crimine.
 La lista di queste pulsioni oscure potrebbe essere lunga. Col tempo la letteratura thriller e quella true crime sembrano essersi fuse in un ibrido affascinante. Se la letteratura thriller di Robert Bloch ha disegnato perfettamente la lenta e inesorabile dissociazione della società capitalistica del XX secolo (coi vari killer dello zodiaco, gli strangolatori di Boston, la famiglia Manson o le gesta di Ed Gein, mutato sullo schermo in Norman Bates o nel reazionario Leatherface di Tobe Hooper), la letteratura successiva (della Fluke, di Thomas Harris col suo personaggio feticcio, lo psichiatra cannibale Hannibal; altri pochi nomi, Alice Blanchard, Michelle McNamara, la sempre necessaria Alda Teodorani) ne ha raccolto l’eredità, raccontando di un mondo in cui ormai la pulsione di uccidere è frammentata dentro ognuno di noi.
La lista di queste pulsioni oscure potrebbe essere lunga. Col tempo la letteratura thriller e quella true crime sembrano essersi fuse in un ibrido affascinante. Se la letteratura thriller di Robert Bloch ha disegnato perfettamente la lenta e inesorabile dissociazione della società capitalistica del XX secolo (coi vari killer dello zodiaco, gli strangolatori di Boston, la famiglia Manson o le gesta di Ed Gein, mutato sullo schermo in Norman Bates o nel reazionario Leatherface di Tobe Hooper), la letteratura successiva (della Fluke, di Thomas Harris col suo personaggio feticcio, lo psichiatra cannibale Hannibal; altri pochi nomi, Alice Blanchard, Michelle McNamara, la sempre necessaria Alda Teodorani) ne ha raccolto l’eredità, raccontando di un mondo in cui ormai la pulsione di uccidere è frammentata dentro ognuno di noi.
Ed ecco affacciarsi nuovi delitti, forse meno rituali e più banali, anonimi, ma per questo a noi vicinissimi. Non c’è più nessuno che “vede” il delitto, che entri nella testa dell’assassino. Cogne, Perugia, Erba, sono stati da noi in Italia non tanto un banco di prova per l’assassino o gli assassini (mai del tutto certi, visto che in ognuno di questi casi, ancora oggi, si sollevano dubbi e ripensamenti d’ogni genere), quanto un palcoscenico ideale per i nuovi protagonisti dello show business criminale: “criminologi con la verità in pugno che discettano dell’intero scibile umano, esperti di tecniche di laboratorio che in TV propugnano l’infallibilità di test genetici e affini” come scriveva acutamente Edoardo Montolli.
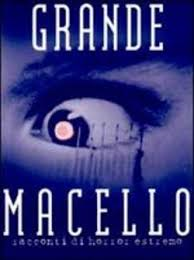 Questo marketing al massacro mi ricorda un bel Millelire di Stampa Alternativa distribuito nel mese di dicembre del 2000: Grande Macello – Racconti di horror estremo, un cantiere di scritture che giravano attorno al reality del Grande Fratello. In quel delizioso librettino la morte in diretta si fondava sul voyeurismo dello spettatore, attirato dall’idea di spiare dal buco della serratura un gruppo di persone alle prese con un vero e proprio gioco al massacro. Un internet claustrofobico in cui la finzione finge di essere realtà e viceversa, secondo le esigenze di un marketing cucito su misura. Idea estrema simile a quella proposta dal multiple name Franz Krieg (Marco Minicangeli) nel romanzo breve Spotkiller (Datanews 1997): qui la figura del muss murderer si trasforma in un assassino collegato ai marchi commerciali, ai loghi, così da portare alle estreme conseguenze l’idea che ogni bisogno umano può trasformarsi in una domanda e in un’offerta.
Questo marketing al massacro mi ricorda un bel Millelire di Stampa Alternativa distribuito nel mese di dicembre del 2000: Grande Macello – Racconti di horror estremo, un cantiere di scritture che giravano attorno al reality del Grande Fratello. In quel delizioso librettino la morte in diretta si fondava sul voyeurismo dello spettatore, attirato dall’idea di spiare dal buco della serratura un gruppo di persone alle prese con un vero e proprio gioco al massacro. Un internet claustrofobico in cui la finzione finge di essere realtà e viceversa, secondo le esigenze di un marketing cucito su misura. Idea estrema simile a quella proposta dal multiple name Franz Krieg (Marco Minicangeli) nel romanzo breve Spotkiller (Datanews 1997): qui la figura del muss murderer si trasforma in un assassino collegato ai marchi commerciali, ai loghi, così da portare alle estreme conseguenze l’idea che ogni bisogno umano può trasformarsi in una domanda e in un’offerta.
Finzione e realtà, dunque, diventano un unico palco per imbastire docu-fiction digitali, contenitori seriali per la nuova narrazione smaterializzata di Netflix, un colosso della distribuzione che è entrato nei contenuti e con dati e tabelle alla mano cerca di costruire l’algoritmo perfetto della narrazione seriale. Una forma di racconto infinito che deve blandirci, tenerci sulle spine, perennemente insoddisfatti, pronti a continuare a consumare e a rimanere online, collegati, agganciati ai bisogni primari delle vendite. Netflix (e poi le piattaforme della Disney, Amazon, Apple, Sky Studios e via in una sarabanda infinita di streaming) vende una bulimia, un’autofagia della visione che non si arresta mai. H24. Certo siamo lontani dal corpse fucking art di Jorg Buttgereit o dal mondo sublunare e ultragore dei vari Andreas Schnaas. 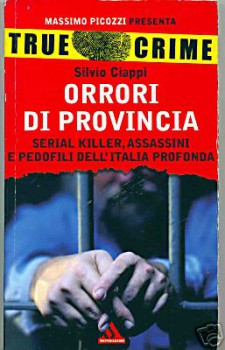 La morte è un meta-dato nei forzieri di Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon, MySpace e non è più un serial killer ad opprimerci e sopprimerci con la sua videocamera. Ora la sorveglianza totalitaria ci riduce tutti a potenziali vittime/consumatori esposte su un monitor.
La morte è un meta-dato nei forzieri di Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon, MySpace e non è più un serial killer ad opprimerci e sopprimerci con la sua videocamera. Ora la sorveglianza totalitaria ci riduce tutti a potenziali vittime/consumatori esposte su un monitor.
La morte correva sul video, si sarebbe detto negli anni ‘90. Oggi corre dappertutto, sui computer, cellulari, smartphone, in un caleidoscopio digitale che mira a individui isolati, senza legami famigliari, in un’uniformità eterogenea di solitudini e metadati. Si modificano dunque anche i crimini, le intolleranze e i divieti. Non più rituali, cose strane, pazzi maniaci, bensì una borghesizzazione del delitto (ne parlava compiutamente Silvio Ciappi in Orrori di provincia, un libretto bellissimo di alcuni anni fa uscito in edicola per Mondadori) dove sogno, mito e follia mentale si attorcigliano in un’omologazione e un conformismo da cui solo col delitto sembra possibile evadere. Effetto neve…






























