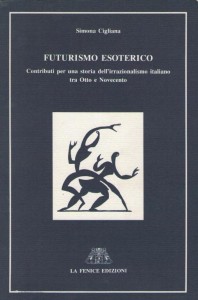Un po’ di tempo fa, per la Zona, ho scritto un articolo che coniugava il thrilling italiano col gotico e ho parlato di alcune pellicole nostrane degli anni ‘60 e ‘70. Segnalo ora alcuni thriller gotici (italiani e non) che si rifanno a certe atmosfere settecentesche/ottocentesche impregnate di magnetismi, ipnotismi, sedute spiritiche, isteria e thrilling.
Un po’ di tempo fa, per la Zona, ho scritto un articolo che coniugava il thrilling italiano col gotico e ho parlato di alcune pellicole nostrane degli anni ‘60 e ‘70. Segnalo ora alcuni thriller gotici (italiani e non) che si rifanno a certe atmosfere settecentesche/ottocentesche impregnate di magnetismi, ipnotismi, sedute spiritiche, isteria e thrilling.
Il primo è scritto da Tessa Harris e pubblicato nella gloriosa collana del “Giallo Mondadori”: Il respiro del diavolo, uscito nel marzo del 2016. Il libro è incentrato sulla figura di un anatomista inglese, Thomas Silkstone, protagonista d’una serie di romanzi di questa scrittrice laureata in Storia alla Oxford University. Credo sia il primo romanzo della serie tradotto in italiano e spero ne seguano altri. Con solo 5,90 euro è possibile acquistare un interessante thrilling ambientato nell’anno del Signore del 1783 e ambientato in alcuni villaggi attorno alla capitale inglese; una nebbia apocalittica sembra calata sulla campagna e un misterioso assassino ne approfitta per spaccare la testa a colpi di vanga ad alcuni bambini. La Harris, senza stupirci più di tanto nel plot, ha il merito di ricostruire bene le ambientazioni e di rifarsi a un disastro naturale provocato dall’eruzione di un vulcano in Islanda. La scrittura è scorrevole e ritmata e i capitoli sono brevi, senza fronzoli o riccioli inutili (leggi valanghe di psicologismi).
 Decisamente più impegnativo è il romanzo di Gianfranco Manfredi, Tecniche di resurrezione, uscito nel settembre del 2010 per i tipi della Gargoyle. Manfredi è uno che vuole stupire e stipa dentro i suoi libri ogni ben di Dio, col risultato di apparire verboso e troppo intellettuale. Già col precedente Ho freddo (romanzo storico di vampiri molto sui generis) la materia gli era sfuggita di mano e la seconda parte del libro stufava. Qui Manfredi appare più spigliato, armato d’un fraseggio breve, cinematografico. La materia è pura meraviglia d’inizio ‘800: si parla di Descartes e della ghiandola pineale, di Napoleone (che appare fugacemente in alcune scene) e ciò che resta della Rivoluzione francese, di autopsie, teatri anatomici, ladri di cadaveri, antico Egitto, tecniche di imbalsamazione e di un serial killer che pare uscito da un fumetto di Alan Moore e ama sezionare le sue vittime. Inoltre la trama ondeggia tra la Francia e l’Inghilterra, due nazioni che si contendono le sorti dell’Europa e, sotto le grandi manovre militari, vedono covare sette segrete, massoneria e interessi al di sopra delle parti come galvanismo, mesmerismo, spiritismo e una mummia impotente e sadica degna del peggior pornofumetto degli anni ‘70. Inoltre la prima parte del romanzo, quella incentrata sui delitti del folle maniaco, è un puro thrilling inquietante e morboso, non lontano dalle atmosfere di film come La lama nel corpo. Insomma, Manfredi si conferma uno dei migliori scrittori italiani (di genere), dotato d’una fantasia scatenata e colta. Io lo preferisco di parecchio a gente come Stephen King (scarsino nei finali e troppo logorroico) o Danilo Arona (bravo negli spunti, più banale negli svolgimenti).
Decisamente più impegnativo è il romanzo di Gianfranco Manfredi, Tecniche di resurrezione, uscito nel settembre del 2010 per i tipi della Gargoyle. Manfredi è uno che vuole stupire e stipa dentro i suoi libri ogni ben di Dio, col risultato di apparire verboso e troppo intellettuale. Già col precedente Ho freddo (romanzo storico di vampiri molto sui generis) la materia gli era sfuggita di mano e la seconda parte del libro stufava. Qui Manfredi appare più spigliato, armato d’un fraseggio breve, cinematografico. La materia è pura meraviglia d’inizio ‘800: si parla di Descartes e della ghiandola pineale, di Napoleone (che appare fugacemente in alcune scene) e ciò che resta della Rivoluzione francese, di autopsie, teatri anatomici, ladri di cadaveri, antico Egitto, tecniche di imbalsamazione e di un serial killer che pare uscito da un fumetto di Alan Moore e ama sezionare le sue vittime. Inoltre la trama ondeggia tra la Francia e l’Inghilterra, due nazioni che si contendono le sorti dell’Europa e, sotto le grandi manovre militari, vedono covare sette segrete, massoneria e interessi al di sopra delle parti come galvanismo, mesmerismo, spiritismo e una mummia impotente e sadica degna del peggior pornofumetto degli anni ‘70. Inoltre la prima parte del romanzo, quella incentrata sui delitti del folle maniaco, è un puro thrilling inquietante e morboso, non lontano dalle atmosfere di film come La lama nel corpo. Insomma, Manfredi si conferma uno dei migliori scrittori italiani (di genere), dotato d’una fantasia scatenata e colta. Io lo preferisco di parecchio a gente come Stephen King (scarsino nei finali e troppo logorroico) o Danilo Arona (bravo negli spunti, più banale negli svolgimenti).
 Il terzo libro è Jack lo squartatore di Robert Bloch, scritto nel 1984 dal maestro americano e tradotto in italiano nel 1994 da Carlo Bordoni, anche prefatore per l’editore Bompiani. Bordoni ha perizia di farci notare come l’argomento del libro sia un’ossessione antica per Bloch; lo scrittore americano aveva già affrontato l’argomento del killer di prostitute in due racconti, uno del 1943 e l’altro del 1967, prima di tornarci sopra con un romanzo vero e proprio, summa storicamente e psicologicamente accurata delle ossessioni vittoriane dello scrittore americano. Bloch ricostruisce con perizia (ma senza ingolfare la lettura con un profluvio inutile di dettagli, errore comune al Manfredi) lo sfondo della Londra del XIX secolo e puntella il plot con una serie di colpi di scena e suspence tipici della sua arte. Bloch è uno scrittore da sempre attento alle figure degli psicopatici (Psycho su tutti), e trova terreno fertile nel florilegio di deduzioni, ipotesi e false piste fiorite attorno al macellaio di Whitechapel (un po’ come accadrà da noi col mostro di Firenze…). La città che ci descrive è buia, sporca, intasata di corpi ammassati, denutriti, sfilacciati da una stanchezza fisica, da lavori opprimenti; venditori ambulanti, stradaioli, facchini, macellai e puttane, sì, puttane dal miasma di tomba, sboccate e lunatiche, vomitate fuori da qualche pub postribolo da angiporto. Attorno una tenebra fitta, psicologica, adibita ad anticamera dell’inferno. Un mostro con berretto da cacciatore e coltello estirpa uteri e smembra i corpi con sapienza medica. Via via che ci si immerge nel limo delle pagine, Bloch ci presenta una sfilza di camici bianchi (è la professione medica ad essere la vera protagonista del romanzo) al lavoro su corpi gonfi appesi a tavole di legno e imbevuti di formaldeide. La psicologia dei corpi è ancora acerba, se ne discute più per vezzo che reale convincimento. Bloch regredisce all’Ottocento delle incisioni d’appendice, ricostruisce il Royal Lyceum Theatre dove s’inscena il Dottor Jekyll e Mister Hyde e lascia scorrere la libido sanguinis per le strade illuminate da lampioni a gas. Varney il vampiro, Sweeney Todd e altri Dracula da feuilleton non possono competere con la brutalità “moderna” dello squartatore; nella sua follia c’è qualcosa di nuovo, di differente e Bloch lo capisce bene, adottando una scrittura nervosa, breve, ritmata da dialoghi secchi, diretti, senza troppi giri di parole. Ne risulta una lettura affascinante e ricca di particolari storici che non rallentano minimamente. Bloch gioca le sue carte migliori nella seconda parte de libro, quando fa apparire alcune “guest” come Conan Doyle, Oscar Wilde, Robert Lees (il medium spiritualista della Regina Vittoria, uno che riesce a percepire l’aura del mostro e la fiuta come un cane con l’osso!) e John Merrick, ossia l’uomo elefante, preso di peso dal film di Lynch (e non è l’unica strizzatine del nostro al cinema; in qualche modo l’autore convoglia nella scrittura un certo ritmo, contratto forse scrivendo le tante sceneggiature per la Amicus, oppure ispirandosi a film inaspettati come Jack the ripper di Jess Franco con Klaus Kinski, dal quale sembra ispirarsi per la figura di un medico russo costretto, per indigenza, a lavorare part-time nel retrobottega di un barbiere). Bloch insomma gioca con la sua ossessione e con le nostre e costruisce un romanzo d’appendice del XX secolo, una storia che pesca nel passato ma ha il nervosismo d’uno psychotriller da anni Ottanta (il libro esce in un periodo particolare per la letteratura americana, impregnata di serial killer e profiler scaturiti dalle opere di Thomas Harris e adepti) e che non lesina sui particolari più crudi della vicenda. Alla fine Bloch saprà dare una degna conclusione alla vicenda (cosa non scontata visto che gente prezzolata come King non azzecca un finale), dopo aver giocato con le piste “storiche” già utilizzate da altri (il medico della Regina? Il principe Eddie? Il pittore Sickert); il finale di Bloch darà un nome e un volto a Jack e sarà all’altezza del romanzo, regalando brividi da puro thrilling fino all’ultima, cruenta, pagina. Nel commiato, uno dei personaggi lascerà Londra per l’America, immaginando altri mostri in attesa nel buio, quasi una profezia di quel che sarebbe venuto. Un capolavoro!
Il terzo libro è Jack lo squartatore di Robert Bloch, scritto nel 1984 dal maestro americano e tradotto in italiano nel 1994 da Carlo Bordoni, anche prefatore per l’editore Bompiani. Bordoni ha perizia di farci notare come l’argomento del libro sia un’ossessione antica per Bloch; lo scrittore americano aveva già affrontato l’argomento del killer di prostitute in due racconti, uno del 1943 e l’altro del 1967, prima di tornarci sopra con un romanzo vero e proprio, summa storicamente e psicologicamente accurata delle ossessioni vittoriane dello scrittore americano. Bloch ricostruisce con perizia (ma senza ingolfare la lettura con un profluvio inutile di dettagli, errore comune al Manfredi) lo sfondo della Londra del XIX secolo e puntella il plot con una serie di colpi di scena e suspence tipici della sua arte. Bloch è uno scrittore da sempre attento alle figure degli psicopatici (Psycho su tutti), e trova terreno fertile nel florilegio di deduzioni, ipotesi e false piste fiorite attorno al macellaio di Whitechapel (un po’ come accadrà da noi col mostro di Firenze…). La città che ci descrive è buia, sporca, intasata di corpi ammassati, denutriti, sfilacciati da una stanchezza fisica, da lavori opprimenti; venditori ambulanti, stradaioli, facchini, macellai e puttane, sì, puttane dal miasma di tomba, sboccate e lunatiche, vomitate fuori da qualche pub postribolo da angiporto. Attorno una tenebra fitta, psicologica, adibita ad anticamera dell’inferno. Un mostro con berretto da cacciatore e coltello estirpa uteri e smembra i corpi con sapienza medica. Via via che ci si immerge nel limo delle pagine, Bloch ci presenta una sfilza di camici bianchi (è la professione medica ad essere la vera protagonista del romanzo) al lavoro su corpi gonfi appesi a tavole di legno e imbevuti di formaldeide. La psicologia dei corpi è ancora acerba, se ne discute più per vezzo che reale convincimento. Bloch regredisce all’Ottocento delle incisioni d’appendice, ricostruisce il Royal Lyceum Theatre dove s’inscena il Dottor Jekyll e Mister Hyde e lascia scorrere la libido sanguinis per le strade illuminate da lampioni a gas. Varney il vampiro, Sweeney Todd e altri Dracula da feuilleton non possono competere con la brutalità “moderna” dello squartatore; nella sua follia c’è qualcosa di nuovo, di differente e Bloch lo capisce bene, adottando una scrittura nervosa, breve, ritmata da dialoghi secchi, diretti, senza troppi giri di parole. Ne risulta una lettura affascinante e ricca di particolari storici che non rallentano minimamente. Bloch gioca le sue carte migliori nella seconda parte de libro, quando fa apparire alcune “guest” come Conan Doyle, Oscar Wilde, Robert Lees (il medium spiritualista della Regina Vittoria, uno che riesce a percepire l’aura del mostro e la fiuta come un cane con l’osso!) e John Merrick, ossia l’uomo elefante, preso di peso dal film di Lynch (e non è l’unica strizzatine del nostro al cinema; in qualche modo l’autore convoglia nella scrittura un certo ritmo, contratto forse scrivendo le tante sceneggiature per la Amicus, oppure ispirandosi a film inaspettati come Jack the ripper di Jess Franco con Klaus Kinski, dal quale sembra ispirarsi per la figura di un medico russo costretto, per indigenza, a lavorare part-time nel retrobottega di un barbiere). Bloch insomma gioca con la sua ossessione e con le nostre e costruisce un romanzo d’appendice del XX secolo, una storia che pesca nel passato ma ha il nervosismo d’uno psychotriller da anni Ottanta (il libro esce in un periodo particolare per la letteratura americana, impregnata di serial killer e profiler scaturiti dalle opere di Thomas Harris e adepti) e che non lesina sui particolari più crudi della vicenda. Alla fine Bloch saprà dare una degna conclusione alla vicenda (cosa non scontata visto che gente prezzolata come King non azzecca un finale), dopo aver giocato con le piste “storiche” già utilizzate da altri (il medico della Regina? Il principe Eddie? Il pittore Sickert); il finale di Bloch darà un nome e un volto a Jack e sarà all’altezza del romanzo, regalando brividi da puro thrilling fino all’ultima, cruenta, pagina. Nel commiato, uno dei personaggi lascerà Londra per l’America, immaginando altri mostri in attesa nel buio, quasi una profezia di quel che sarebbe venuto. Un capolavoro!
 L’atlante criminale di Luigi Guarnirei, edito dalla Bur nel 2000 e ristampato nel 2007 in economica. Per la verità non si tratta di un romanzo, visto che saremmo davanti a una monografia letteraria sulla vita di Cesare Lombroso, ciò nondimeno Guarnirei, nella bella prefazione alla riedizione, ha cura di spiegare l’opera come una forma di identificazione inconscia col personaggio lugubre del Lombroso. Guarnirei, qui alla sua opera prima, ingurgita tonnellate di carte e ricostruisce con sapienza quel mondo ottocentesco diviso tra scienza & occulto, tra positivismo e spiritismo. Lombroso, lo dico da subito, ne esce malissimo nonostante gli sforzi del Guarnirei: esso è personaggio inumano (per questo ho usato il pronome “esso” e non “egli”), uno che gioca coi poveri dementi e fa cose turpi sui cadaveri solo per vezzi scientifici oggi ridicoli. L’intera opera scientifica di Lombroso è farraginosa, inutile, superata; pure Guarnirei ha il genio di intuirne la straordinaria sagoma letteraria, da personaggio d’un cupo feuilleton scapigliato. Ecco allora che la prosa della monografia somiglia a quella del fosco milieu lombrosiano e s’infiltra tra le pagine sinistre dello “scienziato” grafomane, autore di articoli, saggi deliranti. E’ un profluvio di memorie sulle amputazioni, sulle orine degli alienati e patemi per la ricerca di un posto fisso nella placenta dello Stato, di una sicurezza economica. Come uomo il Lombroso è una schifezza: si sposa per grazia ricevuta non certo con una Belen, è un padre a dir poco singolare, un marito distratto, un medico sui generis e i suoi lavori suscitano il riso unanime dei colleghi. Lombroso intravede in sé il genio, perché cerca i segni delle malattie mentali nel peso, l’altezza e la fisionomia dei pazienti alienati. Cerca pezze d’appoggio nell’azione delle meteore sulla mente umana e sperimenta nuovi metodi di cura, che da soli gli meriterebbero l’oblio o la riesumazione della salma a fini oltraggiosi e derisori. Lombroso è il dark side of the medicina ottocentesca, pazzo tra i pazzi, armato d’un punto di vista scientifico nullo e guasto, aggravato dalla grafomania dilagante dell’autore, uno al cui confronto Stephen King è un autore parco e stitico. I saggi di Lombroso sono monumenti patologici e fluviali d’una mente piagata dalle ossessioni maniacali per i lobuli atrofici o ipertrofici degli onanisti strangolatori. Esso diviene direttore di manicomi e può così giocare a fare il Caligari con stormi di neuropatici feroci e sanguinari, attinti da una ebbrezza spermatica curabile a colpi di idroterapia, clinoterapia, ergoterapia, poltrone rotatorie, cure organiche o strumenti originali – inventati dal Lombroso medesimo – come il sitoforo, sorta di bavaglio di latta per l’alimentazione forzata dei lunatici; a fine lettura ci appare nella luce accesa d’un naturalista esotico da romanzo salgariano, preso dalla smania di delimitare, definire, descrivere l’atlante criminale umano, alla ricerca d’un Graal per salvare la specie dall’ala teratologia dei mostri. Lombroso dunque diventa, coi suoi scritti confusionari e letterari, una sorta di saggista scapigliato, un tardoromantico d’appendice che mescola il romanzo nero, il patetico, il melodramma ai cocci d’uno sperimentalismo solo nominalmente scientifico. Finirà anche per lui, col suo corpo donato alla scienza (quale?), scannato e ridotto a scheletro, con la testa e il cervello bacato dentro barattoli di formalina, il tutto sepolto nei corridoi bui di un museo antropologico torinese a lui dedicato, per anni chiuso, oggi riaperto erroneamente. Uomo da dimenticare, libro da comprare, leggere e rileggere.
L’atlante criminale di Luigi Guarnirei, edito dalla Bur nel 2000 e ristampato nel 2007 in economica. Per la verità non si tratta di un romanzo, visto che saremmo davanti a una monografia letteraria sulla vita di Cesare Lombroso, ciò nondimeno Guarnirei, nella bella prefazione alla riedizione, ha cura di spiegare l’opera come una forma di identificazione inconscia col personaggio lugubre del Lombroso. Guarnirei, qui alla sua opera prima, ingurgita tonnellate di carte e ricostruisce con sapienza quel mondo ottocentesco diviso tra scienza & occulto, tra positivismo e spiritismo. Lombroso, lo dico da subito, ne esce malissimo nonostante gli sforzi del Guarnirei: esso è personaggio inumano (per questo ho usato il pronome “esso” e non “egli”), uno che gioca coi poveri dementi e fa cose turpi sui cadaveri solo per vezzi scientifici oggi ridicoli. L’intera opera scientifica di Lombroso è farraginosa, inutile, superata; pure Guarnirei ha il genio di intuirne la straordinaria sagoma letteraria, da personaggio d’un cupo feuilleton scapigliato. Ecco allora che la prosa della monografia somiglia a quella del fosco milieu lombrosiano e s’infiltra tra le pagine sinistre dello “scienziato” grafomane, autore di articoli, saggi deliranti. E’ un profluvio di memorie sulle amputazioni, sulle orine degli alienati e patemi per la ricerca di un posto fisso nella placenta dello Stato, di una sicurezza economica. Come uomo il Lombroso è una schifezza: si sposa per grazia ricevuta non certo con una Belen, è un padre a dir poco singolare, un marito distratto, un medico sui generis e i suoi lavori suscitano il riso unanime dei colleghi. Lombroso intravede in sé il genio, perché cerca i segni delle malattie mentali nel peso, l’altezza e la fisionomia dei pazienti alienati. Cerca pezze d’appoggio nell’azione delle meteore sulla mente umana e sperimenta nuovi metodi di cura, che da soli gli meriterebbero l’oblio o la riesumazione della salma a fini oltraggiosi e derisori. Lombroso è il dark side of the medicina ottocentesca, pazzo tra i pazzi, armato d’un punto di vista scientifico nullo e guasto, aggravato dalla grafomania dilagante dell’autore, uno al cui confronto Stephen King è un autore parco e stitico. I saggi di Lombroso sono monumenti patologici e fluviali d’una mente piagata dalle ossessioni maniacali per i lobuli atrofici o ipertrofici degli onanisti strangolatori. Esso diviene direttore di manicomi e può così giocare a fare il Caligari con stormi di neuropatici feroci e sanguinari, attinti da una ebbrezza spermatica curabile a colpi di idroterapia, clinoterapia, ergoterapia, poltrone rotatorie, cure organiche o strumenti originali – inventati dal Lombroso medesimo – come il sitoforo, sorta di bavaglio di latta per l’alimentazione forzata dei lunatici; a fine lettura ci appare nella luce accesa d’un naturalista esotico da romanzo salgariano, preso dalla smania di delimitare, definire, descrivere l’atlante criminale umano, alla ricerca d’un Graal per salvare la specie dall’ala teratologia dei mostri. Lombroso dunque diventa, coi suoi scritti confusionari e letterari, una sorta di saggista scapigliato, un tardoromantico d’appendice che mescola il romanzo nero, il patetico, il melodramma ai cocci d’uno sperimentalismo solo nominalmente scientifico. Finirà anche per lui, col suo corpo donato alla scienza (quale?), scannato e ridotto a scheletro, con la testa e il cervello bacato dentro barattoli di formalina, il tutto sepolto nei corridoi bui di un museo antropologico torinese a lui dedicato, per anni chiuso, oggi riaperto erroneamente. Uomo da dimenticare, libro da comprare, leggere e rileggere.
Era il 2005, giugno, estate.
Ricordo che pioveva, era brutto.
Sono uscito con la Lancia Dedra verde biscia per andare al franchising Mondadori gestito da due fratelli poi falliti miseramente. Dovevo comprare un libro appena uscito dai torchi della Mondadori, un romanzo di Luca Di Fulvio, quello che aveva scritto per la Mursia L’impagliatore, da cui avevano tratto un film thrilling che tanto m’era piaciuto. L’impagliatore, come romanzo m’era parso meno avvincente, con la balzana idea dell’autore di far scoprire (a differenza del film) l’assassino a metà libro. Comunque Di Fulvio scriveva bene (almeno per i miei standard dell’epoca) e del nuovo romanzo avevo sentito parlare sulla Repubblica. Era un giallo storico, ambientato nel 1899. La cosa cadeva a fagiolo, perché all’epoca avevo appena cominciato a scrivere e volevo cimentarmi in un thriller ottocentesco da ambientare a Vercelli.
 Il libro lo iniziai, poi mi fermai, lasciai perdere e da allora ci torno spesso sopra con la mente. Di Di Fulvio invece mi sono dimenticato e così di quel romanzo, La scala di Dioniso, un bel cartonato della Mondadori, con una copertina rosso sangue. Non mi piacque, questo lo ricordo. Ho deciso di rileggerlo, andando a riesumarlo tra le file di libri della mia biblioteca. Ora La scala è esaurito, disponibile solo come e-book. In quegli anni, Di Fulvio era uno scrittore di thrilling e ne aveva già sfornati tre. La scala era uscito nella collana “Colorado Noir” e doveva diventare un film di Gabriele Salvatores. Cosa centrasse un regista così con questo libro non lo capisco proprio. Comunque Di Fulvio è uno del giro romano del cinema e nei ringraziamenti, oltre ai soliti parenti, ringrazia gente da far accapponare la pelle. La simpatia umana tra me e lui è minima. Oltre a questo Di Fulvio ha una scrittura evocativa, mezza poetica, quel genere di scrittore alla Baricco che non dice un cazzo ma butta lì belle frasi cariche di pathos e sentimenti contrastanti, giusto per vedere l’effetto che fa. La scala avrebbe parecchie cose interessanti. Anzitutto la trama, con un assassino che maciulla donne e uomini di una borghesia senza scrupoli, azionisti di uno zuccherificio dentro al quale si ammassano plotoni di poveri operai morti di fame. Si parla anche dei primi vagiti di un socialismo rivoluzionario che con la parola “sciopero” vorrebbe sfasciare tutto. L’assassino è un socialista, o un seriale psicopatico che inscena delitti teatrali dentro ai quali cerca un riscatto umano impossibile? Di Fulvio costruisce bene i labirinti del suo killer, in modo simile a quanto aveva già fatto con quello de L’impagliatore e di Dover beach. Le indagini sono affidate a un ispettore eroinomane, simile all’ispettore Amalfi de L’impagliatore. Anche qui (come là) c’è una inutile, prevedibile, relazione amorosa tra l’ispettore e una ragazza che lavora in un tendone da fiera, assieme a vari fenomeni da baraccone. Di Fulvio ha agilità nel calare le sue carte narrative, infittendo le pagine di rimandi cinematografici: il baraccone da fiera, automi meccanici, un manicomio popolato di freak e focomelici, processioni di operai che avanzano nella sera; l’autore ha però una prosa troppo fluente e tende a ispessire la trama con cascate di psicologia da 4 $ (anche qui l’ispettore ha un trauma legato a un caso passato da lui risolto, insomma sotto molti aspetti La scala ricicla intuizioni dei libri precedenti) che contrastano con le velleità dello stile. La pecca maggiore è quella di aver voluto tirare alla lunga con un libro di quasi 500 pagine che non aggiunge nulla e avrebbe potuto durarne 200 e non fa altro che mettere in scena personaggi senza spessore, non dissimili da qualunque Racconto di Dracula o schifezza scritta da me, solo che Di Fulvio pensa di differenziarsi con una scrittura allusiva che pesca nei processi identificativi spiccioli, con madri che praticano aborti, bambini nati e poi ripudiati che cercano di rinascere o di morire dentro siringhe eroinomani, o ragazzine abusate che diventano regine di nebbie, fumi soffiati sulle palpebre del lettore medio, che oggi è come dire dell’analfabeta medio, incantato – impagliato? – dalla copertina, dal marchio della casa editrice, da una recensione sui giornali con la faccia dell’autore gaudente, protetto dai soldi del benessere – insomma quel tipo di lettore medio beone che ero io nel 2005; per tornare alle 500 pagine, credo che sia sempre la solita solfa degli scrittori al soldo delle grandi case editrici, convinti sia la mole delle pagine a dare una certa autorevolezza al proprio lavoro, incuranti della folgorante lezione lasciataci da Beckett (o per dirla come si mangia da uno come Sclavi). A metà, come per L’impagliatore, l’autore ci svela chi è l’assassino, esaurendo quel poco di interesse che poteva rimanere, tanto che si leggono le ultime duecento pagine solo per espiare qualche colpa. Nonostante questo non voglio liquidare così seccamente un libro (e un autore) che, almeno nella prima parte, parte molto bene, e, tolta la figura banale dell’ispettore e della sua amata, ha il pregio di essere parecchio thrilling, con un assassino folle che persegue un piano di rinascita degno del miglior True Detective e squarta, sega, sviscera le sue vittime.
Il libro lo iniziai, poi mi fermai, lasciai perdere e da allora ci torno spesso sopra con la mente. Di Di Fulvio invece mi sono dimenticato e così di quel romanzo, La scala di Dioniso, un bel cartonato della Mondadori, con una copertina rosso sangue. Non mi piacque, questo lo ricordo. Ho deciso di rileggerlo, andando a riesumarlo tra le file di libri della mia biblioteca. Ora La scala è esaurito, disponibile solo come e-book. In quegli anni, Di Fulvio era uno scrittore di thrilling e ne aveva già sfornati tre. La scala era uscito nella collana “Colorado Noir” e doveva diventare un film di Gabriele Salvatores. Cosa centrasse un regista così con questo libro non lo capisco proprio. Comunque Di Fulvio è uno del giro romano del cinema e nei ringraziamenti, oltre ai soliti parenti, ringrazia gente da far accapponare la pelle. La simpatia umana tra me e lui è minima. Oltre a questo Di Fulvio ha una scrittura evocativa, mezza poetica, quel genere di scrittore alla Baricco che non dice un cazzo ma butta lì belle frasi cariche di pathos e sentimenti contrastanti, giusto per vedere l’effetto che fa. La scala avrebbe parecchie cose interessanti. Anzitutto la trama, con un assassino che maciulla donne e uomini di una borghesia senza scrupoli, azionisti di uno zuccherificio dentro al quale si ammassano plotoni di poveri operai morti di fame. Si parla anche dei primi vagiti di un socialismo rivoluzionario che con la parola “sciopero” vorrebbe sfasciare tutto. L’assassino è un socialista, o un seriale psicopatico che inscena delitti teatrali dentro ai quali cerca un riscatto umano impossibile? Di Fulvio costruisce bene i labirinti del suo killer, in modo simile a quanto aveva già fatto con quello de L’impagliatore e di Dover beach. Le indagini sono affidate a un ispettore eroinomane, simile all’ispettore Amalfi de L’impagliatore. Anche qui (come là) c’è una inutile, prevedibile, relazione amorosa tra l’ispettore e una ragazza che lavora in un tendone da fiera, assieme a vari fenomeni da baraccone. Di Fulvio ha agilità nel calare le sue carte narrative, infittendo le pagine di rimandi cinematografici: il baraccone da fiera, automi meccanici, un manicomio popolato di freak e focomelici, processioni di operai che avanzano nella sera; l’autore ha però una prosa troppo fluente e tende a ispessire la trama con cascate di psicologia da 4 $ (anche qui l’ispettore ha un trauma legato a un caso passato da lui risolto, insomma sotto molti aspetti La scala ricicla intuizioni dei libri precedenti) che contrastano con le velleità dello stile. La pecca maggiore è quella di aver voluto tirare alla lunga con un libro di quasi 500 pagine che non aggiunge nulla e avrebbe potuto durarne 200 e non fa altro che mettere in scena personaggi senza spessore, non dissimili da qualunque Racconto di Dracula o schifezza scritta da me, solo che Di Fulvio pensa di differenziarsi con una scrittura allusiva che pesca nei processi identificativi spiccioli, con madri che praticano aborti, bambini nati e poi ripudiati che cercano di rinascere o di morire dentro siringhe eroinomani, o ragazzine abusate che diventano regine di nebbie, fumi soffiati sulle palpebre del lettore medio, che oggi è come dire dell’analfabeta medio, incantato – impagliato? – dalla copertina, dal marchio della casa editrice, da una recensione sui giornali con la faccia dell’autore gaudente, protetto dai soldi del benessere – insomma quel tipo di lettore medio beone che ero io nel 2005; per tornare alle 500 pagine, credo che sia sempre la solita solfa degli scrittori al soldo delle grandi case editrici, convinti sia la mole delle pagine a dare una certa autorevolezza al proprio lavoro, incuranti della folgorante lezione lasciataci da Beckett (o per dirla come si mangia da uno come Sclavi). A metà, come per L’impagliatore, l’autore ci svela chi è l’assassino, esaurendo quel poco di interesse che poteva rimanere, tanto che si leggono le ultime duecento pagine solo per espiare qualche colpa. Nonostante questo non voglio liquidare così seccamente un libro (e un autore) che, almeno nella prima parte, parte molto bene, e, tolta la figura banale dell’ispettore e della sua amata, ha il pregio di essere parecchio thrilling, con un assassino folle che persegue un piano di rinascita degno del miglior True Detective e squarta, sega, sviscera le sue vittime.
Il tasso gore è elevato e proprio per questo continuo a chiedermi cosa ne avrebbe fatto quell’intellettuale - per i più – di Salvatores. Non lo sapremo mai, il libro credo sia stato un fiasco colossale, tanto da sparire dagli scaffali e spingere l’autore a scrivere storielle edificanti per adolescenti.
Segnalo in chiusura lo splendido saggio di Simona Cigliana, edito da Liguori Editore nel 2002, Futurismo esoterico, sulla weltanschauung esoterica di fine ‘800 e inizi del ‘900, chiave di lettura per molti fenomeni culturali di quel periodo. Non esente il futurismo, impregnato di metapsichica, occultismo, antroposofia e ricerche medianiche varie. Cigliana ricostruisce l’entusiasmo wagneriano dell’Europa magica, dando ampio spazio al lyceum della “voce” fiorentina, miscuglio perentorio di scritture irrazionalistiche e storiografia crociana.