 Un mio sogno sarebbe stato vedere raccolti in un volume Urania, serie cerchietto rosso del periodo Fruttero & Lucentini, i testi fantascientifici di Samuel Beckett. Fantascientifici? Sì, perché una delle direzioni meno studiate in Beckett è proprio la dimensione fantastica. Dimensione evidente e di non secondaria importanza all’interno della sua produzione in prosa.
Un mio sogno sarebbe stato vedere raccolti in un volume Urania, serie cerchietto rosso del periodo Fruttero & Lucentini, i testi fantascientifici di Samuel Beckett. Fantascientifici? Sì, perché una delle direzioni meno studiate in Beckett è proprio la dimensione fantastica. Dimensione evidente e di non secondaria importanza all’interno della sua produzione in prosa.
Tra il 1964 e il 1973, infatti, il drammaturgo di Godot scrive delle prose (alcune brevi, fulminanti, altre più lunghe ed elaborate) che non possono sentirsi estranee a una sensibilità di genere che mescola la scientificità (dei numeri, delle misurazioni) al fantastico puro dell’immaginazione.
In queste short proses sci-fi sono importanti i suoni (le descrizioni dei), gli odori (la percezione degli) e la vista, spesso deficitaria rispetto all’udito o al tatto.
 Il primo esperimento narrativo risale al 1964 col breve Tutto l’estraneo via, prosa difficoltosa, con una punteggiatura ridotta all’osso; è l’inizio dei luoghi chiusi, non luoghi bianchi, splendenti. Nel testo la luce si spegne e si riaccende con variazioni sensibili di temperatura; forse ci sono 2 personaggi, un lui e (i pezzi di) Emma, che lui violenta ripetutamente; infine i corpi cercano di combinarsi nel cubo luce, di coricarsi fianco a fianco, crogiolandosi nei brandelli di una felicità ridotta all’osso. Poi la terza persona ci informa che forse lei non è qui, è solo un prodotto della fantasia, perché la fantasia è speranza e la speranza, nel cubo luce, è morta (immagine).
Il primo esperimento narrativo risale al 1964 col breve Tutto l’estraneo via, prosa difficoltosa, con una punteggiatura ridotta all’osso; è l’inizio dei luoghi chiusi, non luoghi bianchi, splendenti. Nel testo la luce si spegne e si riaccende con variazioni sensibili di temperatura; forse ci sono 2 personaggi, un lui e (i pezzi di) Emma, che lui violenta ripetutamente; infine i corpi cercano di combinarsi nel cubo luce, di coricarsi fianco a fianco, crogiolandosi nei brandelli di una felicità ridotta all’osso. Poi la terza persona ci informa che forse lei non è qui, è solo un prodotto della fantasia, perché la fantasia è speranza e la speranza, nel cubo luce, è morta (immagine).
Con questo lavoro, Samuel Beckett si sposta dai limbi montani di alcune prose precedenti (penso a certi Testi per nulla) e immerge i suoi personaggi (non più psicologicamente definiti) in contenitori cubici, non luoghi sabbiosi, arene fantastiche o cornici (come la finestra del bellissimo testo La falesia).
 Con Immaginazione morta immagine (1966), l’autore aggiunge un tassello fondamentale all’universo originalissimo che va costruendo. Sempre terza persona e una punteggiatura minima. E’ quasi un seguito del lavoro precedente: isole di bianco totale, rotonde, 2 semicerchi, 2 figure, una femminile. Se ne stanno accovacciate e nude; la luce sale e scende e così la temperatura. Il passaggio dalla luce al buio, dal caldo al freddo, è l’unica cosa che accade, ma l’osservazione, in tutto quel bianco, è difficoltosa e la voce narrante sembra stancarsi, abbandonando l’immagine/immaginazione dei corpi e di quel che (non) fanno. Il testo s’interrompe bruscamente.
Con Immaginazione morta immagine (1966), l’autore aggiunge un tassello fondamentale all’universo originalissimo che va costruendo. Sempre terza persona e una punteggiatura minima. E’ quasi un seguito del lavoro precedente: isole di bianco totale, rotonde, 2 semicerchi, 2 figure, una femminile. Se ne stanno accovacciate e nude; la luce sale e scende e così la temperatura. Il passaggio dalla luce al buio, dal caldo al freddo, è l’unica cosa che accade, ma l’osservazione, in tutto quel bianco, è difficoltosa e la voce narrante sembra stancarsi, abbandonando l’immagine/immaginazione dei corpi e di quel che (non) fanno. Il testo s’interrompe bruscamente.
Sempre del 1966 è lo stupefacente Bing: anche qui un corpo autonomo, ormai ripulito dalla putredine psicologica dello storytelling globale, corpo isolato nel bianco preistorico, isolato in un’incandescenza embrionale, cranica, non più personaggio con propri ricordi, solo materia verbale isolata in uno stupore dal sapore chiaramente science fiction e l’uso di una lingua esfogliata con caduta di articoli, desinenze.
Del 1970 è Senza, una prosa breve in terza persona, senza punteggiatura (salvo il punto), frasi brevi, paratattiche e capitoletti di poche righe. Ci viene descritto uno spazio bianco, illimitato, sabbioso. Una figura (qui il raffreddamento e lo svuotamento psicologico è allo zenith, i personaggi sono atomi verbali, orbite astratte sulla pagina) bianca, senza ricordi, in piedi; nessun rumore, delle rovine cubiche, rifugi tra le dune. La figura, un passo lentissimo alla volta, avanza tra le rovine. Fine.
Sempre del 1970 il testo più affascinante, a mio avviso il vero capolavoro della science fiction degli anni Settanta, un romanzo di fantascienza abortito: Le dépeupleur, lo spopolatore.
 Siamo in un cilindro, gomma, scale, nicchie, gallerie e un’uscita segreta; 200 corpi geometrizzati e la luce che cresce e decresce intorno a una penombra giallo/rossa. L’andirivieni dei corpi chiusi nel cilindro (spazio totale di 1200 metri quadrati) alla ricerca di un’uscita, vecchia credenza che ancora anima il formicaio umano. Tra loro, i vinti, coloro che hanno rinunciato e rimangono immobili. Alla fine del romanzo (una trentina di pagine), rimane un ultimo cercatore e lei, la vinta dai capelli rossi che rappresenta il Nord, la prima a essersi abbandonata all’inazione. E sarà alzando le palpebre della ragazza e contemplando quei deserti di calma che l’ultimo cercatore troverà la sua posizione immobile (ma mai seduta) e tutto, nel cilindro, s’interromperà per cedere al buio e al gelo.
Siamo in un cilindro, gomma, scale, nicchie, gallerie e un’uscita segreta; 200 corpi geometrizzati e la luce che cresce e decresce intorno a una penombra giallo/rossa. L’andirivieni dei corpi chiusi nel cilindro (spazio totale di 1200 metri quadrati) alla ricerca di un’uscita, vecchia credenza che ancora anima il formicaio umano. Tra loro, i vinti, coloro che hanno rinunciato e rimangono immobili. Alla fine del romanzo (una trentina di pagine), rimane un ultimo cercatore e lei, la vinta dai capelli rossi che rappresenta il Nord, la prima a essersi abbandonata all’inazione. E sarà alzando le palpebre della ragazza e contemplando quei deserti di calma che l’ultimo cercatore troverà la sua posizione immobile (ma mai seduta) e tutto, nel cilindro, s’interromperà per cedere al buio e al gelo.
Linguisticamente, Lo spopolatore è un testo più lungo e complesso, stilisticamente involuto sul genere di un trattato scientifico/naturalistico intessuto di laboriose costruzioni narrative poggiate su periodi brevi, quasi sempre coordinati.
Ancora del 1970 il brevissimo Per finire ancora.
Prima ci viene descritto un nero cranico, poi un grigio cenere, plumbeo di cielo e terra. Appaiono spire desertiche alla Star Wars interrotte da delle rovine entro cui si trova l’espulso; all’orizzonte compaiono, inaspettatamente, due nani albini che portano una barella; l’espulso però, dalla sua postazione, non li vede. Alla fine, il buio nero cranico ritorna e spegne l’interruttore dell’immagine.
 Ricapitolando, abbiamo visto come la novità di Beckett sia quella di combinare lo stupore della fantascienza (gli spazi chiusi che rimandano a certi laboratori sotto vuoto, alle cavie di esperimenti di alieni; l’uso di certe immagini come quella dell’interruttore invisibile, acceso e spento da chi?; i nani albini scartati dal deserto di Guerre Stellari o da un set di Jess Franco; i corpi che si rompono e si ricompongono come robot organici, gommosi) a un certo tipo di prosa breve, sperimentale (operazione poi non tanto rara, visto che in quegli anni, su sensibilità differenti, opera anche Burroughs; oppure possiamo pensare a certi esiti italiani – e mi riferisco all’area di Robot la rivista di Vittorio Curtoni – che mescolano spesso esperimenti narrativi agli archetipi della sci-fi). L’intento di Beckett è quello di esaurire il linguaggio, operando su testi minimi, paratattici, con una costruzione del periodo fondata sull’accostamento di proposizioni indipendenti, coordinate, usando una punteggiatura neumatica, composta di segni franti al singhiozzo, alliterazioni (con ripetizioni frequenti di suoni e sillabe identiche), uno stile nominale, una riduzione del verbo alle forme semifinite. Il tutto con un andamento da abbozzo, da trattazione sommaria, in progress (ipotiposi).
Ricapitolando, abbiamo visto come la novità di Beckett sia quella di combinare lo stupore della fantascienza (gli spazi chiusi che rimandano a certi laboratori sotto vuoto, alle cavie di esperimenti di alieni; l’uso di certe immagini come quella dell’interruttore invisibile, acceso e spento da chi?; i nani albini scartati dal deserto di Guerre Stellari o da un set di Jess Franco; i corpi che si rompono e si ricompongono come robot organici, gommosi) a un certo tipo di prosa breve, sperimentale (operazione poi non tanto rara, visto che in quegli anni, su sensibilità differenti, opera anche Burroughs; oppure possiamo pensare a certi esiti italiani – e mi riferisco all’area di Robot la rivista di Vittorio Curtoni – che mescolano spesso esperimenti narrativi agli archetipi della sci-fi). L’intento di Beckett è quello di esaurire il linguaggio, operando su testi minimi, paratattici, con una costruzione del periodo fondata sull’accostamento di proposizioni indipendenti, coordinate, usando una punteggiatura neumatica, composta di segni franti al singhiozzo, alliterazioni (con ripetizioni frequenti di suoni e sillabe identiche), uno stile nominale, una riduzione del verbo alle forme semifinite. Il tutto con un andamento da abbozzo, da trattazione sommaria, in progress (ipotiposi).
L’uso scenografico dello spazio chiuso (le figure geometriche, il cubo) oggi ci fa pensare a certo cinema sci-fi come Il cubo di Vincenzo Natoli. Oppure alla cartografia del bianco-prigione del bellissimo L’uomo che fuggì dal futuro di George Lucas, composto in quel 1970 dello Spopolatore. Oppure il sub-mondo dei corpi immobili immersi nel bianco come fosse una soluzione liquida, amniotica in cui improbabili alieni ci studiano/vivisezionano potrebbe rimandare al fulminante cortometraggio Lumiere (1995) diretto da David Lynch. Altre criptiche citazioni sono rintracciabili nella parte della prigione dell’ultimo Batman di Nolan, quasi un remake (involontario?) del formicai umano de Le dépeupleur.
Ancora il luogo chiuso traccia delle forti somiglianze con la pittura di Francis Bacon, dove la figura è isolata nelle campiture del contorno (una stanza, una sedia), immersa in un mondo completamente chiuso; il contorno in Bacon è protesi per la figura, estratta da una storia, senza più una storia da raccontare.
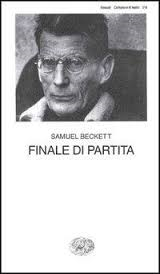 Sempre nella pittura, la fantascienza beckettiana mi porta a Karel Thole e alle copertine di Urania, spesso infittite di tematiche rarefatte che potrebbero adattarsi alla perfezione all’universo di cui stiamo parlando. Thole è pittore di squisite ascendenze surrealiste. Con Beckett condivide ossessioni oculari (l’occhio che guarda, costretto a raccontare il poco niente che rimane), oppure condivide il gusto per gli spazi geometrici, e ancora la rappresentazione degli spazi vuoti; Thole insomma costruisce fantasmi metafisici tormentati dall’inconscio delle rovine (vegetali, organiche, minerali) e in questo mi fa pensare a certe condensed novels di Ballard composte in quei medesimi Sessanta (penso a Finale di partita e la Spiaggia terminale).
Sempre nella pittura, la fantascienza beckettiana mi porta a Karel Thole e alle copertine di Urania, spesso infittite di tematiche rarefatte che potrebbero adattarsi alla perfezione all’universo di cui stiamo parlando. Thole è pittore di squisite ascendenze surrealiste. Con Beckett condivide ossessioni oculari (l’occhio che guarda, costretto a raccontare il poco niente che rimane), oppure condivide il gusto per gli spazi geometrici, e ancora la rappresentazione degli spazi vuoti; Thole insomma costruisce fantasmi metafisici tormentati dall’inconscio delle rovine (vegetali, organiche, minerali) e in questo mi fa pensare a certe condensed novels di Ballard composte in quei medesimi Sessanta (penso a Finale di partita e la Spiaggia terminale).
Con una torsione estrema potremmo spingerci fino al Joe Lansdale della Notte del drive in, dove la fine non è mai la fine e il drive in diviene un mondo vuoto, una necropoli della fantasia, un luna park planetario di spettri, polvere, vento, nebbia e labirinti interscambiabili all’infinito, fondali bidimensionali dietro ai quali si cela il vuoto.
Tuttavia, lo specifico di Beckett, il motivo per cui oggi sarebbe sano rileggersi quei testi è un altro.
Sorvoliamo il fatto che Beckett non sia uno scrittore di genere. Dopotutto, come abbiamo visto, coi generi condivide delle pulsioni di base. Ad esempio l’avversione verso personaggi psicologicamente sfaccettati. Certo il genere predilige l’azione alla descrizione. Però Beckett è interessato a una tabula rasa dell’immaginazione che per lui, uomo del Novecento, aveva un significato; per noi, oggi, in pieno mondo aliendale, un altro.
Da consumatori consumati (Essere o Avere di Fromm, superato & fagocitato), fidelizzati dalla grande distribuzione dei bassi salari e dei diritti negati, da persone a clienti, soci, tesserati. Il nostro quotidiano è un abuso di consumi: più di un’automobile, più di una casa, telefoni e telefonini, frigoriferi pieni, cibo, palestre da mantenere. Non riuscire a tenere il passo, non riuscire a consumare è male, è un senso di colpa, un segno di non appartenenza al consorzio umano del marketing.
 Noi italiani medi viviamo di punti regalo, shopping center, promotion, carta fedeltà e sottocosto. Ci hanno abituati così fin da piccoli. Consumo, dunque sono. E consumo tutto. Meglio se 3 per 2. Il tempo libero intasato dalla tecnologia (alzi la mano chi oggi vivrebbe senza mandare un sms? E pensare che fino a dieci anni fa non era così – e la prosa di sms o quella veloce e standard di Twitter non è poi lontana dagli esperimenti lessicali di Beckett), perché anche il relax deve essere incanalato nell’impalpabile traccia elettromagnetica di un bancomat, deve essere fruttifero. La serialità televisiva (di gran moda in questi giorni) nasce dall’esigenza di riempire spazi di programmazione dilatati all’inverosimile, tirarla per le lunghe con stratagemmi algoritmici che tramutano l’artigianato imperfetto del racconto in tabelle e grafici in cui tizio fa questo nell’atto uno, quest’altro nell’atto due, climax, eccetera, finale consolatorio o meno e poi tutti a ordinare le tazze per la colazione di Breaking Bad. Narrazioni dopate, annacquate, giunte al limite estremo del self-service creativo (penso ai reality show in cui l’uomo comune diviene una star e regge lui lo show, lo scrive in diretta con le suo mancanze lessicali, o al self publishing che se da un lato abbatte (o finge di) certe barriere dittatoriali dell’editoria, dall’altro intasa un non luogo immateriale con la nostra vanità bla bla bla. Le prose sci-fi di Beckett tracciano un monito chiarissimo e originale. Ne cantò anche Lucio Battisti (genio sommo): perché immaginare (fare) sempre qualcosa di più, di nuovo e non di meno? L’immaginazione in Beckett è morta, ridotta a piccoli brandelli. E’ un lo-fi delle parole. Un modo per rigenerarsi e ripulirsi di tanti sprechi, tanta inutile creatività (e mi ci metto in mezzo per primo, visto che il self publishing lo utilizzo eccome per i miei aborti). Spopolare un pochino il cervello e passare il tempo libero non tra i banconi da obitorio di un supermarket o davanti a True Detective. Lavorare meno, spendere meno, vivere con meno e guadagnare in libertà.
Noi italiani medi viviamo di punti regalo, shopping center, promotion, carta fedeltà e sottocosto. Ci hanno abituati così fin da piccoli. Consumo, dunque sono. E consumo tutto. Meglio se 3 per 2. Il tempo libero intasato dalla tecnologia (alzi la mano chi oggi vivrebbe senza mandare un sms? E pensare che fino a dieci anni fa non era così – e la prosa di sms o quella veloce e standard di Twitter non è poi lontana dagli esperimenti lessicali di Beckett), perché anche il relax deve essere incanalato nell’impalpabile traccia elettromagnetica di un bancomat, deve essere fruttifero. La serialità televisiva (di gran moda in questi giorni) nasce dall’esigenza di riempire spazi di programmazione dilatati all’inverosimile, tirarla per le lunghe con stratagemmi algoritmici che tramutano l’artigianato imperfetto del racconto in tabelle e grafici in cui tizio fa questo nell’atto uno, quest’altro nell’atto due, climax, eccetera, finale consolatorio o meno e poi tutti a ordinare le tazze per la colazione di Breaking Bad. Narrazioni dopate, annacquate, giunte al limite estremo del self-service creativo (penso ai reality show in cui l’uomo comune diviene una star e regge lui lo show, lo scrive in diretta con le suo mancanze lessicali, o al self publishing che se da un lato abbatte (o finge di) certe barriere dittatoriali dell’editoria, dall’altro intasa un non luogo immateriale con la nostra vanità bla bla bla. Le prose sci-fi di Beckett tracciano un monito chiarissimo e originale. Ne cantò anche Lucio Battisti (genio sommo): perché immaginare (fare) sempre qualcosa di più, di nuovo e non di meno? L’immaginazione in Beckett è morta, ridotta a piccoli brandelli. E’ un lo-fi delle parole. Un modo per rigenerarsi e ripulirsi di tanti sprechi, tanta inutile creatività (e mi ci metto in mezzo per primo, visto che il self publishing lo utilizzo eccome per i miei aborti). Spopolare un pochino il cervello e passare il tempo libero non tra i banconi da obitorio di un supermarket o davanti a True Detective. Lavorare meno, spendere meno, vivere con meno e guadagnare in libertà.
I boschi ci attendono.






























