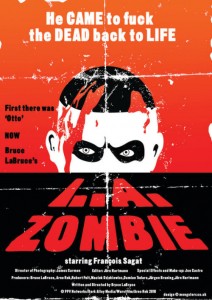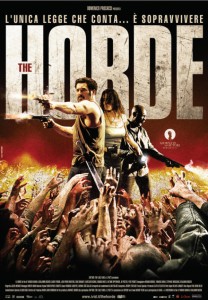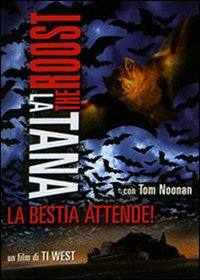Intro.
Provo a tracciare un bilancio (personalissimo) dello zombi movie dello scorso decennio, decennio che ne ha decretato una insperata, quanto numericamente elevata, rinascita. Dopo le secche dei ’90, quando l’horror sembrava aver esaurito la sua carica eversiva e commerciale, gli anni Zero (con tutti i fattori politici ed economici che si trascinano dietro, dal crollo delle due Torri alla crisi economica) hanno riaperto le porte dell’inferno. Su queste nuove “albe” credo siano già state scritte e teorizzate cose importanti e, per questo, rimando alla parziale bibliografia in coda. Qui, sulle pagine virtuali della Zona, vorrei provare a ripercorrere, in estrema sintesi, questi dieci anni, selezionando solo 8 pellicole (le chiamo così per vezzo, ma non tutte sono state girate sulle strisce di celluloide), così da offrirti, caro lettore, la possibilità di confrontare le tue visioni (e la tua lista personale) con quelle di un altro vivo morente. Cominciamo? Cominciamo.
L.A. ZOMBIE
Perché le acque dell’Oceano paiono fatte di cenere schiumosa.
Perché è sempre dalle acque che nasce o rinasce una nuova vita (e anche in “Zombie Honeymoon” la minaccia sbucava dalla torba delle onde e vomitava il pastone putrescente nella gola dello sposino); Francois Sagat esce nudo e truccato, già pronto a fare sfracelli, col pendolo in bella vista tra le gambe.
Perché solo Joe D’Amato con “Porno Holocaust” avrebbe potuto (anche solo) immaginare questo “Porno Gay Holocaust” con lo zombi Sagat che, dopo essere incappato in vari cadaveri (resi tali dalla deriva violenta della metropoli USA), li penetra col suo c***o zombi gigantesco, per poi eiaculare sangue da un glande ricurvo e a punta come le scarpe di Alì Babà.
Perché la Los(t) Angeles che fa da sfondo alla storia è bellissima e rarefatta, fotografata con la medesima poesia fisica della Miami di Michael Mann.
Perché, nonostante sia un film omosessuale (e chi scrive non sia fi******o), il film di Bruce LaBruce mi ha fatto capire che sono un razzista sessuofobo, e che vedere due uomini che si baciano o altro non è più osceno di quanto lo sia vedere un uomo o una donna, o due donne, che scopano. Perché L.A.ZOMBIE è fatto di bisogni primari e il bisogno di un contatto, di una carezza rude è identico da individuo a individuo, aldilà di inclinazioni, ideologie e menate varie, e perché il P.P. finale sul viso di Sagat è da brivido e il porno attore francese è capace di restituirci il senso della visione con due sole lacrime, mandando af*****lo qualunque super attore miliardario con le sue 4 smorfie del c***o.
Perché è un film sull’alienazione girato nei luoghi reali dove questa alienazione cresce, ovvero ai margini delle strade, tra chi ha perso ogni cosa e non possiede altro che un carrello da supermarket pieno di rifiuti e il proprio corpo sudato in precoce disfacimento.
Perché, alla fin fine, alla fantasia di questo barbone, che si immagina uno zombi alieno in cerca di cadaveri da rianimare con lo sperma, non resta che auto tumularsi da solo (questo è genio!) dove tutto è cominciato: ovvero nel restyling dell’eterno cimitero perfettivo, allineato, all’americana, della notte dei living dead (e siccome siamo a colori, voglio pensare si tratti del medesimo camposanto del remake capolavoro di Savini).
Perché i trucchi di Joe Castro (mi pare si chiami così) sono bellissimi, senza bisogno della solita vagonata di miliardi sprecati (lo dico una volta sola e valga per sempre: ma è possibile buttare milioni di euro per fare dei film? È una cosa così seria? Più seria di chi non ha nemmeno un bicchiere di acqua al giorno per bere e lavarsi? Non possono limitarsi a girare un film con un i-Pod e un barattolino di lattice?).
E perché lo zombi zannuto è il più figo e originale che abbia mai visto.
Perché è il più bel film di zombi degli 0 e se ne frega di voi e di me e del nostro qualunquismo che ha bisogno di essere rassicurato dagli effetti visivi, dalla cgd e da una sceneggiatura di ferro piena di dialoghi a cascata scritti dallo specialista del nulla Tarantino e approvati da una commissione di inchiesta di cattolici ex democristiani, ora postmontiani, casinisti, finiani, binettiani e compagnia cantante (adesso è arrivato Captain Findus…).
THE HORDE
Perché il film del duo francese Dahan & Rocher è un ibrido tra un polar francese (i migliori in questo campo) e uno splatter-zombi-movie coi morti di ultima generazione che corrono e saltano come tarantolati. Certo, la commistione non è nuova, ci avevano già provato coi vampiri di “Dal tramonto all’alba”, ma lì era diverso, perché il gusto era troppo ironico, videotecaro e non ci si prendeva sul serio. Qui invece c’è poco da scherzare. Gli sbirri che devono fare irruzione in un palazzone fatiscente delle balieu paiono usciti da un polar nerissimo di Olivier Marchal. Il nuovo polar francese ha resettato la lezione melviniana, composta da carogne e poliziotti con un codice d’onore. Qui il dettato è quello di Manchette, che ha fatto tabula rasa di regole e regolamenti: come dice la frase di lancio del film, non rimane spazio che per il cinismo più spinto e il bisogno (animale) di sopravvivenza contro tutti e tutto. Nel giro di mezz’ora, l’impianto noir si capovolge in un imbuto dantesco, coi morti che sbavano liquami sui vetri e digrignano a più non posso. Poliziotti & Gangster si alleano malvolentieri per sopravvivere, ma sarà comunque una carneficina. Non ci sarà spazio per paroloni, battutone, buoni sentimenti e amicizie virili alla Carpenter. La Horde è un pugno in faccia accelerato, un black hole fatto di ossa che si schiantano e sangue, tantissimo sangue.
Perché La Horde è lontanissimo da tutto il pattume televisivo (italiano). Qui non c’è posto per preti investigatori in odor di santità, non c’è posto per ciclisti, finanzieri, magistrati, sindacalisti, suore, nonni, medici in famiglia in odore di santità. Tutta la medietà televisiva è smascherata dalla furia dello splatter, vera radiografia che “fa esplodere tutte quelle pulsioni aggressive e brutali che albergano nell’animo umano [1]”. I personaggi hanno passati oscuri, brandelli che riemergono come istantanee al fine di pennellare, con altri chili di vernice nera, gli animi perduti. Il nigeriano che ha assistito a orrori che noi umani, il reduce di Algeria schizzato e sadico, lo zingaro Jo Presta sempre immenso, gli sbirri schizzati e fuori controllo. Tutto fosco. Plumbeo. Cupo.
Perché uno degli sbirri ha la voce di Vick Mackey di “The Shield” e la cosa non guasta.
Perché, alla fine, tutti pagheranno tutto, anche più del necessario.
Perché comunque, anche usciti dal palazzone, non c’è via di fuga e il mondo infestato dall’orda non è un bel posto dove passare il proprio tempo.
Perché è un film francese e i francesi sono gli unici, in Europa, capaci di fare film di genere pienamente esportabili e godibili.
L’ALBA DEI MORTI VIVENTI
Perché è una rivisitazione apocalittica del classico di Romero, leggo dal retro del bellissimo dvd (ricco di extra coi contro c****oni) della Universal. Ed è vero. Il film di Snyder è l’altro grande capolavoro del decennio, il film grazie al quale dobbiamo tutta l’outbreak zombesca venuta dopo.
Perché è scritto da quel James Gun che aveva scritto Tromeo & Juliette della Troma e che poi avrebbe diretto quel capolavoro di horror/umorismo che è Slither. E perché proprio la scrittura è, in primis, il punto forte dell’opera: una scrittura capace di coagulare personaggi così sfaccettati e credibili e, a tratti, rivoluzionari come CJ, che parte come uno stronzo senza speranze e si accomiata dallo spettatore come il capo della situazione. E anche perché Gunn tratteggia un percorso all’inverso rispetto alla distopia romeriana, dove la società collassata su se stessa (perché stringendo, questa è la metafora uber alles dello zombi movie) ed è incapace di ritrovare una via, una nuova politica. Nel restyling Universal tutto parte malissimo, degenera in un lampo. Prima il quartierino americano con le casette tutte identiche, vero marchio di fabbrica di un liberismo pompato che promette solo successi calvinisti e nasconde gli homeless sotto il tappetino delle periferie (Resident Evil number 5 rifarà questo incipit con Milla spogliata dalle sue tute in lattice nere e dai suoi super poteri, camuffata da milf anonima di periferia con maritino scemotto e bimba sordomuta tenerella). Lei infermiera carinissima (l’insistenza sui suoi piedini è più disturbante di un porno con Sasha Grey), lui marito stravaccato sul letto a guardarsi l’ennesimo talent. Poi l’apocalisse che bussa alla porta senza farsi annunciare. Prima dei titoli di testa l’universo narrativo è già impostato. I titoli scorrono inframmezzati alle immagini e sono tra i più belli dell’intero decennio (così come quelli di coda). L’infermiera incontra gli altri, arrivano nel market e ognuno è per sé, egoista, indifferente. Poi, mano mano che si va avanti, Gunn opera la sottile e progressiva trasformazione dei personaggi, amalgamandoli in un gruppo variopinto, magari inefficace, ma sempre più unito, capace insomma di ritrovare quella polis primigenia che l’utopia necrotizzata dei morti ha spazzato via.
Perché Zack Snyder filma e monta il tutto con una maestria fuori dal comune, assemblando un’opera visiva senza un’oncia di grasso, scorrevolissima e perfetta in ogni sua parte.
Perché è un film rimpinzato di citazioni verso tutto l’universo zombi precedente (non solo romeriano), anche se le citazioni non sono suture, ferite esibite come in tanto postmoderno o nel cinema vacuo di Tarantino, bensì sono molecolarmente inserite, disciolte nel nuovo tessuto narrativo, rese quasi impercettibili; infatti, ed è questo che ci dice Snyder, non è più importante coglierle. Qui siamo a un nuovo inizio, una nuova alba. Una tabula rasa nel genere e sul genere. Una tabula rasa che, nel decennio degli zero, saranno in pochi a fare (Dei nomi, così per piacere: Rob Zombi, Victor Salva, forse James Gunn).
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
Perché è il più bello tra i cinque film finora messi in cantiere. Delle cinque teste dell’idra è quella (insieme al terzo capitolo) più filmica, ovverosia quella che è più un film. Gli altri sono solo dei videogame senza senso, seppur (il quarto e soprattutto il quinto) visivamente stupendi, vere summe dell’immaginario fantastico dal poema di Gilgamesh a oggi. Ma questo Apocalypse è diverso. Qui gli zombi non sono tappezzeria tra altre stupefazioni salgariane. Qui tutto è fisico, scenografie, attori, zombi (finalmente putrefatti con cascate di vermi dalle orbite e non quei trucchi anoressici digitali del primo). La città è una Sin City del noir in preda alla pandemia del virus, coi morti che non corrono ma nemmeno sono più così lenti e strascicati. E poi il taglio delle luci, contrastate, affilate. L’azione, le sparatorie. Tutto inserito in una storia quasi perfetta, asciugata dalle frasi a effetto e stronzatine sentimentali. Qui le donne sono dure come l’acciaio, maneggiano armi pesanti, eppure non perdono un grammo del loro fascino da divinità greche.
Perché la scena del cimitero ricorda certi zombi movie italiani anni Ottanta, in particolare il cimitero americano caliginoso di Paura nella città dei morti viventi.
Perché c’è Sienna Guillory, la donna più figa del mondo, che entra in scena coi tacchi a spillo e piedini divini. Si sfila le scarpe, mette stivaletti fetish e inizia a piantare pallottole nel cranio dei morti alla stazione di polizia con la stessa determinazione di un personaggio carpenteriano.
Perché c’è Sienna Guillory, che è bene ripeterlo, e ci fa dimenticare persino di Milla, che è già tanta roba.
DIARY OF THE DEAD
Perché è il capolavoro di Romero tra i tre film girati nello scorso decennio, quello dove dimostra la sua capacità di stare ancora dentro il mondo attuale, di saperlo leggere e raccontare. E perché gli zombi sono vecchio stile, non corrono, non hanno fretta, non dimostrano di doversi adeguare all’imperante (e idiota) moda di rendere persino i cadaveri esseri frettolosi.
Perché è parecchio sperimentale e sembra girato da una ragazzino americano fresco di campus cinematografico.
Perché è tutto quello che non è “Land”: indipendente, fatto con molti meno mezzi del film Universal, in venti giorni.
Perché l’idea di ricominciare, fare tabula, azzerare tutto e partire da capo con l’epidemia dagli anni Zero, coinvolgendo i nuovi media, la nuova tecnologia a disposizione, i social network, ben si adatta a questo Romero ancora fortemente politicizzato, alla ricerca di significati, ma meno dogmatico, direi, quasi, pragmatico, spiccio. Il film infatti è veloce, non si perde dietro troppe chiacchiere. Il canovaccio è classico: epidemia, fuga-viaggio con varie peripezie (ospedale, banditi, militari, boschi, case di campagna, eccetera). Naturalmente c’è anche l’assedio dei morti, gli incontri spiacevoli, gli aiutanti che forniscono armi, viveri e munizioni, o più semplicemente il wi-fi per collegarsi e montare e scaricare i filmati che la truppa ha composto durante il viaggio. Perché i nuovi media (i social) permettono, ci dice Romero, di raccontare l’epidemia (economica) fuori dai vecchi schemi, fuori dal controllo, sempre pilotato dall’alto, dei vecchi network. Solo i blogger, con la loro anarchia individuale, possono documentare quello che sta avvenendo in giro per il mondo e contribuire a mantenere le coscienze individuali ben sveglie (le primavere arabe, le porcate mascherate dagli apparati in Siria e Iran dovevano ancora venire, ma questa è la grandezza dell’intuizione romeriana in sintesi…).
Perché la scena finale, coi soliti cacciatori di zombi idioti con le camice di flanella e i berretti spessi di lana, o le bottiglie di birra da smazzare tra una fucilata e l’altra, ci riporta sempre all’ineliminabile sfiducia nell’uomo nutrita da zio George. Sfiducia (noir) alla quale mi sento di aderire perfettamente, sottolineando come la zombi appesa a cui sparano i deficienti, anche se morta, col cranio spaccato e penzolante, continua a guardare e guardarci. Continua a giudicarci.
LA CASA DEI 1000 CORPI
Perché parla di una famiglia disfunzionale che ci mostra nel vitrum (in vitro) una scomposta osmosi culturale di frammenti della POP culture di massa. Perché Rob Zombie è l’unico vero talento (che si dedica anima e corpo al genere) emerso dal decennio appena concluso. L’unico ad aver filmato un classico (I reietti del diavolo). Perché la casa è un film di zombi, anche un film di zombi. Forse. Sono zombi quegli esseri del finale? Forse. Non importa. Rob Zombie. Lo canta anche il rapper Salmo nell’ultimo disco. Non importa. Importa. Perché tutto si tiene.
LA TANA
Ti West. Un ragazzone americano style Eli Roth. Uno che, fin dalla più tenera età, si è cibato di fumetti, film e musica horror. Un pastone culturale frullato e filtrato con superficialità dalla lente convessa della tv (un altro con la medesima educazione di massa è, appunto, Rob Zombie). Ti West è uno dei nomi più interessanti dell’ultimo decennio. Dopo questo esordio ha filmato un film satanico, molto anni settanta, House of the devil, e poi il sequel di Cabin Fever, sequel gore splatter con puntine hard. Ma parliamo de La tana, zombie-movie piuttosto interessante. Dei ragazzi di notte in macchina. Una radio accesa che trasmette programmi per Halloween. La prima metà del film passa così. Attesa e buio, un buio fitto come non l’avete mai visto in altri film. Ancora attesa. E soprattutto lentezza, quella lentezza narrativa (e registica) che non viene quasi più praticata dagli intossicati di tecnologia digitale. Poi le cose precipitano. L’infezione zombie forse viene dai pipistrelli. Ma siamo in campagna e nessuno se ne accorge. Solo i ragazzi e dei vecchi. L’apocalisse, come in Rollin e Grau, è giocata in piccolo, tascabile.
Dai tempi di Tiziano Sclavi e del suo Guerre terrestri è sempre un’ottima scelta.
Una scelta analogica.
LE LAC DES MORTS VIVANTS di Jean Rollin
1980, da qualche parte in Svizzera.
1980!
Prego? Non si parlava di zombi degli anni 0?
Che ci azzecca?
Niente.
E il procedimento anaforico?
Buonanotte al secchio.
Si è perso, è scivolato via, sotto le acque limacciose del lago.
Ho scritto questo articolo (e il prossimo sugli zombie del ’900) in un tempo molto lungo. All’inizio mi ha preso, poi la curiosità mi ha portato altrove e l’ho abbandonato. Adesso lo voglio finire, ma la testa è ancora altrove (su un romanzo satanico che sto scrivendo e che spero qualcuno di voi scaricherà gratuitamente da Lulu.com quando sarà pronto) e l’unico film di zombi di cui vorrei parlare è questo. Mi è arrivato da poco il dvd americano. L’ho atteso a lungo. Era uno dei pochi Rollin mancanti. L’avevo già visto nell’edizione della Pulp. Non lo vedevo da anni. Sarò breve. Brevissimo. So benissimo che per tutti, anche per gli appassionati, questo film è considerata una somma cagata.
Bene.
Non per me.
Il lago.
Il silenzio.
La lentezza esasperata.
Il sotto plot romantico d’amore.
Lo zombi paterno e gentile.
Tutti elementi di zio Jess.
Poi zio Jess il film non l’ha girato.
E’ arrivato Rollin, o così ho capito, ho letto.
E Rollin, al posto dello zoom selvaggio, annega il tutto in un ritmo narcotico e sospeso. Gli zombi hanno il trucco in faccio del cartolaio. I soldi sono inesistenti. Gli attori, comparse prese a casaccio.
Eppure.
Eppure il ritmo, la densità atmosferica, l’anima insomma c’è.
Oggi cose così non le farebbe nessuno, a patto di buttarla in caciara, coi soliti stronzetti fighetti assatanati e ridanciani (vedi il franchise – si scrive così? Boh – di Wrong Turn). Oggi solo il gusto imperante postmoderno degli studentelli di cinema può permettersi di rifare (male) questo tipo di prodotto. Rollin non era consapevole di quello che faceva, per lui questo lago era solo una cosa alimentare, un modo per racimolare i soldi per comprarsi baguette e salame.
Eppure l’eccessiva libertà di quel cinema riusciva comunque a produrre dei cortocircuiti che, visti allora, potevano anche confondersi nel gran marasma di buon cinema che si faceva, ma adesso, in questo 2013 di deep crisis, di death economy, adesso sono esiziali, perché rimarcano l’insondabile distanza dell’arte (o dell’artigianato, fate voi) dalle convenzioni commerciali (a tavolino) di 4 tizi in giacca e cravatta!
Davide Rosso
Bibliografia:
Tito Faraci, Oltre la soglia, Piemme 2011
Davide Toffolo, Cinque allegri ragazzi morti, Coconico Press 2011
Arona, Pascarella, Santoro, L’alba degli zombi, Gargoyle 2011
D. Pulici (a cura di), Nocturno dossier n. 28: Zombi Apocalypse 2004
Giustina Gnasso, Zona infetta, 0111 edizioni 2010
Ross Campbell, The abandoned, Purple Press 2008
Aloisio e Ricciardi, Zombi, Un mondo a parte 2011
Claudia Salvatori, Abel, Mondadori collana Epix n.6 2009
Max Brooks, World war Z, Cooper 2007
[1] Teresa Macrì, Splatter, Stampa Alternativa 1993.