 L’architettura letteraria del romanzo gotico, applicabile – in senso stretto – a un gruppo di romanzi scritti tra il ‘700 e l’800, trova terreno fertile all’interno del mystery classico, ossia del giallo ad enigma, la cui golden age può oscillare tra il 1915 e il 1939. Quello tra il gotico e il mystery è un curioso abbinamento. Il primo ci fa venire in mente racconti o romanzi intrisi di superstizione, soprannaturale e ambientazioni arcaiche, pre-industriali, con personaggi stereotipati e castelli infestati da spettri. Il mystery classico ad enigma, invece, è un ballo in maschera in cui ognuno è travestito da qualcun altro, è un genere che vive sul mistero, sull’enigma, sì, ma solo per svelarlo, inondarlo di luce. Il mystery (o giallo che dir si voglia) gira intorno alle incomprensioni, alle false piste, alla finta complessità, eppure, nel corso delle investigazioni letterarie, tutto ci apparirà chiaro, razionale, sensato. Nel giallo i criminali sono mossi da motivi puerili, quotidiani, spesso legati a faccende monetarie (eredità, bancarotta, ruberie varie), oppure mossi da ragioni di vendetta. Nel gotico, il soprannaturale si manifesta con caratteristiche opposte, insistendo, con una certa enfasi, nelle descrizioni del terrificante: spettri, licantropi, vampiri, eccetera. Nessuno di questi mostri ha delle ragioni ideali (la devianza del criminale che minaccia l’ordine e le regole della società, argine simbolico dalle barbarie primordiali del cosmo e della natura) per uccidere, semplicemente assolvono al vecchio adagio per cui i morti invidiano i vivi e tramano ai loro danni. La paura della morte e il fascino per il macabro sono le note privilegiate del gotico. Il gioco dei fraintendimenti e la chiarezza delle soluzioni, quelle del mystery. Il mystery ha la necessità di ordinare i fatti del mondo, di idealizzarli e quindi di riassumerli secondo un principio regolatore, un’etica, una morale, dei simboli “civili”. Il gotico non offre modelli culturali da seguire, si presenta involuto, esagerato, pagano. Il gotico è il caos. Il mystery l’ordine. Ciò che viene prima e ciò che viene dopo e di nuovo. Vuoto e pieno. Anteriore. Creazione.
L’architettura letteraria del romanzo gotico, applicabile – in senso stretto – a un gruppo di romanzi scritti tra il ‘700 e l’800, trova terreno fertile all’interno del mystery classico, ossia del giallo ad enigma, la cui golden age può oscillare tra il 1915 e il 1939. Quello tra il gotico e il mystery è un curioso abbinamento. Il primo ci fa venire in mente racconti o romanzi intrisi di superstizione, soprannaturale e ambientazioni arcaiche, pre-industriali, con personaggi stereotipati e castelli infestati da spettri. Il mystery classico ad enigma, invece, è un ballo in maschera in cui ognuno è travestito da qualcun altro, è un genere che vive sul mistero, sull’enigma, sì, ma solo per svelarlo, inondarlo di luce. Il mystery (o giallo che dir si voglia) gira intorno alle incomprensioni, alle false piste, alla finta complessità, eppure, nel corso delle investigazioni letterarie, tutto ci apparirà chiaro, razionale, sensato. Nel giallo i criminali sono mossi da motivi puerili, quotidiani, spesso legati a faccende monetarie (eredità, bancarotta, ruberie varie), oppure mossi da ragioni di vendetta. Nel gotico, il soprannaturale si manifesta con caratteristiche opposte, insistendo, con una certa enfasi, nelle descrizioni del terrificante: spettri, licantropi, vampiri, eccetera. Nessuno di questi mostri ha delle ragioni ideali (la devianza del criminale che minaccia l’ordine e le regole della società, argine simbolico dalle barbarie primordiali del cosmo e della natura) per uccidere, semplicemente assolvono al vecchio adagio per cui i morti invidiano i vivi e tramano ai loro danni. La paura della morte e il fascino per il macabro sono le note privilegiate del gotico. Il gioco dei fraintendimenti e la chiarezza delle soluzioni, quelle del mystery. Il mystery ha la necessità di ordinare i fatti del mondo, di idealizzarli e quindi di riassumerli secondo un principio regolatore, un’etica, una morale, dei simboli “civili”. Il gotico non offre modelli culturali da seguire, si presenta involuto, esagerato, pagano. Il gotico è il caos. Il mystery l’ordine. Ciò che viene prima e ciò che viene dopo e di nuovo. Vuoto e pieno. Anteriore. Creazione.
 Eppure entrambi i generi hanno trovato un fertile terreno comune, generando dei romanzi o delle novelle sospese tra i due territori. Un punto comune potrebbe essere nella costruzione anti-psicologica, stereotipata dei caratteri e degli ambienti. Gotico e mystery lavorano su delle cornici ideali, su una serie di figure retoriche comuni e ripetibili all’infinito. Il mostro nella brughiera è assimilabile al criminale, allo scimmione preistorico che devia dalla civiltà. Il castello è una sorta di gigantesca camera chiusa, piena di trabocchetti, false piste. La cornice comune dei due generi è il fatto stesso di essere dei generi popolari, piegati alle esigenze di evasione e divertimento di un lettore moderno (dall’800 a oggi).
Eppure entrambi i generi hanno trovato un fertile terreno comune, generando dei romanzi o delle novelle sospese tra i due territori. Un punto comune potrebbe essere nella costruzione anti-psicologica, stereotipata dei caratteri e degli ambienti. Gotico e mystery lavorano su delle cornici ideali, su una serie di figure retoriche comuni e ripetibili all’infinito. Il mostro nella brughiera è assimilabile al criminale, allo scimmione preistorico che devia dalla civiltà. Il castello è una sorta di gigantesca camera chiusa, piena di trabocchetti, false piste. La cornice comune dei due generi è il fatto stesso di essere dei generi popolari, piegati alle esigenze di evasione e divertimento di un lettore moderno (dall’800 a oggi).
Ma osserviamo alcuni libri, ibridi ideali di terrore superstizioso e razionalismo, anche se, in definitiva, classici del mystery, plot narrativi in cui il soprannaturale è un sublime fumo negli occhi dei creduloni.
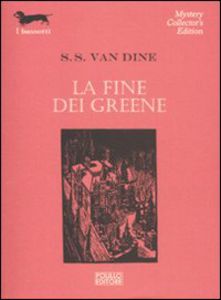 Tra i primi libri che mi vengono in mente (non parlerò, lo dico subito del mastino dei Baskerville; preferisco concentrarmi su romanzi meno noti, almeno sulla Zona) non posso non parlare de La fine dei Green di S. S. Van Dine, pseudonimo di Willard Huntington Wright, scrittore americano estremamente prolifico (caratteristica comune a molti giallisti dell’epoca d’oro), studioso di filosofia, giornalista e colto critico d’arte. Van Dine è uno dei maestri del giallo angloamericano, creatore del detective pomposo e dandy Philo Vance; Vance è straordinariamente colto e si considera un esperto in una varietà infinita di materie (pittura contemporanea, arazzi, psicologia, economia…). Nel 1928 Van Dine scrive una delle avventure più belle di Philo Vance, quel The Green Murder case, da noi tradotto come La fine dei Greene. La trama (e la copertina originale, con il disegno del palazzo dei Greene realizzato da Lowell L. Balcom – ripreso anche nell’edizione Polillo 2010) spiega quanto detto finora: una sontuosa dimora al 53rd Street di Manhattan, nel cuore di una delle megalopoli più moderne e scintillanti del mondo. Subito un contrasto stridente, tipico del gotico, che gioca tra continue oscillazioni tra antico e contemporaneo. La dimora dei Greene, pur senza esserlo, è l’equivalente di un castello, abitato da una delle più importanti famiglie della città, famiglia arricchita oltre ogni misura dal patriarca defunto Tobias, le cui disposizioni testamentarie obbligano i restanti membri della casata a dover restare sotto lo stesso tetto, pena la perdita dell’ingente eredità. Nel palazzo vivono la vedova di Tobias e i cinque figli, più i domestici. Tra ognuno di loro serpeggia l’odio e vecchie tare di famiglia. Presto inizieranno a morire uno a uno, uccisi in modi fantasiosi e creativi. A Philo Vance fermare la mano assassina. Ora, al di là della soluzione logica, ciò che colpisce è la capacita di Van Dine di costruire – attraverso uno stile in bianco e nero, che insiste su parole oscure, tombali – un affresco carico di pathos e angoscia, in perenne equilibrio tra le possibilità della ragione (illuminismo) e il peso rovinoso delle passioni (romanticismo); come in una sorta di remake letterario della casa Usher di Poe, Van Dine lavora di fino attorno ad una famiglia di banchieri e affaristi avidi e arricchiti, fautori del nuovo capitalismo cannibale che divorerà il XIX secolo; la colpa è questa, la loro avidità, i mezzi illeciti con cui si sentono di aver raggiunto la redenzione, la salvezza; tuttavia qualcosa dentro di loro si è guastato e sta degenerando nell’indolenza, e in altre tare omicide. La bellezza di questo giallo classico sta tutta qui, il resto (e mi riferisco al corredo horror) è pura messa in scena, artificio retorico. Dei Greene esiste una bellissima trasposizione televisiva, messa in cantiere dalla Rai, nel 1974: Vance è affidato a un ispiratissimo e inarrivabile Giorgio Albertazzi e la regia di Marco Leto lavora sul testo tetro e sinistro di Van Dine, accentuando le atmosfere orrorifiche.
Tra i primi libri che mi vengono in mente (non parlerò, lo dico subito del mastino dei Baskerville; preferisco concentrarmi su romanzi meno noti, almeno sulla Zona) non posso non parlare de La fine dei Green di S. S. Van Dine, pseudonimo di Willard Huntington Wright, scrittore americano estremamente prolifico (caratteristica comune a molti giallisti dell’epoca d’oro), studioso di filosofia, giornalista e colto critico d’arte. Van Dine è uno dei maestri del giallo angloamericano, creatore del detective pomposo e dandy Philo Vance; Vance è straordinariamente colto e si considera un esperto in una varietà infinita di materie (pittura contemporanea, arazzi, psicologia, economia…). Nel 1928 Van Dine scrive una delle avventure più belle di Philo Vance, quel The Green Murder case, da noi tradotto come La fine dei Greene. La trama (e la copertina originale, con il disegno del palazzo dei Greene realizzato da Lowell L. Balcom – ripreso anche nell’edizione Polillo 2010) spiega quanto detto finora: una sontuosa dimora al 53rd Street di Manhattan, nel cuore di una delle megalopoli più moderne e scintillanti del mondo. Subito un contrasto stridente, tipico del gotico, che gioca tra continue oscillazioni tra antico e contemporaneo. La dimora dei Greene, pur senza esserlo, è l’equivalente di un castello, abitato da una delle più importanti famiglie della città, famiglia arricchita oltre ogni misura dal patriarca defunto Tobias, le cui disposizioni testamentarie obbligano i restanti membri della casata a dover restare sotto lo stesso tetto, pena la perdita dell’ingente eredità. Nel palazzo vivono la vedova di Tobias e i cinque figli, più i domestici. Tra ognuno di loro serpeggia l’odio e vecchie tare di famiglia. Presto inizieranno a morire uno a uno, uccisi in modi fantasiosi e creativi. A Philo Vance fermare la mano assassina. Ora, al di là della soluzione logica, ciò che colpisce è la capacita di Van Dine di costruire – attraverso uno stile in bianco e nero, che insiste su parole oscure, tombali – un affresco carico di pathos e angoscia, in perenne equilibrio tra le possibilità della ragione (illuminismo) e il peso rovinoso delle passioni (romanticismo); come in una sorta di remake letterario della casa Usher di Poe, Van Dine lavora di fino attorno ad una famiglia di banchieri e affaristi avidi e arricchiti, fautori del nuovo capitalismo cannibale che divorerà il XIX secolo; la colpa è questa, la loro avidità, i mezzi illeciti con cui si sentono di aver raggiunto la redenzione, la salvezza; tuttavia qualcosa dentro di loro si è guastato e sta degenerando nell’indolenza, e in altre tare omicide. La bellezza di questo giallo classico sta tutta qui, il resto (e mi riferisco al corredo horror) è pura messa in scena, artificio retorico. Dei Greene esiste una bellissima trasposizione televisiva, messa in cantiere dalla Rai, nel 1974: Vance è affidato a un ispiratissimo e inarrivabile Giorgio Albertazzi e la regia di Marco Leto lavora sul testo tetro e sinistro di Van Dine, accentuando le atmosfere orrorifiche.
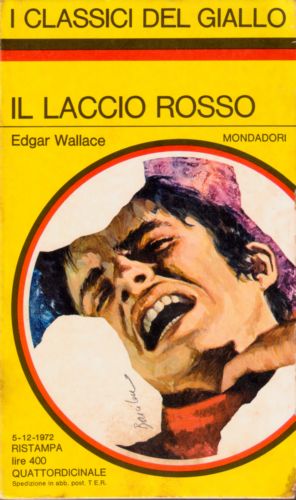 Altro autore immancabile per questo articolo è l’inglese Edgar Wallace, tra i più prolifici del genere e nome tutelare, assieme alla Christie e a Conan Doyle del mystery. Wallace sfornava romanzi in gran quantità, e la sua scrivania era sempre ingombra di fogli bianchi, bobine per dittafono e pacchetti di sigarette; uomo pigro, si vantava di non percorrere a piedi più di 4 chilometri all’anno e di servirsi sempre di un ascensore, anche se il suo studio si trovava al primo piano. Nella multiforme opera del nostro è interessante il romanzo Il laccio rosso, del 1932. Il romanzo è un mystery alquanto psicologico, in anticipo sulla degenerazione thrilling del giallo, operata nel corso degli anni ’40 e ’50 da autori come Fredric Brown, Woorlich, Charlotte Armstrong. Il laccio rosso, come i Greene, ruota attorno alla dimora dei Lebanon, antica famiglia inglese, che ha persino partecipato alle crociate. Qualcosa dentro la casa non funziona più e, anche qui, tare genetiche sembrano fare capolino tra i personaggi, descritti con piglio veloce e stereotipato (ma non è da intendersi come un difetto, non in questi generi) da Wallace. Lady Lebanon, madre castrante e altezzosa, araldo maestoso sottratto a un’epoca medievale finita da un pezzo, donna ferma autoritaria, capace di annientare psicologicamente il figlio inetto, Lord Willie. Attorno a loro dei maggiordomi e dei camerieri sospetti, dei guardiacaccia, degli ispettori di Scotland Yard, agenti dell’ordine. Una serie di delitti circondano il Priorato dei Lebanon, omicidi commessi nella medesima maniera, ossia strangolamenti con un “laccio rosso” appunto. Wallace scrive veloce, usa dialoghi brevi e dosa sapientemente i colpi di scena, tanto che il libro è leggibilissimo, per nulla invecchiato. Tuttavia, il merito più grande dello scrittore, è quello di costruire una vaga atmosfera di tensione (rumori misteriosi, scricchiolii nelle tenebre, mormorii) senza bisogno di ricorrere a qualche maledizione particolare. Tutto rimane nel non detto, nell’appena accennato: è chiaro che ci sia qualcosa di storto, di sbagliato nella famiglia, che interessi divergenti e vecchi traumi stanno portando alla rovina, però Wallace non calca la mano come Van Dine ne La fine dei Greene e lascia che gli omicidi (alcuni anche molto thrilling) si susseguano quasi senza senso, anticipando quasi la follia economica del mondo odierno. Da leggere nell’edizione Mondadori, uscita ne I classici del giallo n. 153, 1972.
Altro autore immancabile per questo articolo è l’inglese Edgar Wallace, tra i più prolifici del genere e nome tutelare, assieme alla Christie e a Conan Doyle del mystery. Wallace sfornava romanzi in gran quantità, e la sua scrivania era sempre ingombra di fogli bianchi, bobine per dittafono e pacchetti di sigarette; uomo pigro, si vantava di non percorrere a piedi più di 4 chilometri all’anno e di servirsi sempre di un ascensore, anche se il suo studio si trovava al primo piano. Nella multiforme opera del nostro è interessante il romanzo Il laccio rosso, del 1932. Il romanzo è un mystery alquanto psicologico, in anticipo sulla degenerazione thrilling del giallo, operata nel corso degli anni ’40 e ’50 da autori come Fredric Brown, Woorlich, Charlotte Armstrong. Il laccio rosso, come i Greene, ruota attorno alla dimora dei Lebanon, antica famiglia inglese, che ha persino partecipato alle crociate. Qualcosa dentro la casa non funziona più e, anche qui, tare genetiche sembrano fare capolino tra i personaggi, descritti con piglio veloce e stereotipato (ma non è da intendersi come un difetto, non in questi generi) da Wallace. Lady Lebanon, madre castrante e altezzosa, araldo maestoso sottratto a un’epoca medievale finita da un pezzo, donna ferma autoritaria, capace di annientare psicologicamente il figlio inetto, Lord Willie. Attorno a loro dei maggiordomi e dei camerieri sospetti, dei guardiacaccia, degli ispettori di Scotland Yard, agenti dell’ordine. Una serie di delitti circondano il Priorato dei Lebanon, omicidi commessi nella medesima maniera, ossia strangolamenti con un “laccio rosso” appunto. Wallace scrive veloce, usa dialoghi brevi e dosa sapientemente i colpi di scena, tanto che il libro è leggibilissimo, per nulla invecchiato. Tuttavia, il merito più grande dello scrittore, è quello di costruire una vaga atmosfera di tensione (rumori misteriosi, scricchiolii nelle tenebre, mormorii) senza bisogno di ricorrere a qualche maledizione particolare. Tutto rimane nel non detto, nell’appena accennato: è chiaro che ci sia qualcosa di storto, di sbagliato nella famiglia, che interessi divergenti e vecchi traumi stanno portando alla rovina, però Wallace non calca la mano come Van Dine ne La fine dei Greene e lascia che gli omicidi (alcuni anche molto thrilling) si susseguano quasi senza senso, anticipando quasi la follia economica del mondo odierno. Da leggere nell’edizione Mondadori, uscita ne I classici del giallo n. 153, 1972.
 Mary R. Rinehart è stata una delle più prolifiche autrici di gialli di tutti i tempi; una volta si lamentò del fatto di non riuscire a trovare una penna che riuscisse a scrivere tanto veloce quanto i suoi pensieri. Di questa grande autrice propongo il romanzo del 1942 Il pipistrello (The haunted lady), tradotto da Grazia Griffini ne I classici del giallo n. 541 della Mondadori. Il pipistrello narra della famiglia Fairbanks e della vecchia anziana signora Eliza Fairbanks, chiusa in una decrepita dimora e circondata da una scombinata famiglia di potenziali eredi: un figlio inetto e squattrinato, sua moglie, le nipoti. La vecchia è terrorizzata; qualcuno infatti ha già tentato di avvelenarla e ora cerca di spaventarla a morte, introducendo di notte nella sua camera topi e pipistrelli. Che stia impazzendo? Che si tratti di alcuni fantasmi? La Rinehart è unica nel costruire, da un plot semplice, un’atmosfera claustrofobica e d’attesa, giocata in bilico tra le infiltrazioni gotiche (i pipistrelli, simboli di un ultraterreno posticcio e di facciata) e una struttura classica da giallo ad enigma (le indagini sono condotte dall’ispettore Fuller e da un’infermiera soprannominata miss Pinkerton). Anche ne Il pipistrello, come nei Greene o nei Lebanon de Il laccio rosso, si ritrova una borghesia annoiata e corrotta, che ha esaurito il suo compito sociale (due rivoluzioni industriali giocate sulla pelle e sui diritti dei lavoratori) e si appresta ad appassire tra gli agi; le fortune gigantesche che hanno accumulato non sono pulite, bensì raggiunte per mezzo di artifici e soprusi; tuttavia le loro coscienze (almeno quelle dei padri fondatori) sono tranquille, cullate dalla logica della predestinazione (tutta americana) divina. Non possono dire lo stesso gli eredi di tali fortune, quasi sempre giovani senza nerbo, inetti e violenti, in preda a passioni evanescenti e distruttive. Il denaro è il vero moloch che muove tutto e dietro a pipistrelli, ombre o vampiri c’è sempre lui. Questa è la lezione più bella (e attuale) del mystery classico.
Mary R. Rinehart è stata una delle più prolifiche autrici di gialli di tutti i tempi; una volta si lamentò del fatto di non riuscire a trovare una penna che riuscisse a scrivere tanto veloce quanto i suoi pensieri. Di questa grande autrice propongo il romanzo del 1942 Il pipistrello (The haunted lady), tradotto da Grazia Griffini ne I classici del giallo n. 541 della Mondadori. Il pipistrello narra della famiglia Fairbanks e della vecchia anziana signora Eliza Fairbanks, chiusa in una decrepita dimora e circondata da una scombinata famiglia di potenziali eredi: un figlio inetto e squattrinato, sua moglie, le nipoti. La vecchia è terrorizzata; qualcuno infatti ha già tentato di avvelenarla e ora cerca di spaventarla a morte, introducendo di notte nella sua camera topi e pipistrelli. Che stia impazzendo? Che si tratti di alcuni fantasmi? La Rinehart è unica nel costruire, da un plot semplice, un’atmosfera claustrofobica e d’attesa, giocata in bilico tra le infiltrazioni gotiche (i pipistrelli, simboli di un ultraterreno posticcio e di facciata) e una struttura classica da giallo ad enigma (le indagini sono condotte dall’ispettore Fuller e da un’infermiera soprannominata miss Pinkerton). Anche ne Il pipistrello, come nei Greene o nei Lebanon de Il laccio rosso, si ritrova una borghesia annoiata e corrotta, che ha esaurito il suo compito sociale (due rivoluzioni industriali giocate sulla pelle e sui diritti dei lavoratori) e si appresta ad appassire tra gli agi; le fortune gigantesche che hanno accumulato non sono pulite, bensì raggiunte per mezzo di artifici e soprusi; tuttavia le loro coscienze (almeno quelle dei padri fondatori) sono tranquille, cullate dalla logica della predestinazione (tutta americana) divina. Non possono dire lo stesso gli eredi di tali fortune, quasi sempre giovani senza nerbo, inetti e violenti, in preda a passioni evanescenti e distruttive. Il denaro è il vero moloch che muove tutto e dietro a pipistrelli, ombre o vampiri c’è sempre lui. Questa è la lezione più bella (e attuale) del mystery classico.
 Vorrei segnalare ora un ottimo romanzo, Sotto la neve, di Jefferson Farjeon, scrittore inglese che lavorò presso periodici umoristici negli anni ’20 del ‘900; in seguito scrisse un’ottantina di romanzi, in prevalenza gialli, alcuni pubblicati con lo pseudonimo di Anthony Swift; Farjeon scrisse anche alcune sceneggiature cinematografiche, tra cui quella di Numero diciassette, un film diretto da Alfred Hitchcock nel 1932; nonostante l’estrema prolificità (comune a molti giallisti dell’epoca d’oro), Farjeon è abile nel coniugare trame ingegnose e intriganti con uno stile scorrevole e controllato. Sotto la neve (presentato in italiano, nella traduzione di Dario Pratesi, nelle edizioni Mystery collector’s edition di Marco Polillo Editore) è del 1937 ed è un ottimo esempio dell’arte di Farjeon: siamo alla vigilia di Natale e durante una tempesta di neve un treno viene bloccato in aperta campagna; alcuni passeggeri, stanchi di aspettare, decidono di raggiungere a piedi la stazione più vicina, ma si smarriscono e, ormai allo stremo delle forze, in balia d’una tormenta di neve, trovano rifugio in una villa isolata. Al suo interno non c’è nessuno, eppure il camino è acceso e la tavola è apparecchiata per il tè. In cucina il bollitore è sul fuoco e, curiosamente, c’è un coltello sul pavimento. Mentre i nuovi arrivati cercano di organizzarsi, alla villa giungono un anziano passeggero del treno, che mostrerà di possedere conoscenze medianiche inaspettate, e uno strano figuro che ha tutta l’aria di un avanzo di galera. Le sorprese non sono finite: sul treno dal quale sono scesi è stato commesso un delitto, nella casa troveranno una lettera dal significato oscuro e una camera del mistero. I fatti, com’è logico, precipiteranno nel delitto. Farjeon confeziona un romanzo che si legge d’un fiato ed è più avvincente del 99% della letteratura odierna (infarcita di psycho thriller anonimi e violenti). Qui l’autore gioca coi generi e infittisce il mystery coi colori dell’horror, giocando sugli stereotipi della casa disabitata, dimora di fantasmi isolata dagli effetti di una nevicata che ha lo scopo di separare e ritagliare i personaggi in uno sfondo metafisico e assoluto dal quale nessuno uscirà prima del finale. Un gioiello da recuperare!
Vorrei segnalare ora un ottimo romanzo, Sotto la neve, di Jefferson Farjeon, scrittore inglese che lavorò presso periodici umoristici negli anni ’20 del ‘900; in seguito scrisse un’ottantina di romanzi, in prevalenza gialli, alcuni pubblicati con lo pseudonimo di Anthony Swift; Farjeon scrisse anche alcune sceneggiature cinematografiche, tra cui quella di Numero diciassette, un film diretto da Alfred Hitchcock nel 1932; nonostante l’estrema prolificità (comune a molti giallisti dell’epoca d’oro), Farjeon è abile nel coniugare trame ingegnose e intriganti con uno stile scorrevole e controllato. Sotto la neve (presentato in italiano, nella traduzione di Dario Pratesi, nelle edizioni Mystery collector’s edition di Marco Polillo Editore) è del 1937 ed è un ottimo esempio dell’arte di Farjeon: siamo alla vigilia di Natale e durante una tempesta di neve un treno viene bloccato in aperta campagna; alcuni passeggeri, stanchi di aspettare, decidono di raggiungere a piedi la stazione più vicina, ma si smarriscono e, ormai allo stremo delle forze, in balia d’una tormenta di neve, trovano rifugio in una villa isolata. Al suo interno non c’è nessuno, eppure il camino è acceso e la tavola è apparecchiata per il tè. In cucina il bollitore è sul fuoco e, curiosamente, c’è un coltello sul pavimento. Mentre i nuovi arrivati cercano di organizzarsi, alla villa giungono un anziano passeggero del treno, che mostrerà di possedere conoscenze medianiche inaspettate, e uno strano figuro che ha tutta l’aria di un avanzo di galera. Le sorprese non sono finite: sul treno dal quale sono scesi è stato commesso un delitto, nella casa troveranno una lettera dal significato oscuro e una camera del mistero. I fatti, com’è logico, precipiteranno nel delitto. Farjeon confeziona un romanzo che si legge d’un fiato ed è più avvincente del 99% della letteratura odierna (infarcita di psycho thriller anonimi e violenti). Qui l’autore gioca coi generi e infittisce il mystery coi colori dell’horror, giocando sugli stereotipi della casa disabitata, dimora di fantasmi isolata dagli effetti di una nevicata che ha lo scopo di separare e ritagliare i personaggi in uno sfondo metafisico e assoluto dal quale nessuno uscirà prima del finale. Un gioiello da recuperare!
 La casa fantasma, edito da Polillo Editore nella Mystery collector’s edition nel 2008, tradotto da Bruno Amato, è un breve libricino composto da due racconti del 1907, “The Grinning god” di May Futrelle e “The House that was” di Jacques Futrelle. I Futrelle erano due coniugi scrittori. Lui lavorò come giornalista per il New York Herald e, successivamente, per il Boston American di William Randolph Hearst. In seguito si dedicò alla letteratura gialla, creando il personaggio del professor Van Dusen, insopportabile e scorbutico genio delle investigazioni. All’apice della fama, Jacques morì nel disastro del Titanic. L’ultima immagine che ci lascia di lui Mary (anch’essa a bordo del transatlantico, e tra i superstiti) è quella di un uomo in piedi, sul ponte già inclinato della nave, mentre fuma placido una sigaretta. Ma torniamo ai racconti. Quello di Mary è una classica storia di fantasmi, seguita dal contro-racconto del marito, che ricostruisce e spiega razionalmente gli avvenimenti soprannaturali inscenati da Mary. Nella prima parte della Casa fantasma abbiamo un uomo che si è perso, che è rimasto a secco, senza benzina, in balia di una tormenta. Pioggia, vento, una foresta scheletrica, forse le urla di una donna, e ancora una figura fluttuante, spettrale che s’aggira tra le piante. Poi appare una casa isolata, un cottage gotico abitato dalle ombre e da uno strano vecchio, che non parla, che appare e scompare e sembra un fantasma. Scoppierà pure un incendio e lo sventurato visitatore finirà pazzo in un manicomio, con un idolo d’avorio nelle tasche. Nella seconda parte, Van Dusen, scioglierà logicamente ogni enigma, portando la fiammella della ragione all’interno delle tenebre della superstizione. Divertissement letterario felice sia nello stile, godibile e moderno, che nel plot, sospeso tra horror e giallo ad enigma.
La casa fantasma, edito da Polillo Editore nella Mystery collector’s edition nel 2008, tradotto da Bruno Amato, è un breve libricino composto da due racconti del 1907, “The Grinning god” di May Futrelle e “The House that was” di Jacques Futrelle. I Futrelle erano due coniugi scrittori. Lui lavorò come giornalista per il New York Herald e, successivamente, per il Boston American di William Randolph Hearst. In seguito si dedicò alla letteratura gialla, creando il personaggio del professor Van Dusen, insopportabile e scorbutico genio delle investigazioni. All’apice della fama, Jacques morì nel disastro del Titanic. L’ultima immagine che ci lascia di lui Mary (anch’essa a bordo del transatlantico, e tra i superstiti) è quella di un uomo in piedi, sul ponte già inclinato della nave, mentre fuma placido una sigaretta. Ma torniamo ai racconti. Quello di Mary è una classica storia di fantasmi, seguita dal contro-racconto del marito, che ricostruisce e spiega razionalmente gli avvenimenti soprannaturali inscenati da Mary. Nella prima parte della Casa fantasma abbiamo un uomo che si è perso, che è rimasto a secco, senza benzina, in balia di una tormenta. Pioggia, vento, una foresta scheletrica, forse le urla di una donna, e ancora una figura fluttuante, spettrale che s’aggira tra le piante. Poi appare una casa isolata, un cottage gotico abitato dalle ombre e da uno strano vecchio, che non parla, che appare e scompare e sembra un fantasma. Scoppierà pure un incendio e lo sventurato visitatore finirà pazzo in un manicomio, con un idolo d’avorio nelle tasche. Nella seconda parte, Van Dusen, scioglierà logicamente ogni enigma, portando la fiammella della ragione all’interno delle tenebre della superstizione. Divertissement letterario felice sia nello stile, godibile e moderno, che nel plot, sospeso tra horror e giallo ad enigma.
 Vorrei chiudere (chiudere per modo di dire, visto che queste commistioni letterarie sono feconde nel giallo ad enigma; purtuttavia non posso annoiarvi troppo e incorrere nelle ire funeste del mio signore e padrone assoluto, boss Longoni) segnalando, sempre di Polillo Editore Il pappagallo bianco di Mignon Good Eberhart, scritto originariamente nel 1933. Ne Il pappagallo abbiamo un albergo dei delitti, dove vengono uccise varie persone e la polizia costringe gli occupanti a rimanerci dentro, onde evitare al colpevole di involarsi. La cosa interessante è l’atmosfera sospesa e irreale che l’autrice riesce ad infondere alle sue pagine; anzitutto un vento che sbatte contro l’albergo, e fa scricchiolare la struttura, le vecchie imposte, i rampicanti e gli arbusti stregoneschi che la circondano, formando un tutt’uno coi delitti, contribuendo a costruire un alone arcano e minaccioso che sospende la logicità della realtà e fa pensare a impalpabili maledizioni. La bellezza del romanzo sta qui, in questa capacità evocatoria ed espressionista, affidata agli effetti del vento perenne e delle finestre che sbattono, senza bisogno di ricorrere, in maniera esplicita, a leggende di spettri maligni e menomati, costretti ad aggirarsi per l’eternità, tra le pagine vetuste di questi ardenti gialli d’epoca. Amen!
Vorrei chiudere (chiudere per modo di dire, visto che queste commistioni letterarie sono feconde nel giallo ad enigma; purtuttavia non posso annoiarvi troppo e incorrere nelle ire funeste del mio signore e padrone assoluto, boss Longoni) segnalando, sempre di Polillo Editore Il pappagallo bianco di Mignon Good Eberhart, scritto originariamente nel 1933. Ne Il pappagallo abbiamo un albergo dei delitti, dove vengono uccise varie persone e la polizia costringe gli occupanti a rimanerci dentro, onde evitare al colpevole di involarsi. La cosa interessante è l’atmosfera sospesa e irreale che l’autrice riesce ad infondere alle sue pagine; anzitutto un vento che sbatte contro l’albergo, e fa scricchiolare la struttura, le vecchie imposte, i rampicanti e gli arbusti stregoneschi che la circondano, formando un tutt’uno coi delitti, contribuendo a costruire un alone arcano e minaccioso che sospende la logicità della realtà e fa pensare a impalpabili maledizioni. La bellezza del romanzo sta qui, in questa capacità evocatoria ed espressionista, affidata agli effetti del vento perenne e delle finestre che sbattono, senza bisogno di ricorrere, in maniera esplicita, a leggende di spettri maligni e menomati, costretti ad aggirarsi per l’eternità, tra le pagine vetuste di questi ardenti gialli d’epoca. Amen!






























