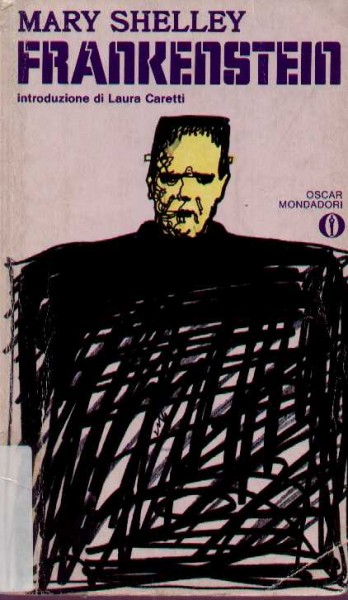 Ok, quanti film su Frankenstein, l’immonda creatura partorita dalla fervida immaginazione di Mary Shelley, vi siete puppati in vita vostra? Sicuramente tanti. E quanti di voi hanno letto il libro della Shelley? Mmmh, vedo poche mani alzate… (in effetti vedo solo il monitor in questo momento…). Effettivamente “Frankenstein (o il Prometeo moderno)” – reperibile in diversi formati e pubblicato da Mondadori – non è un libro che di solito si è portati a ricercare in libreria. Probabilmente perché è da molti associato a una pomposità e a una prolissità tipici dell’800 a cui non siamo più abituati. Per questi motivi penso che molti siano automaticamente portati a evitarlo come la peste. Ed è sicuramente un peccato, perché è un’opera sicuramente godibile (e soprattutto leggibile) ancora oggi, scorrevole e ricca di metafore interessanti, nonostante sia ambientata in un’epoca ormai lontana, fatta di carrozze sobbalzanti e lumi a olio, di salassi a base di sanguisughe e di malattie fulminanti che tolgono dal mondo da un giorno all’altro…
Ok, quanti film su Frankenstein, l’immonda creatura partorita dalla fervida immaginazione di Mary Shelley, vi siete puppati in vita vostra? Sicuramente tanti. E quanti di voi hanno letto il libro della Shelley? Mmmh, vedo poche mani alzate… (in effetti vedo solo il monitor in questo momento…). Effettivamente “Frankenstein (o il Prometeo moderno)” – reperibile in diversi formati e pubblicato da Mondadori – non è un libro che di solito si è portati a ricercare in libreria. Probabilmente perché è da molti associato a una pomposità e a una prolissità tipici dell’800 a cui non siamo più abituati. Per questi motivi penso che molti siano automaticamente portati a evitarlo come la peste. Ed è sicuramente un peccato, perché è un’opera sicuramente godibile (e soprattutto leggibile) ancora oggi, scorrevole e ricca di metafore interessanti, nonostante sia ambientata in un’epoca ormai lontana, fatta di carrozze sobbalzanti e lumi a olio, di salassi a base di sanguisughe e di malattie fulminanti che tolgono dal mondo da un giorno all’altro…
Un’opera scritta in maniera magistrale e densa di significati che vanno ben al di là del semplice conflitto fra “normalità” e deformità, fra Vita e Morte, fra Bene e Male. Sono un tale fan di questo vero e proprio classico della letteratura mondiale che proporrei di metterlo come testo di base nei licei dove si studia l’inglese, magari al posto del solito “La fattoria degli animali” di Orwell (autore che pure amo svisceratamente: oltre a “1984” leggetevi anche “Una boccata d’aria” per una lezioncina su come si scrive davvero), o delle stucchevoli opere di tanti misconosciuti racconta-fiabe anglosassoni…
Narra la leggenda che una notte d’estate del 1816 quattro letterati, fra cui due poeti e due scrittori, si riunirono nella villa Diodati nei pressi del lago di Ginevra in Svizzera. I poeti erano Lord George G. Byron (l’unico ad aver allora già raggiunto una certa fama) e Percy B. Shelley. I letterati erano John William Polidori e Mary Wollstonecraft Godwin. Costretti dal tempo inclemente a chiudersi fra quattro mura, queste “anime inquiete” per passare il tempo cominciarono a raccontarsi storie di fantasmi e del terrore. Ben presto però Byron gettò il guanto della sfida: ognuno di loro si sarebbe misurato nella stesura su carta di una vera e propria storia dell’orrore frutto del suo ingegno. Una vera e propria gara fra intellettuali, insomma.
Byron cominciò la stesura di “Mazeppa”, un breve poema su un personaggio realmente esistito nella Polonia del XVII secolo. La storia narra di un giovane che viveva alla corte del re polacco Giovanni Casimiro che un giorno venne scoperto a letto con la moglie di un nobile e venne torturato dal marito per giorni e giorni, riuscendo però a tornare più forte e potente di prima e addirittura a vendicarsi del proprio carnefice. Il “Mazeppa” venne pubblicato per la prima volta nel 1818.
Polidori , dottore in medicina e quindi molto avvezzo a fatti di emoglobina, scrisse l’inizio del suo “Il vampiro”, macabra opera che presenta l’archetipo di tutti i vampiri-dandy successivi (venne pubblicato nel 1819), “Dracula” di Bram Stoker compreso. Fra l’altro, dato che Polidori lo scrisse sulla base di una traccia dell’amico Byron, il libro venne per anni erroneamente attribuito al ben più famoso poeta inglese, padrone di villa Diodati. Mentre il signor Shelley si dedicava a un oscuro componimento poetico di cui si persero ben presto le tracce, colei che sarebbe presto diventata sua moglie, Mary, iniziò quello che avrebbe preso il nome di “Frankenstein (o il Prometeo moderno)”. Prometeo, come saprete, nella mitologia greca fu quell’uomo che rubò il fuoco agli déi per donarlo ai suoi simili e che per questo venne severamente punito da Zeus (il “fuoco” di “Frankenstein” sarebbe l’elettricità).
Il romanzo della Shelley in ogni sua pagina riecheggia di quello spirito romantico che aveva dominato per tutto il XVII secolo, fuso però alla perfezione con una robustissima dose di gotico. Genere quello gotico che aveva cominciato a fare proseliti a partire dalla fine del ‘700. Infatti si fa comunemente risalire la nascita della letteratura gotica con l’uscita nel 1784 del romanzo di Horace Walpole “Il castello di Otranto”, che fu tradotto in italiano – guarda un po’ – proprio dal padre di Polidori, Gaetano Polidori.
Da quel momento in poi “Frankenstein” si sviluppò nelle mani della sua autrice in maniera quasi autonoma e venne infine terminato e dato alle stampe nell’aprile 1817.
Il libro si apre con la disperata ricerca della “Cosa” da parte del Dr. Victor Frankenstein nei ghiacci antartici. Non riuscendo a catturarla, l’uomo viene soccorso da una nave spacca-ghiaccio che si trova a transitare per quei luoghi desolati. Quindi Frankenstein confessa al comandante della nave tutta la storia che lo ha portato ad attraversare mezzo mondo conosciuto per ritrovare la sua “creatura” e vendicarsi finalmente di lei. Ma – naturalmente – si guarda bene dall’arrivare subito al punto (dopotutto ne va della suspance!), prendendola molto alla larga e preferendo parlare prima della propria infanzia trascorsa all’ombra rassicurante di un casato nobiliare di Ginevra, del suo amore per la sorellastra Elizabeth e della sua avventura all’Università di Medicina di Ingolstadt a fianco dell’amico Clerval.
Proprio qui a Ingolstadt avviene in Victor quel cambiamento che lo porterà a infrangere le barriere della Scienza accademica, della Natura e del buon senso. Avvenimento che lo porta a intraprendere un torbido cammino all’interno delle forze più invisibili e terribili della Natura, fatto di disseppellimenti di cadaveri (da notare che il cervello della “creatura” di Frankenstein non è affatto anormale, come successivamente divulgato al cinema) e di esperimenti notturni e segretissimi condotti nei propri appartamenti di studente. Finalmente, dopo due anni di infinite prove fallite, Frankenstein riesce a dar vita alla sua “creatura”, ma, spaventato dall’orripilante aspetto e dall’apparente incapacità di comportarsi “normalmente” di questa (è addirittura muta), la scaccia.
Il “demonio” – come da questo momento verrà quasi sempre chiamato – comincia così la propria odissea, di cui i punti culminanti sono:
1) l’incontro con una famiglia di contadini apparentemente pacifici, nel cui granaio “la cosa” si nasconderà per un po’ a loro insaputa, spiandoli da una fessura nella parete, spettatore impotente di tutte le loro gioie e dei loro crucci. Una specie di televisione ante litteram, però con la (grande) differenza che in questo modo “la cosa” riesce a imparare il linguaggio umano (riesce a leggere perfino “I dolori del giovane Werther” di Goethe e le “Vite” di Plutarco). Quando però “il mostro” deciderà di rivelarsi alla famiglia per quello che è verrà cacciato anche da essa;
2) l’assassinio del fratellino minore di Victor, William, del quale viene accusata la domestica di casa Justine. La donna, ricattata dal “demonio”, finirà per essere giustiziata in sua vece: è infatti lui il vero colpevole;
3) il desiderio della “creatura” di avere accanto a sé una compagna sua simile che possa comprenderlo e condividere con lui una vita insieme. Il “mostro” minaccia di uccidergli l’amata Elizabeth, che Victor sta per sposare, se lui non lo esaudirà (“Sarò con te la notte delle tue nozze” è il messaggio che gli fa trovare), ma Frankenstein preferisce fuggire con la donna a Londra;
4) l’uccisione di Elizabeth da parte del “demone” e il successivo processo a carico di Victor che ne è considerato l’artefice. Victor viene liberato, ma suo padre appena saputa la notizia dell’uccisione della figliastra muore di un colpo apoplettico. Victor parte in direzione dei ghiacci nordici, verso i quali lo conducono le orme lasciate dalla sua “creatura”…
Recenti studi da parte del professor Christopher Goulding hanno avanzato l’ipotesi che Mary Shelley si sia ispirata per il personaggio del Dr. Victor Frankenstein a un amico del marito e cioè allo scienziato inglese James Lind (1736-1812). Lind era un naturalista molto esperto nelle recenti scoperte sull’applicazione dell’elettricità (propose l’applicazione dell’elettroshock per curare la pazzia di re Giorgio III) e fu probabilmente lui che indicò i fenomeni elettrici come soluzione per spiegare la nuova vita (o non-vita) della “cosa” di Frankenstein.
La fine del ‘700 era l’epoca dei primi esperimenti sull’elettricità. Fenomeno che attraeva molto l’attenzione di tutto il mondo accademico e che di lì a poco avrebbe contribuito alla nascita di numerose vere e proprie scienze indipendenti l’una dall’altra. Importanti e conosciutissimi sono gli esperimenti condotti da Benjamin Franklin. Esperimenti che furono ripresi dai più eminenti scienziati di tutta Europa, fra i quali svettarono le figure degli inglesi Watson e Cavendish e del nostro Luigi Galvani (1737-1798). Molti di voi si ricorderanno degli esperimenti che Galvani faceva sulle rane morte, applicando ai loro arti posteriori elettrodi che, messi in tensione, ne provocavano la temporanea contrazione. Su queste basi Galvani formulò la teoria dell’elettricità animale che ipotizzava che in tutti gli esseri viventi è presente una carica elettrica naturale, la quale può essere “azionata” semplicemente mettendo un “ponte” fra le terminazioni nervose, che così cominciano a dimenarsi “spontaneamente”. Anche James Lind, il presunto ispiratore della figura del Dr. Frankenstein, era esperto di questa pratica e fervente sostenitore dell’elettricità animale. Non era stata ancora scoperta l’alta conducibilità dei metalli e tanto meno si parlava di elettroni. Questa teoria venne successivamente completamente confutata da Volta, che cancellò l’idea dell’esistenza di un’elettricità innata negli esseri viventi.
Il Dr. Frankenstein, dunque, coi suoi esperimenti disumani a base di scariche elettriche e semi-conduttori, non avrebbe fatto altro che “chiudere il circuito” delle terminazioni nervose dell’uomo, stabilendo così un “riciclo di energie” capace di donare la vita eterna.
Parlando di cinema, il film più vicino al romanzo della Shelley è sicuramente il “Frankenstein” girato da Kenneth Branagh (1994), con un’irriconoscibile De Niro nei muscoli della “creatura” e con lo stesso Branagh nei panni di Victor. Pur non avendo riscosso grandissimo successo, è sicuramente quanto di più fedele all’opera originale della Shelley si può chiedere, seguendo la trama del libro passo passo dall’inizio alla fine. Che ci volete fare? Il Frankenstein partorito dalla penna della celebre scrittrice inglese è esattamente così! Se volete proprio prendervela con qualcuno riesumate la Shelley! In ogni caso quando la pigliate non fatele troppo male, dato che a massacrarla ci ha già pensato per benino il grande Mel Brooks con “Frankenstein Junior” (un mito in terra), con Gene Wilder nel camice del Dr. FrankenstIn e Peter Boyle a impersonare la “cosa” (più di recente visto come il padre stronzo e razzista di Billy Bob Thornton in “Monster’s Ball”). Non possiamo inoltre non citare comunque, per dovere di cronaca, i due cicli dedicati alla “creatura” dalla Universal negli anni Trenta (con Boris Karloff) e dalla Hammer (con Christopher Lee e Peter Cushing) negli anni Settanta.
Tornando alla letteratura, fortemente debitore dell’opera più famosa della Shelley è sicuramente H.P. Lovecraft (un uomo, un mito letterario) col suo “Herbert West: rianimatore” (1922).
La “creatura” di Frankenstein, o se preferite “la cosa”, “il mostro” o “il demone”, è il frutto di un lavoro costante e amorevole del suo “fattore” Victor. Questo DEMONE (termine che viene dal greco “eudaimon”, cioè “posseduto dal buon spirito”, dall’unione di “eu”=prefisso che significa “buono” e di “dai mon”=”fortunato”) è stato costruito e cucito, arto dopo arto, organo dopo organo, quasi come fosse puro frutto dell’invincibile desiderio del suo creatore (non a caso il nome di Frankenstein è Victor). In questa “nascita” può essere visto il faticoso gesto dello scrittore o del poeta di “assemblare”, frase dopo frase, dialogo dopo dialogo, un’opera letteraria. Nascita dicevamo, o “ri-nascita”: anche in letteratura, per parafrasare il celebre scienziato Lavoisier, “nulla si crea e nulla si distrugge” ma tutto si trasforma. Proprio come l’elettricità.
PREMIO ITALIA 2015:
- MIGLIOR SAGGIO
PREMIO ITALIA 2016:
-MIGLIOR SITO
-MIGLIOR RACCONTO
-MIGLIOR SAGGIO
PREMIO ITALIA 2021:
-MIGLIOR SITO
PREMIO SIDIOUS 2017
ASSOCIATO A:






























