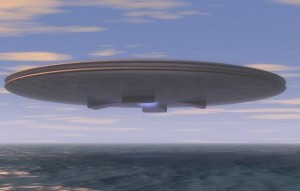Prologo
Tarda Età Imperiale Romana. Nei pressi di Metaponto.
Giunto in contatto con l’atmosfera l’oggetto si infuocò.
Il tracciato fiammeggiante, a metà del cielo buio, curvò in modo innaturale come fosse comandato a distanza lambendo con un sibilo meccanico la linea orizzontale del mare che riluceva piatto sotto una luna rotonda. L’oggetto era ancora in corsa quando la vampa cessò trasudando sulla superficie una patina di schiuma verde luminescente che la ricoprì per intero. Infine, concluse il rapido tragitto nella putrida landa acquitrinosa nei pressi della foce del fiume Bradano, laddove una volta avevano dominato floride le colonie magnogreche protette dai maestosi templi dorici. Tutto avvenne a poca distanza da quella che era stata la splendida Metaponto, città oramai decaduta a poco più che un villaggio. A Uranus, che nella campagna notturna stava ultimando le immagini di un vaso a cratere da donare a sua sorella Aelia in occasione del matrimonio con un funzionario locale dell’imperatore Diocleziano, sembrò quasi che la bizzarra scia nel cielo, dalla gradazione corallo prima e verde fosforescente dopo, gli cadesse addosso.
Sebbene molto giovane Uranus, per la sua abilità, da Roma a Taranto sino a Reggio Calabria, era onorato e noto come il Pittore dell’antica Metapontum.
Il giovane artista rimase affascinato da quella prodigiosa linea di colori cangianti venuta dall’alto e, considerandola un segno propizio degli Dei per l’imminente matrimonio, ne catturò l’istante riportandolo sul vaso a figure rosse.
L’immagine che eternizzò sul manufatto artistico fu fedele a quanto da lui visto: in primo piano la divina traccia sfiorava i santuari greci in rovina; sullo sfondo troneggiava ammaliante il Mar Jonio; le acque del Bradano che discendevano dalle colline dell’entroterra si perdevano nell’immensa distesa palustre.
Finito il lavoro Uranus, curioso di natura, si avventurò nella palude per andare a vedere il miracolo caduto dal cielo.
I due corpi straziati nel canale di bonifica
Era una mattina di sole temperato di fine marzo. Nei giorni precedenti aveva piovuto senza tregua e i campi della Piana jonica erano allagati.
C’era una calma solo apparente, poiché i temporali non parevano essere affatto finiti.
L’area di campagna, alle spalle della stazione ferroviaria di Metaponto lido, pullulava di forze di pubblica sicurezza. La vice commissaria di polizia, Ida Veneri, sul bordo del canale adduttore che smaltiva le ultime acque della piena, assisteva immobile, le mani giunte dietro, alle ripetute immersioni dei sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco, giunti dal comando di Matera. I movimenti appena percettibili delle sue narici, un po’sudate, tradivano nervosismo.
Sebbene avesse il copricapo d’ordinanza con sotto la chioma corvina raccolta a crocchia e la divisa le desse un tono severo, Ida Veneri, non riusciva a nascondere la sensualità del suo corpo attraente che spesso l’aveva messa a disagio, tanto più quando era nell’esercizio delle sue funzioni.
Uno dei sub risalito dal canale, aveva rinvenuto altri resti: “Questa volta si tratta di un portafogli”, asserì presentando l’oggetto infangato.
“Me lo dia pure, vediamo se riusciamo a dare un nome a quest’altro sventurato risucchiato dall’idrovora”, sentenziò la bella questurina.
Tirò fuori una tessera d’identità: il nome, Alvaro Acqui, corrispondeva a quello dell’amministratore unico del Consorzio di bonifica.
“Dunque” sentenziò “appartenevano entrambi all’ente consortile”.
Tra i cronisti ero stato il primo e per ora, fortunatamente, ancora l’unico, ad arrivare sul luogo grazie al mio privilegiato contatto.
“Mi conferma che l’altro corpo stritolato appartiene al capo zona che coordinava i lavori di riattamento del canale di adduzione?”, le chiesi mentre prendevo appunti sul mio taccuino.
“Sì, con l’amministratore unico devono essere venuti a controllare qualcosa che non andava, forse alla potente idrovora sotterranea e sono stati risucchiati nel bocchettone, che porta acqua alle adiacenti vasche, finendo straziati tra le eliche”.
“Ma l’impianto era a norma? Non esisteva una griglia protettiva? E come mai due persone certamente non alle prime armi si sarebbero fatte sorprendere come principianti?”
“Calma, calma signor Bini” rispose lei “non sia impaziente! Tutto sarà verificato. Per prima cosa si tratta di un’idrovora obsoleta pertanto non era provvista dei meccanismi automatici di sicurezza. Inoltre, è possibile che uno dei due si sia sporto troppo sul bordo perdendo l’equilibrio e l’altro abbia tentato di aiutarlo… al momento siamo solo alle supposizioni”.
“E se qualcuno li avesse spinti dentro?”, insinuai.
“Lei è il solito cronista smaliziato e sospettoso, Bini. Certo, potrebbe anche essere così. Ma per ora lasciamo stare le notizie ad effetto finalizzate a vendere qualche copia in più di giornale!”, rispose brusca la vice commissaria.
“Excusez moi madame!”, dissi, schermendomi con le mani in avanti e con un risolino forzato.
Ciò detto Ida Veneri fece cenno a un agente di sollevare il lenzuolo che ricopriva i resti dei due.
Una smorfia di ribrezzo le attraversò il viso. Lo spettacolo era agghiacciante anche se per me, che da ex volontario dell’Esercito italiano avevo partecipato a diverse peacekeeping operations, la cosa filò via come ordinaria amministrazione, considerando le carneficine cui avevo assistito.
A uno era troncata di netto la testa mentre il corpo appariva un ammasso deforme di carni; l’altro, con il volto ancora riconoscibile, sebbene sfigurato, era letteralmente spezzato in tre tronconi.
Rimanemmo a studiarli per un po’ mentre di tanto in tanto venivano fuori da sottacqua, galleggiando nel canale, alcuni poveri resti. Altri erano già stati recuperati finanche sulle sponde del Basento, in cui si immetteva il canale, che correva verso il Mar Jonio, distante poche centinaia di metri.
“Non ho mai amato lo spezzatino”, dissi, mentre scattavo alcune foto.
“Si risparmi le sue consuete battute di cattivo gusto Bini e magari, visto il suo acume, ci dica qualcosa che possa essere utile alle indagini. E, soprattutto, eviti di scattare foto prima che arrivi il magistrato, così non mi farà pentire di averla informata per primo”, aggiunse con sguardo complice la vice commissaria. Quindi ordinò di ricoprire i cadaveri.
Poco dopo giornalisti di ogni risma, me compreso ovviamente, si aggiravano sul posto assetati di voci e notizie.
Raccolsi qualche altra informazione e tornai a Policoro, in redazione, per scrivere il pezzo.
Tra le onde dello Jonio
 Osservava rapito la grande massa d’acqua azzurra con lo sciabordio delle onde lievi che si disfacevano pigre sulla battigia. Era come se dal mare giungesse un coro di voci celesti che lo richiamavano. Il sole sfolgorava in alto, al centro del cielo, lanciando i suoi dardi rilucenti a picco sulla superficie.
Osservava rapito la grande massa d’acqua azzurra con lo sciabordio delle onde lievi che si disfacevano pigre sulla battigia. Era come se dal mare giungesse un coro di voci celesti che lo richiamavano. Il sole sfolgorava in alto, al centro del cielo, lanciando i suoi dardi rilucenti a picco sulla superficie.
Pitagora raccolto nei pensieri guardava l’orizzonte aperto a Levante, che si stagliava color cobalto in profondità. Era solo sulla spiaggia lunga e bianca, lo Jonio sembrava respirare.
Al Tempio di Hera i suoi discepoli, che lo aspettavano per ascoltarne il verbo, dopo una lunga attesa decisero di cercarlo proprio mentre lui metteva il primo piede nell’acqua limpida per raggiungere il sacro confine fra cielo e terra.
Procedeva lento con lo sguardo lusingato dalle fissità meridiane.
La tonaca inzuppata d’acqua si faceva pesante, ma lui avanzava, come in trance, verso la purificazione. L’acqua gli giunse al torace, poi al collo e iniziò a lambirgli la lunga barba bianca. Mancava poco per l’ultimo gesto che l’avrebbe portato alla catarsi. Si sarebbe lasciato annegare in quel divino mare degli dei.
L’acqua salata gli superò le labbra, il naso, gli occhi. Proseguì. Protese le braccia in aria con le palme aperte in segno di adorazione. Rimanevano fuori le mani dai polsi in su e iniziò a inghiottire acqua. Lo prese la nausea e i conati e inghiottì ancora e ancora! Oramai annaspava e anche le mani erano sottacqua.
Ma successe qualcosa.
Una forza possente lo sollevò. Si librò nell’aria. Gli sembrò di essere in un ampio tubo diafano e luminoso. Saliva come aspirato a velocità vertiginosa verso l’alto e vedeva allontanarsi sempre di più il mare sotto di lui. Allora guardò in alto e nella confusione del momento vide una gigantesca sagoma scura ellittica sospesa nel cielo.
Emetteva un segnale acustico ripetitivo e volteggiava nell’aria via via sollevandosi.
Stranito, si ritrovò dentro perfettamente asciutto.
Era al centro di un ambiente asettico che gli parve un edificio di culto.
Non vi erano aperture e tutto, dal pavimento alle pareti al soffitto, aveva lo stesso tono giallo ocra con ovunque cerchi che contenevano altri cerchi sempre più piccoli, di colore arancione, che roteavano emanando luci magnetiche.
Poi con un guizzo la scura sagoma ellittica svirgolò nel cielo scomparendo nella direzione opposta al Sole.
Il tombarolo Vito Ingannamorte
Driiin, driiinn…
“Sì?”
“Ennio Bini?”
“Chi parla?”
“Bini, sono Ingannamorte”
“Ué, dimmi…”
“Ci possiamo vedere subito?”.
Era Vito Ingannamorte noto tombarolo di origini baresi.
Ultrasessantenne, segaligno, con le dita inanellate e ingiallite dalla nicotina, era eternamente vestito come un ragazzo degli anni ’70: pantaloni attillati e giacche strette. Sembrava la brutta copia di Renato Vallanzasca da giovane.
Personaggio inquieto ma di fine intelligenza, figlio di NN, aveva vissuto sino alla prima giovinezza in collegio e stava anche per conseguire la maturità classica quando in una rissa, per motivi di donne, aveva accoltellato un rivale, finendo in carcere.
Lì aveva conosciuto il fior fiore della malavita del capoluogo pugliese. Uscito traviato di galera, aveva continuato quelle pessime frequentazioni divenendo irrecuperabile. Poi, per motivi ancora poco chiari – pare che avesse fatto parte di un commando che aveva gambizzato un avvocato del foro barese – si era ritirato agli inizi degli anni ’80 in Basilicata, nel Metapontino, area allora tranquillissima. Qui aveva stabilito il centro dei suoi affari.
Per ovvi motivi all’epoca della galera Ingannamorte aveva dovuto interrompere gli studi. Comunque da personaggio torbido, ma curioso e, a suo modo, geniale, era rimasto un appassionato di studi classici e soprattutto di archeologia.
Così, non avendo potuto fare l’archeologo, aveva fatto il tombarolo.
Un tombarolo, per così dire, colto.
Lavorava in proprio e in oltre trent’anni di onorata carriera aveva saccheggiato necropoli magnogreche su tutto l’Arco jonico, divenendo ricco.
La sua telefonata mi era giunta inattesa a notte fonda mentre stavo chiudendo il pezzo sulla sciagura dell’idrovora.
Chiese di incontrarmi, facendo riferimento a quello che era accaduto.
Non era uno da poco e sapeva quello che diceva, per cui assentii subito.
Ci demmo appuntamento nell’autorimessa sotterranea dello stabile in cui, al primo piano, era ubicata la redazione. Giunsi al suo gigantesco Suv Mercedes di ultima generazione grigio fumé: un’offesa alla decenza. Attesi un attimo.
Nella penombra, da dietro un pilastro, una voce che riconobbi mi chiamò. Mi avvicinai.
“La brutta fine dei due non è fortuita”, esordì Ingannamorte, una vecchia volpe dai modi spicci. Era nella mezza luce dei neon.
“Fammi capire bene…”, chiesi immediatamente.
“Sono stati gettati nell’idrovora. Non ci sono finiti. Volevano fare i furbi ma non era mestiere loro!”, aggiunse secco.
“E non erano lì per motivi di lavoro…”, osservai.
“Cercavano tesori!” ribatté pronto Ingannamorte, sputacchiando per terra. Era, quello, il suo intercalare.
Lo sollecitai “Ok! Continua”.
“Tu sai, amico mio – pensai che non ero suo amico e mai avrei voluto esserlo - che opero con serietà nel settore da decenni…”, attaccò lui serio con una inflessione ibrida tra il pugliese e il lucano. Avvertii un’infernale alitosi. Mi posi a distanza di sicurezza, ma non bastò.
“E sei sempre sulla cresta dell’onda.”, aggiunsi tra il serio e il faceto.
“…sono un professionista! Io!!”
“Ne sono convinto…”, non so quanto il mio tono poté apparire beffardo.
“Ho soldi in abbondanza! Qui sta mettendo radici una malavita locale giovane e feroce: i Tremamunno, con collegamenti a Taranto. Non per paura, ma per me non è più aria. E poi c’ho pure una certa età e voglio ritirami dal giro, ma non prima di contribuire a una clamorosa scoperta che mi riscatti e mi riabiliti”, dichiarò convinto.
“E allora sono tutt’orecchi, ma mettiti dalla parte sinistra che dall’orecchio destro ho qualche problema”, gli dissi.
Una notizia sensazionale
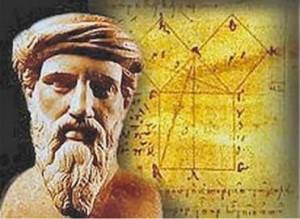 Ingannamorte si accese una sigaretta, scatarrò, poi attaccò con la storia. Mi raccontò che il Consorzio di bonifica stava effettuando lavori di ripristino di una parete laterale in vecchia muratura del canale adduttore. Era crollata per le incessanti precipitazioni. Ciò proprio nei pressi del bocchettone dell’idrovora sotterranea.
Ingannamorte si accese una sigaretta, scatarrò, poi attaccò con la storia. Mi raccontò che il Consorzio di bonifica stava effettuando lavori di ripristino di una parete laterale in vecchia muratura del canale adduttore. Era crollata per le incessanti precipitazioni. Ciò proprio nei pressi del bocchettone dell’idrovora sotterranea.
Mentre stavano lavorando con la pala meccanica, dopo aver tirato su terreno ceduto e cemento sbriciolato, la benna aveva impattato uno strato tufaceo semisommerso da depositi di melma e acqua. Insomma, tra il materiale di risulta erano spuntati alcuni pezzi di vasi antichi. Il capo zona, Canio Zolla, aveva fatto interrompere i lavori e avvisato l’amministratore consortile, Alfio Acqui. Il pomeriggio stesso, con nessun altro nel cantiere, si erano recati sul posto a verificare di cosa si trattasse.
Si erano resi conto di essere all’ingresso di una tomba o un tempio sotterraneo.
Con la pala meccanica avevano estratto altro materiale ed erano venuti alla luce vasi, statuette e altri preziosi oggetti.
Avevano anche notato che lo scavo sembrava avere un’altra porta bloccata da una lastra di roccia calcarea. Comunque, da quello che sembrava un vestibolo affiorò, ancora integro, un vaso molto pregiato a cratere con alcune figure rosse: vi era ritratta una specie di meteora che cadeva dal cielo tra i templi in rovina, con lo sfondo del mare, infine sotto vi era la scritta IPSE DIXIT.
“Tu che hai fatto le scuole alte”, mi disse con affilata ironia Ingannamorte aspirando una lunga boccata alla bionda che aveva tra il pollice e l’indice, “saprai che era il motto di Pitagora”. Lasciai perdere l’acida espressione del tombarolo e cercai nella memoria dei miei confusi ricordi liceali
“Certo il motto latino Ipse dixit, che deriva dal greco Autos epha e che tradotto in italiano significa lo ha detto lui”.
“Quindi ciò significa che potrebbe anche essere… la Sua tomba”, asserì Ingannamorte.
“Già” dissi ancora scettico senza fare volutamente il nome per scaramanzia “ma se il motto è scritto in latino vuol dire che risalirebbe a un periodo di gran lunga successivo alla sua scomparsa…”.
“Occupandomi del settore da una vita, ho fatto le scoperte più impensabili. Ed è possibile che i resti siano stati risistemati o rinvenuti altrove e sepolti lì nel periodo romano”, replicò l’uomo.
La notizia già mi ribolliva nella mente e intuii che doveva essere solo l’inizio di qualcosa di ben più straordinario
“Vuoi dire che la Tomba di Pitagora, di cui tanto si è favoleggiato e che sembra una leggenda, potrebbe essere reale?”
“Pare proprio di sì!”, confermò Ingannamorte mordicchiandosi le unghie da tipo tosto. Certo, questa sì che era musica, poteva essere la scoperta del secolo, per la miseria!
La telefonata a Palmo Scavafossi
 “E poi che è successo?”, chiesi al tombarolo.
“E poi che è successo?”, chiesi al tombarolo.
“Entrambi, Acqui e Zolla, li conoscevo bene, erano soci in affari oltre che scommettitori con grossi debiti di gioco, decisero che avrebbero tentato di ricavare quanti più soldi possibili dal rinvenimento. Tra l’altro, non era la prima volta che gli capitava di trovare materiale archeologico e, che, invece di segnalare la cosa alla Sovrintendenza contattavano me. Ricoprirono accuratamente con la pala meccanica l’apertura e mi avvisarono, per negoziare, portandomi quale prova della scoperta il prezioso vaso. Chiedevano però una cifra esagerata per una cosa di cui non si conosceva l’entità. Così gli dissi di aspettare e, come per le altre volte, di non parlarne a nessuno. Al momento avrei preso solo il vaso, che peraltro pagai profumatamente”.
“E allora, come mai sono finiti male?”, la storia si faceva sempre più avvincente.
“Seppi che dopo di me si erano rivolti ai Tremamunno. Quelli sono spietati e li hanno fatti secchi per prendersi il bottino senza pagare nulla, pauh!” concluse lanciando lontana la cicca e sputando ancora una volta per terra, mentre sfilavo il piede per non farmi centrare la scarpa.
Erano tante le domande che mi frullavano nella mente.
Cosa fare? Andare sul posto a cercare direttamente, oppure avvisare la polizia? Ci si poteva fidare di Ingannamorte senza mettersi nei guai? Gli interrogativi mi turbinavano nel cervello.
“Posso vedere questo prezioso vaso?”, gli chiesi.
“Eccome no!”.
Aprì il cofano del suo arrogante Suv. Coperto da un plaid e in un cubo rivestito da un telo di plastica ben protetto da polistirolo c’era il vaso.
Era assolutamente fantastico. Molto più grande e solido di quello che avevo immaginato. Integro, come aveva detto Ingannamorte, e soprattutto dai colori neri e rossi che quasi luccicavano come fossero stati dipinti il giorno prima.
Promanava un alone mistico e un grande fascino, avvolto com’era dal mistero. La scritta IPSE DIXIT, in caratteri decisi e le figure plastiche raffigurate completavano la decorazione.
“Certo che, senza togliere nulla a te” gli dissi “se lo portassimo da uno studioso ci potrebbe dire chi lo ha realizzato e magari quali sono i segreti che cela”.
Ebbi un lampo di genio. Avrei interpellato Palmo Scavafossi mio amico e grande erudito dell’antichità, nonché unico e convinto assertore della reale esistenza della Tomba di Pitagora. Da sempre, infatti, egli era impegnato nella ricerca della sepoltura del filosofo greco, convinto che esistesse davvero e che non fosse solo frutto di fantasie. Per questo era anche sbeffeggiato soprattutto dalla comunità accademica.
Palmo, inoltre, conosceva ogni centimetro della Piana metapontina.
Conosceva a memoria studi e ricerche del prof. Dinu Adamesteanu, pioniere dell’archeologia nella zona che aveva fatto straordinarie scoperte di necropoli e santuari.
Colto, solipsista e anche bizzarro Palmo Scavafossi lavorava, appartato, al Marta, il Museo nazionale archeologico di Taranto. Era stato una grande promessa dell’archeologia, ma, come spesso avviene per le grandi promesse, tale era rimasto.
“Sempre che” ripresi “non ci anticipino i Tremamunno. Occorre muoversi per evitare che portino a segno la razzia, casomai ci fosse realmente altro materiale prezioso”.
“Tranquillo Bini. Li conosco bene i Tremamunno. Dopo quello che è avvenuto, sapendo che la zona pullula di polizia si terranno qualche giorno alla larga finché le cose si calmano e poi agiranno”.
“Allora telefonerò a Palmo e domattina stessa andremo da lui”, proposi.
“No probblem” disse in un inglese improbabile annuendo.
Poi sputò a terra. E andò via. Mi sembra superfluo dire che non salutò.
Sul Magnifico Pianeta Zkyon
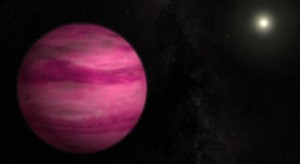 Pitagora aveva riaperto gli occhi sereno e subito gli era venuta alla memoria la gigantesca sagoma scura ellittica sospesa nel cielo sopra lo Jonio. Adesso era disteso, o meglio adagiato, in una specie letto semicilindrico antracite ondulato e avvolgente. Dal tessuto di un viola laccato traforato e morbido fuoriusciva un flusso odoroso. L’atmosfera da vuoto pneumatico era rarefatta e ovattata. Si trovava in uno stato di piacevole sospensione. Sembrava non ci fosse gravità. La prima cosa che aveva visto guardando fuori erano stati tre corpi celesti grossi come lune che si stagliavano nel cielo. Posizionati obliquamente uno dietro l’altro, a equa distanza, brillavano di luce riflessa con diverse tonalità di colori che andavano dal giallo zolfo del primo, all’ambra del secondo, sino al color ruggine del terzo. I colori che venivano generati in quel cielo potevano essere paragonati a quelli di uno stupendo tramonto contrassegnato dai gialli e dai rossi, velato dai lilla, e dai viola. Lo scenario era sorprendente, ma i tre corpi celesti vicini testimoniavano che, certamente, egli non si trovava nella sua Metaponto, né tantomeno nel suo Mondo. Si chiese se fosse morto annegato nel Mar Jonio e se adesso avesse raggiunto l’Olimpo, la casa di suo padre, il Dio Apollo. Si alzò, aveva indosso la sua tunica di un bianco più candido che mai. Posò un piede sul pavimento, poi anche l’altro.
Pitagora aveva riaperto gli occhi sereno e subito gli era venuta alla memoria la gigantesca sagoma scura ellittica sospesa nel cielo sopra lo Jonio. Adesso era disteso, o meglio adagiato, in una specie letto semicilindrico antracite ondulato e avvolgente. Dal tessuto di un viola laccato traforato e morbido fuoriusciva un flusso odoroso. L’atmosfera da vuoto pneumatico era rarefatta e ovattata. Si trovava in uno stato di piacevole sospensione. Sembrava non ci fosse gravità. La prima cosa che aveva visto guardando fuori erano stati tre corpi celesti grossi come lune che si stagliavano nel cielo. Posizionati obliquamente uno dietro l’altro, a equa distanza, brillavano di luce riflessa con diverse tonalità di colori che andavano dal giallo zolfo del primo, all’ambra del secondo, sino al color ruggine del terzo. I colori che venivano generati in quel cielo potevano essere paragonati a quelli di uno stupendo tramonto contrassegnato dai gialli e dai rossi, velato dai lilla, e dai viola. Lo scenario era sorprendente, ma i tre corpi celesti vicini testimoniavano che, certamente, egli non si trovava nella sua Metaponto, né tantomeno nel suo Mondo. Si chiese se fosse morto annegato nel Mar Jonio e se adesso avesse raggiunto l’Olimpo, la casa di suo padre, il Dio Apollo. Si alzò, aveva indosso la sua tunica di un bianco più candido che mai. Posò un piede sul pavimento, poi anche l’altro.
Una vertigine lo colse quando guardò di sotto e vide che poggiava sul nulla o meglio su qualcosa di trasparente che lo sosteneva. Senza fiato balzò nuovamente sul letto semicilindrico. Si accorse di essere sull’apice di una torre altissima, forse di cristallo, a pianta quadrata. Intorno il panorama del territorio era monocromatico di un colore indaco e alla prima impressione non si trattava di acqua, ma di terreno solido.
In lontananza, quasi a toccare quella volta celeste innaturale, spiccavano i profili di vette tubiformi e con vasti antri, come tane, all’interno. Vi fuoriuscivano, volando, apparecchi meccanici di varie forme geometriche che non aveva mai visto e che prendevano varie direzioni. Osservò uno di questi, esagonale, che dall’esterno si attaccò, incastonandosi perfettamente nella parete trasparente. Poi un’armonia sublime si diffuse in quell’ambiente surreale. Era una ritmica con scansioni intervallate e tempi regolari. Il Maestro non riusciva a capire quale genere di strumento potesse produrla. Sembrava il preludio a un’apparizione che subito dopo si verificò. Pitagora sgranò gli occhi, dall’oggetto esagonale si proiettarono i contorni di una figura affilata di uno strano essere dalla testa bislunga, e sicuramente non aveva le sembianze di un dio antropomorfo!
La love story con Ida Veneri e la mia voglia di avventura
Chiamai Palmo al quale, nei limiti di ciò che potevo dirgli per telefono, riferii. Egli comprese subito l’importanza di quanto gli andavo dicendo. Rimase un po’ senza parlare.
Poi mi disse: “Ho motivo di credere che il rinvenimento sia a dir poco eccezionale. Vi aspetto”.
La cosa era seria quindi, e la frase di Palmo Scavafossi mi confermò che dovevo avvisare la mia referente nella polizia.
Senza indugiare ulteriormente composi il numero di telefono di Ida Veneri, anche se era notte inoltrata.
“Commissario?”
“Purtroppo per me c’è ancora un vice che precede il titolo”, la sua voce un po’ assonnata tradiva, seppur lievemente, irritazione.
“Il mio era un auspicio…”,
“Lasciamo perdere, Signor Asso della cronaca, mi sembrava strano che non ti fossi ancora fatto sentire”,
“E dai, tesoro, ho lavorato sodo sinora e anche per te”, replicai sulla difensiva.
“Non mi chiamare tesoro. Piuttosto com’era la tipa con la quale hai lavorato sodo: rossa, bionda o mora”?
“Ida non scherzare! Comunque mi piacciono le mediterranee, quindi, mi piaci tu! Possiamo vederci?”.
“Sì, ma non ti sognare di provarci!”, ammonì conoscendomi.
“Prometto sul mio onore!”
“Quale onore!”
“Vabbé, prometto e basta.”
Conclusi sbrigativamente il pezzo di cronaca, lasciando passare la morte dei due per un incidente sul lavoro. Per ora era bene tenere le cose tranquille e non suscitare sospetti di sorta. Nell’articolo non mancavo di evidenziare come le forze dell’ordine “avevano prontamente avviato le indagini…”
Con Ida ci eravamo conosciuti a Bari, alla Facoltà di Scienze politiche che avevamo frequentato insieme. Avevamo anche avuto una lunga love story.
Dopo la laurea, ero assetato di avventura, volevo fare il reporter di guerra e decisi per un master in giornalismo partendo alla volta di Roma. Avevo quindi lasciato giù Ida, assicurandole che quanto prima sarei rientrato. Ma, concluso il master, avevo iniziato la dura gavetta giornalistica nella Capitale con collaborazioni precarie a giornali di ogni genere.
Tuttavia, nonostante l’abnegazione quotidiana, la paga era scarsa e sporadica.
Così, non sopportando più di quella vita grama e anche per dare fiato al mio spirito d’avventura mi ero arruolato nell’Esercito, dimenticando completamente la bella fidanzata. Non ero divenuto un reporter, ma ero finito carrista nel Genio militare, spedito in Iraq prima e in Afghanistan dopo. Paga ottima, puntuale e tanta avventura. Tanta al punto che, in un’attività di pattugliamento con una colonna afghana, nei pressi della base avanzata di Bala Baluk, eravamo stati bersagliati da colpi di mortaio. Ne ero uscito per miracolo, ammaccato, ma vivo, divenendo però quasi sordo. Ero stato rispedito in Italia e costretto a concludere la mia carriera militare.
Poi c’era stata la riabilitazione e il ritorno alla scrittura: avevo raccolto la mia esperienza di guerra pubblicata con il titolo Quattro passi tra le mine. Così con qualche soldo – ma non troppi – in tasca ero pronto a ricominciare. E proprio grazie al mio racconto autobiografico sulla guerra, che aveva riscosso discreti consensi di critica e pubblico, avevo recuperato quella collaborazione a La Gazzetta del Giorno di Taranto, come responsabile della pagina del Metapontino (invero ero l’unico corrispondente). Pertanto ero tornato nella mia Policoro: una volta Heraklea, gloriosa colonia magnogreca, ora ridente cittadina jonica.
Insomma, per tornare a Ida, un po’ per vocazione (visto che era figlia di un questore) un po’ per ripicca nei miei riguardi, anche lei si era arruolata, ma in polizia. La nostra storia era finita lì. Poi lei, dopo un lungo peregrinare, era stata assegnata al Commissariato di Scanzano Jonico e ci eravamo ritrovati.
Da allora si era stabilito uno strano rapporto tra noi.
Di quelli tra due persone che si odiano e si amano, si ritrovano con un conto in sospeso e si studiano perché non sanno ancora bene cosa sarà di loro. Comunque, in pubblico, ci davamo sempre del lei.
Nella Villa Peripato di Taranto
Quando al mattino Ingannamorte l’aveva vista, era trasalito.
Non si aspettava che avrei messo al corrente la vice commissaria Ida Veneri. Non sapeva del nostro rapporto, per così dire personale, e soprattutto della impegnativa promessa che, nottetempo, Ida mi aveva strappato affinché lei accogliesse la mia richiesta di unirsi a noi, naturalmente senza la copertura della centrale di polizia.
Tra l’altro la bella e severa poliziotta, sebbene quel giorno fosse in borghese, faceva sempre un effetto… marziale. Ingannamorte si era tranquillizzato quando Ida gli aveva riferito che non aveva informato nessuno della Questura per non creare “inutili allarmismi e congetture”. Aveva acceso una sigaretta in auto ma Ida lo aveva rimbrottato e lui era rimasto seduto in religioso silenzio per tutto il tempo del percorso acquattato sul sedile posteriore della mia mitica Alfa 156.
Sicuramente, avevo pensato, il tombarolo era taciturno anche per una sorta di deferenza istintiva che le mele marce hanno verso le forze dell’ordine. E tanto più se si tratta di una donna fascinosa, come appunto Ida, che aveva dalla sua in modo naturale quell’alterigia dovuta da una parte alla rigida educazione familiare e dall’altra al ruolo che ricopriva.
L’Alfa Romeo 156 1.8 Twin spark era un ricordo di mio zio Evaristo, meticoloso e ricco ingegnere. Il passaggio a miglior vita dello zio era coinciso con il mio ritorno a Policoro. Ero mal ridotto e mio cugino Filippo – sempiterno seduttore col quale mi ero conteso il titolo di sciupafemmine della Costa, attribuzione di cui oggi mi rimaneva solo la nomea e i baffetti da sparviero – non sapendo cosa farsene di quello che considerava un catorcio se n’era disfatto donandomelo. Il veicolo, anno di costruzione 2001, con poche migliaia di chilometri, sempre in garage, di un grigio metallizzato lustratissimo, aveva ancora i residui di cellophane dentro e quel tipico odore di seminuovo che hanno le vetture curatissime. Una vera signora, anche se un po’ datata. Insomma era quello che, al momento, potevo permettermi.
Palmo Scavafossi ci aspettava a Villa Peripato, storica oasi di verde nel centro di Taranto, nei pressi del Museo archeologico. Era nella piazzetta centrale di fronte all’austero busto dedicato a Pitagora. Lo guardava incantato. Sicuramente era attraversato dai suoi soliti visionari pensieri. Come sempre si muoveva a scatti, pieno di tic nervosi. Quando ci vide arrivare, senza farci avvicinare troppo, con la sua andatura schizzata, prese a camminare facendo cenno di seguirlo verso la balconata che dava sul Mar Piccolo. Ci fermammo in un luogo sufficientemente appartato, protetto da una lussureggiante vegetazione risalente agli inizi del secolo scorso, su una balconata che si sporgeva nel mare incorniciato da un cielo terso che sembrava acquerellato.
“Le Sue illuminazioni hanno fornito le basi alla filosofia e alla scienza rendendolo immortale e quel busto, che vengo a venerare quotidianamente è la sua immagine perfetta!”, esordì enfatico Palmo Scavafossi, facendoci un fulmineo movimento con la testa.
Ida mi guardò di sottecchi incuriosita, nascondendo a malapena un sorrisetto.
Le feci un cenno con la mano, sapevo che Palmo era comico nelle movenze e ridondante nell’oratoria.
“Parli di…”, non terminai sapendo già a chi si riferiva.
“…del Maestro dell’antichità per antonomasia: Pitagora!”, continuò lui.
Pitagora era il suo chiodo fisso. Poi sembrò tornare in sé.
“Caro Ennio come te la passi? Ho saputo dell’episodio in Afghanistan, stavi per saltare in aria e te la sei cavata con un timpano infranto. Vecchia quercia, nessuno può abbatterti!”, mi disse battendomi la spalla da vecchio amico.
“Beh, certe volte mi sembra che un treno in corsa mi passi a pochi centimetri dall’orecchio destro, ma per il resto è ok!”.
Lo presentai a Ida che evidentemente dovette piacergli non poco (ero sempre un po’ geloso di lei) visto che non le lasciava più la mano, e a Ingannamorte che notai inquieto e che continuava ad accendersi una cicca dietro l’altra.
Spiegai a Palmo tutto quanto in modo circostanziato, poi quando gli mostrammo il vaso, trepidò: “E’ un vaso a cratere, decorato da Uranus, il Pittore dell’antica Metapontum. La sua impronta è inconfondibile!” assicurò divenendo rosso in volto. Gli occhi gli brillavano per l’emozione. Poi lo accarezzò. Sembrava quasi adorarlo. “Se è come credo siamo vicini a una svolta nella storia e non solo dell’archeologia!”, affermò senza togliere lo sguardò dal vaso. “Vi spiego. Anni fa decifrai una pergamena latina, in verità malridotta, che parlava di Uranus. Nella parte leggibile del vecchio documento era riportato che il pittore era morto sprofondando negli acquitrini di Metaponto dove si era avventurato. Probabilmente, così riportava la pergamena, era stato incuriosito da una meteora che aveva visto cadere dal cielo e che aveva raffigurato su questo vaso, menzionato nel documento. Ma vi è da aggiungere che il corpo fu ritrovato vicino alla meteora che, per quanto ho capito, proprio un sasso cosmico non era”.
“E di cosa si poteva trattare?”, intervenni.
“Non so, non si comprende bene. Come ho detto mancavano dei pezzi della pergamena. Comunque ci sono alcuni termini che potrebbero fare riferimento a un qualcosa di artificiale e comunque un oggetto volante… fabbricato, caduto dallo spazio, oggetto che si riferirebbe plausibilmente a Pitagora. E qui entra in ballo il vaso. Infatti, la scritta Ipse dixit, aggiunta in seguito da un’altra mano è impropria rispetto alle figure dipinte, ma testimonia il collegamento diretto con il filosofo greco”.
“Dicevi di un oggetto, per così, dire… alieno?”
“…forse no… ma forse sì!”
“Comunque il luogo di ritrovamento del cadavere di Uranus e della meteora, per quanto zona disagevole, divenne, luogo sacro di pellegrinaggio”, aggiunse Palmo.
“Le spoglie di Uranus sarebbero sepolte lì?”.
“Sì. Fu cremato come usava allora per le persone di censo elevato, e tumulato con molte sue opere. E soprattutto insieme a quella cosa che divenne oggetto di culto. Ma nella parte di pergamena che ho studiato non si fa riferimento al posto. Sicuramente era nel pezzo mancante. Poi, nei secoli seguenti, l’area fu abbandonata e ricoperta dalle acque paludose, che inghiottirono anche il presunto tempio.
Insomma, dato che Uranus fu tumulato – con i suoi vasi – nel luogo sacro, è probabile sia proprio quello dov’è stato ritrovato il presente prezioso vaso. Il tempio misterioso sarebbe lì!”.
“Ritieni che potrebbe trattarsi della Tomba di Pitagora?”
“Anche di qualcosa in più di una semplice tomba!!”
Direzione Metaponto
 Non c’era tempo da perdere. Se le ipotesi di Palmo Scavafossi si fossero rivelate vere non osavo credere a quello che avremmo potuto rivelare al mondo.
Non c’era tempo da perdere. Se le ipotesi di Palmo Scavafossi si fossero rivelate vere non osavo credere a quello che avremmo potuto rivelare al mondo.
Ci precipitammo tutti e quattro alla mia Alfa, dovevamo raggiungere quanto prima Metaponto. Filai agile nel traffico denso e appiccicoso di Taranto, passando davanti all’imponente Prefettura fascista che dominava il lungomare e che, come la fortezza Bastiani descritta da Buzzati ne Il deserto dei Tartari, dava l’impressione di essere sospesa nel tempo. Poi fu la volta dell’Ilva. Il siderurgico si allungava inquietante lungo la costa, inframmezzato da depositi di carburanti e ciminiere gigantesche che levavano nel cielo colonne di fumo concentrato. In sottofondo su Radio Futuro Sud andava Lullaby un brano di fine anni ‘80 dei Cure, dalle atmosfere molto dark.
La musica che si espandeva nell’auto, pressata da onde magnetiche, moltiplicava gli interrogativi in ognuno di noi, mentre la voce nevrotica del leader della band, Robert Smith, sembrava interpretare perfettamente il nostro momento di eccitazione e ansia. Sentivo sempre più il rischio del fosco e del recondito, ma come sempre nella mia vita, non riuscivo a stare lontano dai guai. Nessuno parlava, Ida mi era accanto con la sua rincuorante presenza, Palmo Scavafossi e Vito Ingannamorte erano dietro. Il primo muoveva la testa a scatti più del solito, l’altro masticava nervosamente una gomma (gliel’avevo data io nel tentativo di evitare che la sua alitosi infestasse nuovamente l’abitacolo dell’auto) tenendosi stretto tra le braccia l’imballo con dentro il vaso di Uranus. La strada era libera e vuota. L’asfalto correva liscio sotto i copertoni dell’Alfa di zio Evaristo che, sebbene avesse i suoi anni suonati, sfrecciava a 170 chilometri orari sulla Statale 106 Jonica. Dallo spartitraffico centrale sembravano venirci incontro, variopinti, i cespugli di oleandri. Sul lato sinistro il bacino dello Jonio limpido era uno spazio metafisico. Tutt’intorno si estendevano rigogliosi, squadrati e irrigati modernissimi impianti di frutteti e vigneti a tendone. Sui bordi della Statale si susseguivano esuberanti piante di fichi d’india, palme ed eucalipti.
La ricerca dell’Essere Perfetto su Zkyon
Un’ombra filiforme, dell’altezza doppia del Maestro, prese consistenza dall’esterno dell’esagono. I contorni erano appena visibili e dentro, uniforme, si distingueva una materia mucosa come fosse una medusa ma con la superficie di una corteccia di albero che si muoveva impercettibilmente. Da quella materia lattiginosa viva proveniva un ronzio come regolato da microscosse elettriche che di tanto in tanto riverberavano. Poi la creatura emise un gorgoglio e Pitagora che si era alzato in piedi, con voce per niente intimorita, chiese: “Dove sono e tu chi sei?”
L’essere filiforme allora sembrò assorbire e rielaborare i suoni e la voce di Pitagora.
Un istante dopo ripeté con lo stesso tono e la stessa voce le parole del Maestro greco, poi la figura emise delle radiazioni luminose che contornarono Pitagora. Quindi i raggi fecero ritorno verso l’essere che cominciò a mutare forma e qualche istante dopo Pitagora aveva di fronte il suo sosia.
Il neo Pitagora con tono solenne parlò: “Sei sul Magnifico pianeta Zkyon. Io sono uno dei diciassette Designati al suo governo e tu sei nostro ospite.”
“Ma tu sei me… come hai fatto a prendere il mio aspetto e la mia voce?”, domandò l’uomo ancora incredulo.
“Noi zkyoniani non abbiamo una forma precisa e ci adeguiamo alle caratteristiche di chi abbiamo di fronte”, ribatté sereno il sosia.
Pitagora ancora confuso si tastò il corpo per avere conferma che fosse vivo.
Poi ci fu una lunga pausa nella quale la mente del Maestro, addestrata com’era al ragionamento, spaziò tra mille pensieri. Erano troppe le domande che avrebbe voluto porre, ma pensò che avrebbe avuto tutto il tempo per soddisfare le sue infinite curiosità.
Allora soggiunse “Ma io che faccio qui?”
“Tu fai parte di una razza, quella umana, che noi zkynioniani osserviamo da molte epoche. La vostra è una specie che reputiamo imperfetta, come del resto lo siamo noi, ma molto interessante e dotata. Sappiamo inoltre che tu sei uno dei grandi sapienti tra gli uomini del tuo tempo e per questo sei qui con noi. Raduniamo su Zkyon i luminari più importanti di tutti i mondi conosciuti per dare vita all’Essere Perfetto e in questo tu ci aiuterai”.
“Credo che vi deluderò. Non ho ancora molti elementi, ma mi sembra chiaro che la vostra società è molto più evoluta della nostra che al confronto sembra primitiva”, controbatté perplesso Pitagora
“Non angosciarti, umano, ognuno dei grandi dotti dei vari mondi porterà il suo contributo nell’ambito delle sue conoscenze. Seguimi e non dubitare”. Quindi aggiunse bonario: “Qui il tempo non è limitato come da voi, siamo ospitali e pacifici. Ti troverai bene.”
Inseguimento sulla Jonica
Dallo specchietto retrovisore vidi una Bmw. La berlina, di un nero lucido, si avvicinava ad alta velocità. Giunta a pochi metri lampeggiò. Superai la linea di mezzeria facendomi di lato sulla corsia destra, continuando nella mia corsa. La Bmw rallentò e si pose dietro, molto vicina. Era praticamente incollata alla mia Alfa.
“Ma guarda questo idiota come mi sta appiccicato dietro”, inveii.
Ida si girò a guardare preoccupata.
“Sono in tre e hanno delle facce poco raccomandabili”, disse estraendo dalla borsa la sua scintillante Beretta 92 Sb, tenendola abbassata accanto alla gamba destra. Pigiai l’acceleratore. Il contachilometri segnò i 180 per poi sfiorare i 190, più di così non potevo, eravamo in quattro e la mia auto era vecchia. Al primo tamponamento un fanalino volò sul fondo stradale. Quindi la Bmw si fece sul mio fianco e mi strinse sul bordo della Statale fiancheggiandomi e tamponandomi ancora per farmi accostare.
La mia Alfa sbandò e sculettò. Tenni fermo il manubrio per non uscire di strada.
“Tenetevi forte!”, urlai mentre le vene della testa mi martellavano il cervello.
“Se fossi stato con il mio Suv e non co ‘sto ferrovecchio li spedivo direttamente ad arare nei campi questi infamoni, pauh!”, sbraitò Ingannamorte.
“Zitto, abbassa la testa e proteggi il vaso di Uranus piuttosto! Anche tu Palmo abbassati sul sedile!”, dissi mentre pigiavo a tavoletta l’acceleratore.
Conservai la calma. Sentivo la puzza del motore forzato a tutta velocità. I copertoni mangiavano l’asfalto. Tenni la strada.
“Bastardi, avanzi di galera!” urlò Ida mentre puntava la Beretta verso la Bmw nera che a quel punto rallentò. Passarono pochi istanti ed erano di nuovo al nostro fianco. Fui io questa volta a deviare sulla sinistra tamponando lateralmente la Bmw, che sbandò sfiorando il guard rail, provocando scintille, per rientrare prontamente in corsia, intanto che dai finestrini spuntavano dei mitra.
Inchiodai i freni e l’Alfa emise un ululato pauroso mentre le sventagliate di mitra andavano a vuoto. Sentii i pneumatici che si scioglievano sul catrame.
Eravamo dietro l’auto nera. Allora Ida, stupendomi, come un navigato guerrigliero, si sporse dal finestrino e sparò alle ruote della Bmw facendole scoppiare. L’auto sfondò il guard rail di destra e come un dardo schizzò fuori strada schiantandosi su una casa colonica diroccata. Ci fu un fragore.
I rottami della Bmw erano fuoco e fiamme.
“Però!…” dissi compiaciuto alla volta di Ida.
“… le donne in polizia non stanno per fare l’uncinetto!” replicò secca lei.
Poi continuò:“ Ma chi erano?”
“Killer dei Tremamunno!! E’ evidente che quei due sciagurati di Acqui e Zolla gli avranno detto di me e mi tenevano d’occhio. Ci avranno seguiti e quando hanno capito che andavamo diretti verso la meta hanno pensato bene di farci fuori”, sentenziò Ingannamorte.
“Ma avevano fatto mali i conti”, replicai mentre l’orecchio mi fischiava da morire e riportavo l’acceleratore a tavoletta.
Affanni
 Giungemmo a Metaponto. Ci fermammo sul bordo del canale di bonifica mentre il motore della 156 di zio Evaristo fumava e gemeva penosamente. Considerai l’auto che una volta era stata perfetta: era inguardabile. Mio zio, ne ero certo, si stava rivoltando nella tomba. Frattanto si erano addensate nuvole minacciose e in men che non si dica iniziò a diluviare. Dovevamo sbarrare il corso del canale per evitare che la corrente lo sommergesse ancora e travolgesse una volta per tutte il tempio distruggendo tutto quanto di unico e prezioso presumibilmente conteneva.
Giungemmo a Metaponto. Ci fermammo sul bordo del canale di bonifica mentre il motore della 156 di zio Evaristo fumava e gemeva penosamente. Considerai l’auto che una volta era stata perfetta: era inguardabile. Mio zio, ne ero certo, si stava rivoltando nella tomba. Frattanto si erano addensate nuvole minacciose e in men che non si dica iniziò a diluviare. Dovevamo sbarrare il corso del canale per evitare che la corrente lo sommergesse ancora e travolgesse una volta per tutte il tempio distruggendo tutto quanto di unico e prezioso presumibilmente conteneva.
“Se continua così l’adduttore rischia di saturarsi di acqua e divenire impraticabile e allora sì che sarà difficile individuare il punto che cerchiamo”, sostenne allarmata Ida.
“Potremmo sempre azionare l’idrovora sommersa così che aspiri una parte d’acqua”, propose Vito Ingannamorte.
“Mmm… l’idea non è malvagia anche se mi sembra pericoloso, visto lo spezzatino di ieri”, gli risposi.
“Basta tenersi alla larga”, disse il tombarolo.
Quindi aggiunse: “Comunque, da quello che mi avevano spiegato Acqui e Zolla, l’apertura del presunto tempio dovrebbe essere sotto la massicciata crollata, a pochi metri dall’idrovora, sulla destra del canale, scendendo verso il mare”.
Mentre parlavamo, in modo oramai sempre più concitato, la pioggia cadeva a catinelle e il canale si andava ingrossando a vista d’occhio.
“Ok, allora Ida, tu che hai l’arma fai saltare la porta della cabina di controllo dell’idrovora”.
“Agli ordini mio capitano”, mi rispose imitando ironicamente un gesto di saluto militare. Oramai condividevamo la stessa pericolosa situazione ed erano saltati gli orpelli delle formalità in pubblico.
Esplose tre colpi di seguito, e la porta (aveva i sigilli per le indagini) si spalancò. Mi introdussi nella cabina. Non mi ci volle molto ad azionarla, vista la mia multiforme esperienza nell’Arma del Genio dove, oltre a manovrare bulldozer corazzati, realizzare opere difensive e strutture logistiche, avevamo acquisito dimestichezza con tutti i tipi di congegni meccanici. Salii sulla pala meccanica e iniziai dopo qualche brusca manovra a scaricare materiale nel canale. In breve, grazie alla notevole capacità di carico della benna riuscii a creare, con il terreno, i pezzi di cemento e altro materiale di risulta, un argine apparentemente stabile che deviava il corso dell’acqua del canale adduttore. Tra l’altro con la potente idrovora in funzione, che assorbiva acqua gettandola nelle vasche, ottenemmo che il flusso del condotto si riducesse.
L’argine, comunque, non poteva durare a lungo visto il volume d’acqua che si andava ingrossando. Quando la parte che ci interessava fu quasi prosciugata, con Vito Ingannamorte individuammo il punto dove Acqui e Zolla avevano ricoperto l’apertura dell’antro. Sebbene non fosse agevole lavorare dal bordo del canale, addentrai la benna nella base del condotto cercando di fare meno danni possibili.
Palmo Scavafossi, con i movimenti delle mani mi indicava se andare avanti o indietro, rallentare o intensificare l’azione di sterro. Ci fu un cedimento e la benna andò a vuoto.
Allora sentii strillare Palmo: “Stop, stoop. Basta cosìì. Ci siamoo!”.
Avevamo portato alla luce il vestibolo. Ora ci toccava esplorare ciò che si nascondeva dietro la solida lastra di pietra tufacea. Con l’agile pala meccanica fu un gioco da ragazzi.
Affondai la benna sul lato e sollevai. La lastra si filò in due parti, ma feci in tempo a posarla sul letto del canale. Con un balzo scesi dalla pala meccanica.
Ida, Ingannamorte e Palmo erano sul bordo dell’apertura.
Nessuno fiatava. Restammo muti, come estasiati. Il vento e l’acqua ci sferzavano le facce. I lunghi capelli di Ida, come imperlati, scendevano a ciuffi sui suoi occhi dal taglio orientale rendendola più attraente.
Palmo che per la trepidazione spostava la testa a scatti ravvicinati e in modo semicircolare, era supercomico. Ingannamorte aveva uno sguardo indecifrabile. Ci affrettammo a togliere di mezzo i detriti. Con le torce speciali facemmo luce dentro.
Il vestibolo con le pareti in pietra dura e squadrata era buio e allagato.
Avevamo fatto dei danni nello scavo, ma, tutto sommato, erano di lieve entità.
L’acqua non era proprio freddissima. Vi entrai sino alla vita per scrutare meglio. Solo vasi in terracotta, sicuramente preziosi poiché avevano la stessa fattura di quello di Uranus e sul fondo una scala con gradini sgretolati consunti dall’acqua.
Ma per capire di più su quanto ci si apriva davanti dovevo esplorare meglio.
L’Urna funebre di Uranus
Non esitai. Inzuppato com’ero, assicuratomi che le torce speciali fossero adatte alle esplorazioni subacquee, tirai un lungo respiro e mi tuffai di sotto. Palmo, che non stava più nella pelle, mi seguì. Ida rimase fuori a vigilare con Ingannamorte che osservava in giro teso e guardingo.
Ci addentrammo nell’antro che si sviluppava ad un livello inferiore: l’acqua stagnava e sull’acciottolato a pochi metri di profondità giacevano, nel fango, vari reperti.
Proseguimmo nell’immersione. Quattro possenti colonne, sui lati, e una centrale, reggevano il soffitto. Sui fianchi si aprivano cavità nelle quali erano scolpite varie effigi. Tutt’attorno vi erano piatti decorati, oggetti e corone in oro, tantissimi vasi ornati, sembrava da una mano sola: quella del Pittore di Metapontum.
Osservavamo inebriati. Ma la cosa che colpiva erano i fregi sulle pareti che rappresentavano una processione sacra sormontata da iscrizioni latine.
Palmo si fermava, fluttuando, a tastare e a osservare le figure e le iscrizioni con le mani, interrompendosi e tornando più volte indietro. Poi si trattenne su quello che mi sembrò un corredo funerario. Dapprima vidi le espressioni di meraviglia del suo volto, quindi prese a gesticolare come un matto. Avevamo bisogno d’aria. In alto trovammo una cavità dove l’acqua non arrivava e risalimmo, ma notammo che quest’ultima aveva preso ad alzarsi di livello. Sentimmo da fuori, flebile, la voce di Ida che ci ammoniva: “L’argine non resisterà a lungo ci sono già infiltrazioni!”. Dovevamo muoverci.
Nel frattempo Palmo, che oramai era in delirio, si affrettò a dire: “Eccezionale, unica, speciale, specialissima scoperta!”
“Palmo stringi, che qui non si sa come va a finire…”, lo esortai.
“Sì, sì. Tra i vasi del corredo funerario ne ho scorto uno sul quale ho intravisto la scritta URANUS PICTOR METAPONTI, e mi sembra chiaro che si tratta dell’urna cinerea del grande pittore. Ma soprattutto le iscrizioni sulle pareti parlano anche di una strana piccola nave animata che giunse dallo spazio! E indovina di cosa si tratta…”, non fece in tempo a concludere la frase che sentimmo uno scossone e un rumore lungo e cupo.
Oramai l’acqua creava gorghi.
“… torniamo immediatamente su o diverremo carne flaccida in ammollo”, dissi.
“Ma…”,
“Di corsa, via!” intimai a Palmo mettendogli la testa sott’acqua.
Ci immergemmo rapidamente e quando stavamo ruotando per effettuare la risalita vidi qualcosa di fosforescente, sopra un altare possente in marmo cesellato era poggiato un misterioso oggetto di forma esagonale. Appariva di un verde luminoso. Palmo mi fece segno di prenderlo.
Con un scatto di reni mi precipitai e l’afferrai.
Poteva avere un’ampiezza di cinquanta centimetri e sebbene fossimo in acqua valutai che doveva pesare quattro-cinque chilogrammi.
Feci appena in tempo ad afferrarlo che tutto intorno cominciò a vorticare.
Il sotterraneo si stava riempiendo di acqua sconvolgendo quell’equilibrio che si era creato in secoli di isolamento. Vidi la colonna centrale che dapprima vacillava poi iniziò a cedere. Raccolsi tutte le energie e nuotai verso l’alto, Palmo mi seguiva a razzo, anche lui in senso avverso all’acqua che, ostile, contrastava la nostra risalita.
Dal soffitto si staccavano pezzi di marmo e sassi. Si alzava fango e si creavano mulinelli di pulviscolo limaccioso. Mi girai e vidi il pilastro centrale che si spezzava, mentre quelli laterali cedevano come pastafrolla.
Fu come in un incubo, come quando si tenta di scappare e si rimane con le gambe di legno sempre nello stesso punto. Il fiato era terminato e stavo per perdere coscienza quando vidi delle braccia che si protendevano per tirarmi fuori da quella trappola. Qualche istante dopo ci fu un crollo che frantumò ciò che di inestimabile c’era lì sotto. Tutto fu inghiottito in un abisso infernale.
Diluviava abbondantemente quando il debole argine che avevo realizzato cedette definitivamente alla corrente divenuta oramai una fiumana.
L’Ologramma di Pitagora
 Quando mi riebbi Ida mi stava aiutando a mettermi in salvo e Ingannamorte trasportava sulle spalle Palmo che aveva ingoiato acqua a più non posso. Poi Ida tornò indietro a prendere la misteriosa navetta esagonale, ma mise un piede in fallo nella melma, scivolò e l’oggetto cadde rimbalzando sul margine del canalone. Tutti avevamo il fiato sospeso sembrava che sarebbe caduto in acqua, invece si bloccò sul ciglio. Emise un ronzio prolungato. Quindi divenne come arroventato ed emanò un bagliore che parve una luce multicolore proveniente da un faro. Sembrava formato da tante molecole che galleggiavano. Comparve, proiettata nell’aria, una sagoma dall’aspetto pallido. Prese una forma tridimensionale, umana: un vecchio con la barba bianca, una tonaca e i sandali. I goccioloni di pioggia attraversavano la figura.
Quando mi riebbi Ida mi stava aiutando a mettermi in salvo e Ingannamorte trasportava sulle spalle Palmo che aveva ingoiato acqua a più non posso. Poi Ida tornò indietro a prendere la misteriosa navetta esagonale, ma mise un piede in fallo nella melma, scivolò e l’oggetto cadde rimbalzando sul margine del canalone. Tutti avevamo il fiato sospeso sembrava che sarebbe caduto in acqua, invece si bloccò sul ciglio. Emise un ronzio prolungato. Quindi divenne come arroventato ed emanò un bagliore che parve una luce multicolore proveniente da un faro. Sembrava formato da tante molecole che galleggiavano. Comparve, proiettata nell’aria, una sagoma dall’aspetto pallido. Prese una forma tridimensionale, umana: un vecchio con la barba bianca, una tonaca e i sandali. I goccioloni di pioggia attraversavano la figura.
“Ma è… è, il Maestro per antonomasia! PITAGORA!”, esclamò sbalordito Palmo. Notai la pressoché totale somiglianza con il busto della Villa Peripato di Taranto.
L’ologramma che aveva le dimensioni di un uomo era a mezz’aria, sollevato di una trentina di centimetri da terra.
Parve registrare la voce di Palmo per rielaborarla in un linguaggio proprio. E mentre noi eravamo sbigottiti e ancora confusi ci fu un effetto acustico come di un nastro magnetico che si riavvolge.
Poi l’ologramma parlò: “Non vi sorprendete se conosco il vostro linguaggio. Come vedete siamo della stessa razza ma io da secoli abito su un altro corpo celeste dell’infinito cosmo. E’ molto singolare, ha tre lune e si trova in una Galassia remota. Sto parlando del Magnifico Pianeta Zkyon. Qui la dimensione spazio-temporale è totalmente diversa dalla vostra, e la civiltà è estremamente complessa e progredita…”
Provai a interromperlo per interloquire. Gli posi alcune domande: “Come ti chiami, chi sei, da dove vieni?”, ma la voce proseguì come nulla fosse, come non potesse ascoltarmi.
“…è proprio per questo che per via di congegni compositi, attraverso pochi termini, posso decriptare il vostro linguaggio, facendolo mio. Il modulo che avete di fronte, che io governo da Zkyon, ha avanzate peculiarità tecniche ed è in grado di conformare il lessico a quello della civiltà con cui entra in contatto. Qui su Zkyon, non abbiamo sconfitto la morte ma, grazie alla tecnologia evoluta, la vita è millenaria. Io sono Pitagora di Samo. So di essere molto celebrato lì da voi per via dei miei studi. Posso osservare tutti i mondi che voglio e conosco quanto accade sulla Terra, giacché da Zkyon vi osserviamo attraverso apparecchiature che potrebbero essere lontanamente paragonate ai vostri satelliti, ma che sono troppo complesse e sofisticate per le vostre elementari conoscenze. Le nostre, invece, sono la sintesi delle migliaia di culture con le quali abbiamo contatti.
Non sono mai morto, ma fui salvato e rapito, se vogliamo, dagli zkynioniani quando avevo deciso di morire nel Mar Jonio, persuaso di aver raggiunto il momento perfetto per la catarsi. Gli zkynioniani, come hanno fatto con me e continuano a fare con altri esseri di vari sistemi stellari, si impossessano delle più valide intelligenze per metterle al servizio della propria evoluzione. Tutti lavoriamo oramai da tanto alla realizzazione dell’Essere Perfetto, ma forse anche su Zkyon ciò è un’utopia. Comunque qui rivesto un ruolo importante e appartengo ai Maah-Mak, privilegiata classe di dotti e sapienti, molto onorati. Ma mi sono assolutamente preclusi i contatti con l’esterno. Vivo in uno stato di perenne esilio, aureo certo, ma lontanissimo dalla mia Terra e soffro molto. E’ questa la mia condizione. Per tale motivo, dopo molti secoli che, per me, in questa Non Dimensione possono essere paragonati a pochi giorni, di nascosto e calcolando la rotta spaziale, sono riuscito a inviare questa mia navicella esattamente là dove vivevo: Metaponto. Per un certo periodo i vostri antenati mi onorarono nel tempio, ma erano primitivi e non avevano le tecnologie per riportarmi sulla Terra. Poi per secoli la mia navicella è rimasta sepolta nel buio.
So bene che al momento, pur essendoci stata un’evoluzione rispetto al passato, neanche voi sareste in grado di riportarmi sulla Terra, poiché siete ai primordi della tecnologia spaziale. Per me l’importante è aver ristabilito il contatto con il mio Mondo. Poi si vedrà! Mi farò risentire presto… ma sappiate che qui non abbiamo la dimensione del tempo e il prossimo contatto da parte mia potrebbe essere anche fra mille dei vostri anni!”.
Ciò detto l’ologramma fu come riassorbito dalla navicella.
Ci guardammo ancora allibiti.
Avevamo sotto mano la più grande scoperta di tutti i tempi! La rivelazione dell’esistenza di una civiltà aliena senziente era venuta da un uomo del passato!
Le sorprese non finiscono mai
“Ok gente. Adesso questa bella macchinetta con il filmato del vecchio Pitagora me la porto. Mi frutterà un bel malloppo quando la venderò a magnati russi di mia conoscenza!”, Vito Ingannamorte aveva una pistola puntata nella nostra direzione.
Le sorprese non finiscono mai!
Ida mise mano alla fondina, era vuota. Impallidì.
“Sta buona, graziosa bambina, per fregare Vito Ingannamorte devi nascere altre tre volte e devi stare più attenta alle armi che porti addosso. Ma tanto non ti servirà nell’altro mondo dove stai per finire tu e questi altri due pivelli”, aggiunse con un ghigno storto sulla faccia.
“Ma non volevi riscattarti e riabilitarti?”, gli chiesi mentre pensavo a cosa fare per venire fuori da quella situazione.
“Certo. Ma inizialmente. Adesso, vista l’entità della scoperta, ci ho ripensato e preferisco la più concreta e sonante moneta alla gloria. E, soprattutto, non voglio testimoni!”,
Cercai di prendere tempo: “Che imbecille che sono stato: il lupo perde il pelo ma non il vizio.”
“Esatto”, disse l’uomo con aria compiaciuta, scatarrando ancora una volta per terra, “…e adesso mammolette…”, stava per premere il grilletto quando, provvidenziali, si udirono le sirene delle volanti della polizia che giungevano veloci dalla vicina Statale 106. Colsi al balzo l’occasione. Mi mossi per bloccarlo. Ingannamorte esitò un attimo poi sparò. Mi colpì di striscio a una gamba. Un graffio. Tentò la fuga. Fece qualche metro di corsa sul bordo del canalone. Con la capsula sotto il braccio destro si muoveva impacciato. Avevo l’adrenalina fuori controllo. Lo raggiunsi. Si voltò e sparò di nuovo. Stavolta feci in tempo a deviargli il colpo in aria bloccandogli il braccio mentre, di lato con il destro, gli tiravo un pugno tra collo e orecchio. Strabuzzò gli occhi ed emise un grugnito. La capsula, viscida di alghe volò nel canale e lui girandosi si allungò in avanti per riafferrarla. Di sotto l‘idrovora ingoiava voracemente acqua.
Si sbilanciò in avanti, sull’orlo dell’adduttore.
Per una frazione di secondo rimase in equilibrio precario. Annaspò in aria e cascò nel canale, finendo nel gorgo dell’idrovora. Sentimmo un rumore di ossa fracassate e un urlo orrendo e gorgogliante che anticipò una chiazza di sangue rosso vermiglio. La chiazza risalì corposa, unita a frammenti di carne che si dispersero nella corrente vorticosa dell’acqua.
Epilogo
Nell’attesa che il Maestro rientri
 Il giorno dopo, la notizia titolava a caratteri cubitali sulle prime pagine dei giornali:
Il giorno dopo, la notizia titolava a caratteri cubitali sulle prime pagine dei giornali:
“Dal passato si apre una porta verso il futuro!”, “A Metaponto una scoperta che muterà i destini del genere umano!”, “Sciolto l’enigma di Pitagora!”.
La capsula con l’ologramma del Maestro greco (composta di uno sconosciuto materiale extraterrestre non subì nemmeno una scalfittura dalle pale dell’idrovora) con patto trilaterale fu affidata a una équipe di studiosi delle Agenzie spaziali italiana ed europea e della Nasa. Il Governo Italiano ne pretese il coordinamento. Metaponto in breve divenne uno dei luoghi maggiormente celebrati dalle troupe televisive dei canali più importanti del pianeta, che si precipitarono per girare documentari e parlare della scoperta.
Per me, per Ida e per Palmo Scavafossi si aprirono scenari insperati. La grande casa editrice americana Doubleday, che pubblica anche Dan Brown, mi contattò immediatamente per un contratto da capogiro sulla storia. Ida, che per tutta l’operazione (violando il nostro patto, ma adesso posso dire che fece bene) aveva tenuto i contatti con la centrale della polizia, ricevette un encomio dal Ministro dell’Interno e fu promossa commissario, partendo ahimè alla volta di Trieste.
A Palmo Scavafossi, che divenne l’idolo della comunità degli studiosi di archeologia, fu affidata la conduzione delle ricerche nella Chora metapontina e incominciò subito dal tentativo di recupero del corredo funerario di Uranus.
Quanto a Vito Ingannamorte, beh… da uno con quel cognome cosa ci si poteva aspettare? Comunque un po’ mi dispiacque per la sua straziante fine, in fondo era un buon diavolo. E poi, diciamolo, fu grazie a lui se rinvenimmo quel patrimonio come dire… fantascientifico. Ah! dimenticavo, i capibastone dei Tremamunno furono arrestati e la gang sgominata del tutto.
Per lavorare al mio libro ho abbandonato la collaborazione al giornale e il bugigattolo dove abitavo a Policoro e ho preso in fitto, a Metaponto lido, una villetta dall’architettura lineare in puro modernariato anni ‘60.
E’ autunno pieno, qui non c’è nessuno e scrivo tutta la giornata. La casa dà sul mare e mi piace osservare i flutti che disfano la sabbia sulla battigia mentre guardo castelli di nuvole che attraversano veloci il cielo grigio chiaro.
Lo Jonio che d’estate ha i colori abbacinanti del Sole meridiano, nella stagione autunnale assume tinte intimiste che portano all’introspezione. Ma porta anche a un pensiero metastorico che affonda sia nell’aura della mitologia greca, sia in un futuro che sino a ieri poteva essere considerato solo science fiction.
Spesso nei lunghi pomeriggi passeggio per le vie deserte per finire sempre calamitato dal lungomare ventoso il quale sembra portarmi la voce di Pitagora. E quando di notte osservo la luce fredda e minuscola delle stelle mi sembra di immaginare il Maestro. Lo vedo che da lassù in un tempo senza tempo, sul Magnifico Pianeta Zkyon, in una stanza impersonale ricurvo su uno scrittoio studia, di nascosto, il modo per far ritorno sulla Terra.
Ho anche idee più profane nei miei pensieri.
Anzitutto ho quasi definitivamente risolto i miei problemi di udito. Ma c’è un compito ancora più importante che sto portando a termine: la vicenda che mi è capitata qualche mese addietro mi ha fatto riavvicinare a Ida. L’ho fatto un po’ per onorare la promessa che mi aveva strappato la notte prima della grande avventura ma anche perché era da tempo che ci pensavo. Così nel periodo precedente al suo trasferimento a Trieste abbiamo ripreso a frequentarci regolarmente (mi ha posto solo il vincolo di tagliarmi i baffetti da sparviero). La settimana entrante la raggiungerò per un breve soggiorno: ci sposeremo in Municipio. Nel frattempo che Pitagora scopra il modo di rimpatriare, è bene continuare a vivere tenendo i piedi per terra!
Filippo Radogna
 “L’enigma di Pitagora” è la terza avventura del reporter dell’occulto Ennio Bini, di cui abbiamo già pubblicato sulla Zona Morta i primi due capitoli: “Catastrofe sullo Jonio” (IV classificato al “IV Trofeo La Centuria e La Zona Morta”) e “Lesak, il Custode della Città Sacra” (Premio della Giuria al concorso internazionale “Cinque Terre Golfo dei Poeti”).
“L’enigma di Pitagora” è la terza avventura del reporter dell’occulto Ennio Bini, di cui abbiamo già pubblicato sulla Zona Morta i primi due capitoli: “Catastrofe sullo Jonio” (IV classificato al “IV Trofeo La Centuria e La Zona Morta”) e “Lesak, il Custode della Città Sacra” (Premio della Giuria al concorso internazionale “Cinque Terre Golfo dei Poeti”).
Questo nuovo racconto si è classificato al terzo posto nel concorso di fantascienza “Senagalactica 2015”, dedicato a Vittorio Curtoni, ed è stato pubblicato sull’antologia del Premio “Senagalactica/2 – Dove stiamo volando?” (Marco Del Bucchia Editore – Lucca 2015).