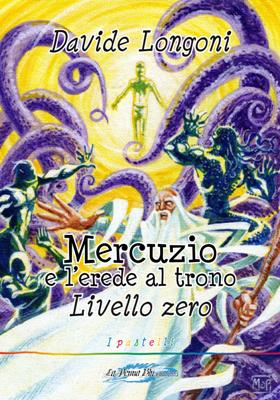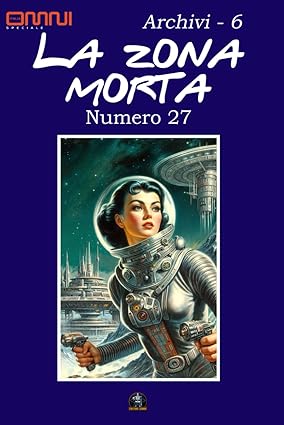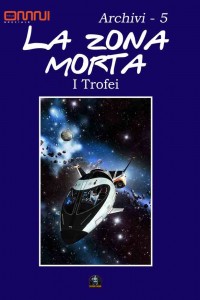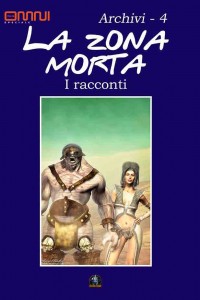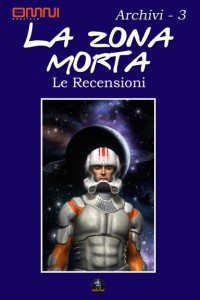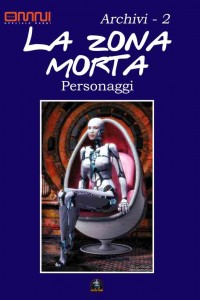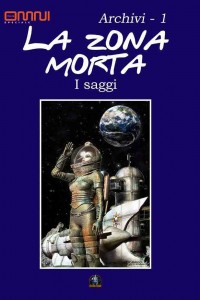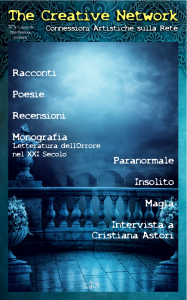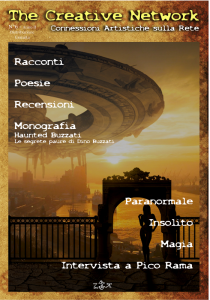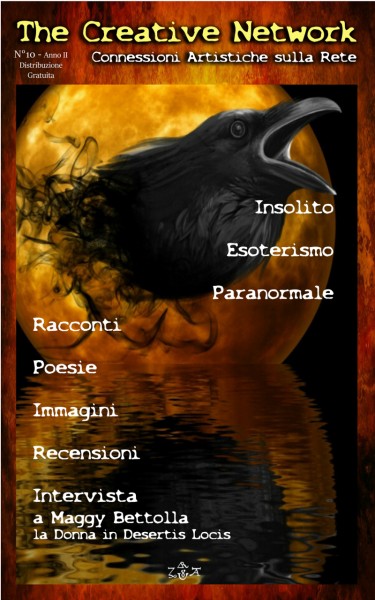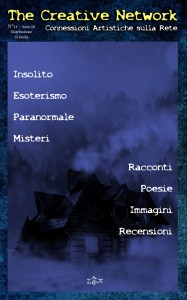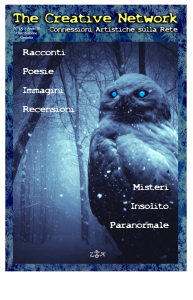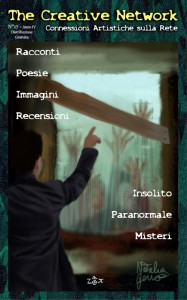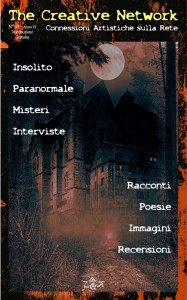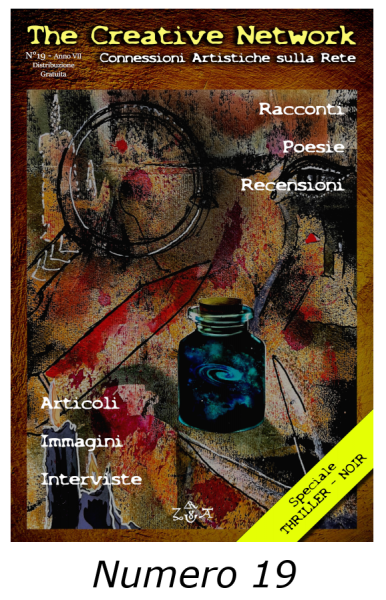A distanza di 15 anni dalla sua prima apparizione negli USA di una delle più celebri puntate di Breaking Bad (1), è forse arrivato il momento di fare un consuntivo delle numerose interpretazioni che di essa sono state date. Quanto alla genesi e ai riferimenti di “Fly”, ne ho lette di ogni genere, dalle stalle alle stelle: si incomincia da un semplice episodio tappabuchi (in gergo “bottiglia”), giusto “per tagliare i costi o allungare le stagioni” sfuggito di mano in corso di lavorazione (intendiamoci: “sfuggito di mano” nel senso più positivo dell’espressione) (2), per arrivare fino a Kafka, più precisamente all’insetto della “Metamorfosi” (3), e addirittura a Macbeth, con relativo paragone dell’animale con il fantasma di Banquo e con altro relativo e puntuale confronto fra un frammento del dettato originale shakespeariano e quello (sempre in inglese) del duo di sceneggiatori Sam Catlin e Moira Walley-Beckett (4). Siamo partiti da un veramente troppo modesto “Fly” per arrivare a una più azzeccata titolazione italiana ironicamente antifrastica: “Caccia grossa”. Vince Gilligan e i suoi collaboratori avranno certo gongolato di fronte a interpretazioni tanto alte che vedono in ogni caso al loro centro l’affiorare del complesso di colpa (in quanto, per citare un solo commentatore “la mosca rappresenta […] anche l’ultimo frammento di umanità rimasto vivo in Walter” (3)): non vedo quindi perché non offrirgliene un’occasione in più, sia pure – questa volta – senza il citato complesso.
A distanza di 15 anni dalla sua prima apparizione negli USA di una delle più celebri puntate di Breaking Bad (1), è forse arrivato il momento di fare un consuntivo delle numerose interpretazioni che di essa sono state date. Quanto alla genesi e ai riferimenti di “Fly”, ne ho lette di ogni genere, dalle stalle alle stelle: si incomincia da un semplice episodio tappabuchi (in gergo “bottiglia”), giusto “per tagliare i costi o allungare le stagioni” sfuggito di mano in corso di lavorazione (intendiamoci: “sfuggito di mano” nel senso più positivo dell’espressione) (2), per arrivare fino a Kafka, più precisamente all’insetto della “Metamorfosi” (3), e addirittura a Macbeth, con relativo paragone dell’animale con il fantasma di Banquo e con altro relativo e puntuale confronto fra un frammento del dettato originale shakespeariano e quello (sempre in inglese) del duo di sceneggiatori Sam Catlin e Moira Walley-Beckett (4). Siamo partiti da un veramente troppo modesto “Fly” per arrivare a una più azzeccata titolazione italiana ironicamente antifrastica: “Caccia grossa”. Vince Gilligan e i suoi collaboratori avranno certo gongolato di fronte a interpretazioni tanto alte che vedono in ogni caso al loro centro l’affiorare del complesso di colpa (in quanto, per citare un solo commentatore “la mosca rappresenta […] anche l’ultimo frammento di umanità rimasto vivo in Walter” (3)): non vedo quindi perché non offrirgliene un’occasione in più, sia pure – questa volta – senza il citato complesso.
“In Decalogo 2: Non nominare il nome di Dio invano – c’è l’angosciante sequenza di una mosca invischiata nel miele, sul fondo di una tazza di thè; sul letto a fianco, un uomo ancor giovane, tra la vita e la morte. Entrambi hanno le stesse, minime possibilità di venirne fuori. La mosca – e l’uomo – poi si salvano, ma niente sarà più uguale a prima…” (5) “La scena della mosca […] funziona come esempio per […] l’impossibile e insperata guarigione di Andrzej […] [essa] avviene parallelamente alla risalita di una mosca che era rimasta mortalmente invischiata nel succo di fragola”. (6). In sostanza, confidando nella cultura cinematografica di Catlin e Walley-Beckett, cautamente ipotizzo che essi abbiano voluto tentare una parodia dell’episodio del Decalogo (serie polacca di Kieślowski/ Piesiewicz, a suo tempo – 1988-1989 – celebre e celebrata anche in Occidente, composta di dieci mediometraggi, uno per comandamento), tutt’altro che con intenti umoristici, ma anzi con molta meno positività dei due autori dell’Europa centrale, che in fin dei conti terminano con un lieto fine la loro fatica di 7 minuti (com’è ovvio non si tratta della durata del film, ma di quella della scalata al cucchiaino della mosca polacca), mentre l’insetto americano ci lascia le ali.
Nel corso della sua tanto pervicace quanto insensata caccia alla mosca, Jesse racconta una storia, anodina solo all’apparenza, che serve invece a collegare gli animali selvatici con il cancro e offre a Walter, per associazione, l’occasione più logica per parlargli del suo recentissimo incontro con l’oncologo. Singolarmente, almeno all’apparenza, non appena White rivela a Jesse che il medico gli ha dato buone notizie sul tumore da cui è affetto (la regressione di esso continua), si fa anche un punto d’onore, a sentir lui una necessità assoluta, di uccidere un insetto che contaminerebbe la purezza del loro prodotto… ma non scordiamoci che si tratta pur sempre di metanfetamina! In effetti su questo aspetto della loro attività il ragazzo è molto più realista: “Noi creiamo veleno per persone a cui non importa niente. Probabilmente abbiamo i clienti meno esigenti al mondo”. Ma Walter è irremovibile e pare proprio non ascoltarlo, perso nella sua paranoide volontà di controllo: “Per poter cucinare dobbiamo sterminarla [la mosca]. Se non ci riusciamo, siamo morti. Non c’è più margine d’errore, non con queste persone”. (Il riferimento è alla banda di Gus, ma suona del tutto fuori luogo rispetto alle richieste del capo).
 Credo proprio che la buona nuova a proposito del cancro abbia riportato il protagonista fin troppo velocemente nei ranghi della norma degli esseri umani: come tutti sappiamo in prima persona, quando non abbiamo grossi problemi (o poco dopo averli superati, come nel caso del nostro chimico) siamo subito pronti a disperarci per cose di secondaria o infima importanza – che poi si tratti di un essere minuscolo a turbare così tanto Walter è soltanto una sottolineatura iperbolica della gravità del male al quale sta riuscendo, dopo tanto terrore e disperazione, a sfuggire. Il ritorno alla normalità, ovvero al veder problematiche cose che non lo sono affatto, è in via metaforica evidente fin dall’inizio sotto il profilo della pura tecnica: non dimentichiamo che è un obiettivo macro a riprendere l’animaletto ingrandito in maniera smisurata. Lascio volutamente da parte gli aspetti più profondi del monologo di Walt a proposito del “momento più giusto per morire” e della sua confusa quasi-confessione a proposito della fine di Jane perché credo che funzionerebbero altrettanto bene anche senza la presenza dell’insetto, mentre tutto quanto concerne l’ironia sulla precisione maniacale dell’uomo di scienza merita maggior considerazione nella mia prospettiva: si parte da un dottorale e altisonante esordio, “in un ambiente altamente controllato [come il loro laboratorio] un agente inquinante, non importa quanto piccolo, può essere un pericolo”, per arrivare a credere nella possibilità che “devono esistere alcune parole che messe in un ordine specifico possano spiegare tutto”, ma d’improvviso l’esortazione per il ragazzo arrampicato sulla scala, ormai anche lui coinvolto a pieno titolo nell’ossessione per la “caccia grossa”, è: “Jessie, scendi, vieni giù: dobbiamo cucinare!”. “Ah, e la contaminazione?”. “Tutto è contaminato”. Per fortuna ci siamo arrivati! Quest’ultima affermazione sconsolata di White, che lo rende alla quotidianità terrestre espellendolo dall’empireo delle scienze esatte, fa il paio col suo improvviso disinteresse per l’uccisione della mosca, favorito anche dai sonniferi somministratigli da Jesse. Anticlimax e sogni d’oro, Walter!
Credo proprio che la buona nuova a proposito del cancro abbia riportato il protagonista fin troppo velocemente nei ranghi della norma degli esseri umani: come tutti sappiamo in prima persona, quando non abbiamo grossi problemi (o poco dopo averli superati, come nel caso del nostro chimico) siamo subito pronti a disperarci per cose di secondaria o infima importanza – che poi si tratti di un essere minuscolo a turbare così tanto Walter è soltanto una sottolineatura iperbolica della gravità del male al quale sta riuscendo, dopo tanto terrore e disperazione, a sfuggire. Il ritorno alla normalità, ovvero al veder problematiche cose che non lo sono affatto, è in via metaforica evidente fin dall’inizio sotto il profilo della pura tecnica: non dimentichiamo che è un obiettivo macro a riprendere l’animaletto ingrandito in maniera smisurata. Lascio volutamente da parte gli aspetti più profondi del monologo di Walt a proposito del “momento più giusto per morire” e della sua confusa quasi-confessione a proposito della fine di Jane perché credo che funzionerebbero altrettanto bene anche senza la presenza dell’insetto, mentre tutto quanto concerne l’ironia sulla precisione maniacale dell’uomo di scienza merita maggior considerazione nella mia prospettiva: si parte da un dottorale e altisonante esordio, “in un ambiente altamente controllato [come il loro laboratorio] un agente inquinante, non importa quanto piccolo, può essere un pericolo”, per arrivare a credere nella possibilità che “devono esistere alcune parole che messe in un ordine specifico possano spiegare tutto”, ma d’improvviso l’esortazione per il ragazzo arrampicato sulla scala, ormai anche lui coinvolto a pieno titolo nell’ossessione per la “caccia grossa”, è: “Jessie, scendi, vieni giù: dobbiamo cucinare!”. “Ah, e la contaminazione?”. “Tutto è contaminato”. Per fortuna ci siamo arrivati! Quest’ultima affermazione sconsolata di White, che lo rende alla quotidianità terrestre espellendolo dall’empireo delle scienze esatte, fa il paio col suo improvviso disinteresse per l’uccisione della mosca, favorito anche dai sonniferi somministratigli da Jesse. Anticlimax e sogni d’oro, Walter!
A dir la verità, sebbene creda davvero alla genesi appena proposta del “simbolo” mosca, ciò che m’interessa maggiormente non è tanto che la mia fonte sia più centrata delle altre o almeno quanto le precedenti, ma semmai proprio che ce ne siano diverse tutte meritevoli di portarsi a casa una parte per quanto piccola del già minuscolo insetto: ciò è una riprova della legge artistica dell’ambiguità in sede di analisi dell’opera, ma anche una conferma del fatto che quando si plasma un oggetto estetico sono moltissime le suggestioni pronte a stimolare in maniera magmatica l’artista: la sua disordinata biblioteca mentale si apre ed egli fa razzia di tutto ciò che gli serve in maniera selvaggia, di Kafka come di Shakespeare, di Kieślowski/ Piesiewicz come di chissà chi altri (7), con un ordine che obbedisce soltanto alla costruzione che egli ha – di solito in forma ancora parziale e confusa – in mente. In altre parole ritengo quasi certo che Catlin e Walley-Beckett non censurerebbero affatto le varie letture critiche che sono state date della loro mosca, ma le avvalorerebbero e semmai ne avrebbero ulteriori da proporre in prima persona o, infine, incoraggerebbero addirittura nuove interpretazioni…
Vale la pena di notare, poi, come i simboli cinematografici forti che hanno preceduto la mosca di Breaking Bad, per esempio il camion di Duel o il celeberrimo parallelepipedo di 2001: Odissea nello spazio, proprio perché singoli elementi sui quali si fissano pressoché in toto l’attenzione e l’interrogazione dello spettatore in quanto enigmi privi di chiavi interpretative certe (8) – così come la nostra mosca, che rispetto agli esempi citati ha in più (o in meno, dipende dai punti di vista) le minuscole dimensioni e l’assoluta banalità – tendano a rendere potenzialmente senza fine l’interpretazione di tali oggetti estetici così come, con tutta probabilità, è senza fine l’interrogazione che si pongono sulla produzione di essi i loro stessi autori.
 Volendo – e io da buon sofista lo voglio – si potrebbe destituire di valore tutto ciò che ho scritto finora sostenendo che la mosca, così come il camion e il parallelepipedo, non hanno alcuna valenza simbolica, ma sono semplicemente degli esempi di “scatola nera” nel significato che di essa dà la pragmatica della comunicazione: “contano i flussi di comunicazione in entrata e in uscita, non il funzionamento intrapsichico della mente”, cioè l’importante non è la mosca / il camion / il parallelepipedo (semplice fenomeno intercambiabile: il funzionamento intrapsichico della mente), ma che l’oggetto in questione comunichi i termini di un problema allo spettatore (input: in un certo film un insetto / un camion / un parallelepipedo significa più della sua apparenza quotidiana e assume una posizione centrale) e la soluzione parziale di esso (output: il film ha un esito che viene incontro alla logica dello spettatore, ma non spiega – o non spiega del tutto – il supposto valore simbolico dell’insetto / camion / parallelepipedo); così il pubblico e l’autore stesso restano sazi, ma con un minimo di appetito – perennemente insoddisfatto perché in fin dei conti fittizio.
Volendo – e io da buon sofista lo voglio – si potrebbe destituire di valore tutto ciò che ho scritto finora sostenendo che la mosca, così come il camion e il parallelepipedo, non hanno alcuna valenza simbolica, ma sono semplicemente degli esempi di “scatola nera” nel significato che di essa dà la pragmatica della comunicazione: “contano i flussi di comunicazione in entrata e in uscita, non il funzionamento intrapsichico della mente”, cioè l’importante non è la mosca / il camion / il parallelepipedo (semplice fenomeno intercambiabile: il funzionamento intrapsichico della mente), ma che l’oggetto in questione comunichi i termini di un problema allo spettatore (input: in un certo film un insetto / un camion / un parallelepipedo significa più della sua apparenza quotidiana e assume una posizione centrale) e la soluzione parziale di esso (output: il film ha un esito che viene incontro alla logica dello spettatore, ma non spiega – o non spiega del tutto – il supposto valore simbolico dell’insetto / camion / parallelepipedo); così il pubblico e l’autore stesso restano sazi, ma con un minimo di appetito – perennemente insoddisfatto perché in fin dei conti fittizio.
Gianfranco Galliano
Note
(1) Al punto da essere ricordata come sceneggiatura esemplare da Stefano Bises (autore di molti copioni importanti fra i quali Esterno notte di Bellocchio e Adagio di Sollima per il cinema e di molti episodi di Gomorra e The New Pope per la tv) in https://www.traccesnc.it/2021/06/scrivere-sceneggiature-serie-stefano-bises/.
(2) M. Furina, https://www.lascimmiapensa.com/2023/06/10/breaking-bad-bryan-caccia-grossa-mosca-episodio/2/.
(3) V. Di Somma, https://www.hallofseries.com/breaking-bad/breaking-bad-fly-capolavoro/.
(4) https://www.reddit.com/r/FanTheories/comments/2oe95g/breaking_bads
_fly_episode_has_a_strong_connection/?tl=it.
(5) S. Russo, https://www.odeonblog.it/2019/10/22/kieslowski-e-il-cambiamento/.
(6) L. Strano, Decalogo–Due: Non nominare il nome di Dio invano, https://www.pointblank.it/recensione-film/krzysztof-kieslowski/decalogo-due. Vale la pena citare il seguito del discorso, sebbene non abbia attinenza con quanto ci proponiamo di dimostrare, per il suo valore filosofico più generale: “Così si potrebbe intendere che il testo suggerisca che la risalita della mosca sul cucchiaio immerso nel succo stia lì allegoricamente, simbolicamente, per il ritorno alla vita di Andrzej. Questa tuttavia è solo una lettura parziale, che interpreta l’evento solo come un costrutto simbolico, distinguendo la cosa che accade – una mosca risale dal succo – dal suo significato – la rinascita di Andrzej; e invece non si deve ignorare la forza con cui, mentre la cosa sembra sul punto di definirsi simbolo, cioè di rimandare ad altro, il didascalico – la natura didascalica dell’accostamento mosca-Andrzej – insiste sulla matericità di ciò che sta avvenendo, la stessa matericità che avviene prima del significato, e contrae la cosa su se stessa, la costringe a restare in se stessa. Guardando l’insetto che disperatamente flette il suo corpo e le sue piccole zampe per arrampicarsi sul cucchiaio immerso nel denso succo rosso del vasetto di fragole portate da Dorota in dono a suo marito, ecco, guardando questo slancio vitale che si compie per se stesso e per propria volontà, per la volontà di sopravvivere e resistere anche mentre fuori il mondo gocciola morte, anche quando il tutto sembra barbarie e anche il sorriso si indurisce nel cristallo, sembra che l’esistente voglia solo esistere, allo stesso modo in cui il colore brilla e vuole solo brillare.”
(7) Magari fagocitando pure (il dottor) Cechov, che nel lapidario – e straordinario – “Morte di un impiegato” fa perire di crepacuore l’uomo a cui è sfuggito uno starnuto (che ha colpito la persona sbagliata) a causa dell’eccessivo senso di colpa provato per il suo imperdonabile gesto. (Un racconto che, per l’esasperato senso della vergogna esibito, potrebbe esser stato scritto da un giapponese). Si veda: A. Čechov, Racconti e novelle; Sansoni.
(8) Come dice Maurice Blanchot con espressione forse un tantino enfatica, “non c’è doppiofondo nel puro enigma” (M. Blanchot, Thomas l’Oscuro, Sansoni, 2023).