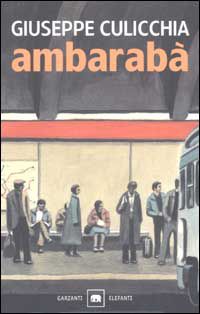 Prendo spunto da Ambarabà di Giuseppe Culicchia per fare un discorso esplorativo sulla Commedia italiana.
Prendo spunto da Ambarabà di Giuseppe Culicchia per fare un discorso esplorativo sulla Commedia italiana.
21 personaggi collettivi, come direbbe Sonego, sono alla basa del libro, uscito per Garzanti nel 2000. Lo sfondo, astratto (reso da una prosa nominale) è quello di una città (ideale? distopica?) percorsa da gas tossici e informazioni liquide. 21 racconti per 21 personaggi senza nome, quasi senza storia, attinti da flussi di coscienza caotici e sperimentali (d’uno sperimentalismo “cannibale”, per restare nelle etichette). In questa sorta di “nuova” commedia (all’)italiana, non ci sono più le grandi maschere dell’Io, gli ierofanti del grottesco come Sordi, Gassman, Manfredi, Tognazzi. I “nuovi” mostri del XXI secolo assomigliano molto più a quelli emersi dalle macerie siciliane di Ciprì & Maresco: piccole unità biologiche votate alla mera sopravvivenza (là scatologica, qui verbale).
Tra le parvenze d’eco proposte, Culicchia offre un campionario di umanità flessibile, già erosa dall’alienazione di un Capitalismo della tarda modernità, votato all’accelerazione sociale e all’emarginazione. Le voci/personaggio sono dissolte nella pagina, disgregate da un ritmo verbale che contrae lo spazio e il tempo del racconto, lo annulla dentro un presente senza più passati e senza più futuri possibili. I 21 personaggi del libro sono attinti in un momento quotidiano (l’attesa del metrò giù nell’underground) di fermata, di sosta forzata; pur tuttavia il loro pensiero è in continuo movimento e l’attesa del convoglio equivale a un ingorgo stradale, ad una stasi deceleratoria che comunque accresce il livello di stress e alienazione e fa esplodere l’inerzia culturale della nostra epoca. Culicchia sostituisce i colletti bianchi, i vigili, gli statali, i mantenuti del cinema di Risi o Zampa con escort precarie, malati del gioco, aspiranti modelle anoressiche, teppisti con pit-bull, aspiranti manager in carriera.
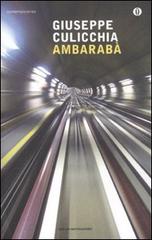 Su tutto e tutti, quel che conta è il successo (ossia un riconoscimento sociale), inteso come gratifica, come soddisfacimento di un istinto, di un bisogno, di una ossessione spesso futile, accessoria. Ecco, automatica. Di un automatismo che pare programmato ad hoc da esperti americani in torture e privazione del sonno. Le 21 psico-voci culicchiane finiscono quasi sempre per deragliare e somigliare a un dispositivo a bassa energia, a un download fallace.
Su tutto e tutti, quel che conta è il successo (ossia un riconoscimento sociale), inteso come gratifica, come soddisfacimento di un istinto, di un bisogno, di una ossessione spesso futile, accessoria. Ecco, automatica. Di un automatismo che pare programmato ad hoc da esperti americani in torture e privazione del sonno. Le 21 psico-voci culicchiane finiscono quasi sempre per deragliare e somigliare a un dispositivo a bassa energia, a un download fallace.
Rispetto alla commedia classica degli anni ’60, qui l’orbita del racconto non ha più bisogno di una morale, di un messaggio da veicolare. Rispetto a film seminali come Sedotta e abbandonata (percorsi dalle fobie ipocrite di una società, moderna solo nell’apparenza scintillante dei bar di paese), la “nuova” commedia di Culicchia, sconfina nell’insonnia morfologica, nella pura inquietudine mortifera. E’ cambiato il paese, è cambiata l’Italia. Allora c’era il boom, vero motore immobile della commedia degli anni ’60, il boom che significava la fine di un paese con le pezze al culo, che avrebbe aspirato a nuovi spezzoni di progresso. Il boom illumina i residui post fascisti della società dei ’60 e punisce ancora le donne per adulterio, usa lo sfollagente contro i pericoli del socialismo in Occidente. La famiglia diviene il perno su cui tutto si fonda. Una famiglia patriarcale, retta da un uomo tiranno e ipocrita, doppio dei politicanti assediati con le loro leggi nel Palazzaccio democristiano. La famiglia della commedia italiana di allora non è ancora allargata, non pretende il divorzio, non chiede diritti per le coppie gay; la famiglia dei ’60 sogna a occhi aperti i frigoriferi, le automobili FIAT, i televisori, i bagni e i servizi interni, le lavatrici. I contadini divengono operai, gli operai hanno figli che diventano impiegati statali col posto fisso, mezzadri d’un benessere alla portata di tutti, finalmente collettivo. Liberi dalle guerre e dalla fame, gli italiani di allora si scoprono differenti e abbandonano le vite “collettive” nelle borgate, nei cascinali padani e traslocano in periferie anonime, illuminate dai bagliori di una festa a base di panettoni e cognac.
 Il villaggio globale è alle porte.
Il villaggio globale è alle porte.
Tuttavia la festa cambierà presto di segno e a metà degli anni ’60 gli effetti del boom sono già finiti. La commedia sfumerà dentro i malumori di una Resistenza tradita, nelle richieste di salari e orari migliori, di scioperi e terrorismi vari. Il comico si farà grottesco, plumbeo, mortifero. E alla fine non si riderà quasi più (penso a film come Salò di Pasolini, dove i 4 signori carnefici altro non sono che l’ennesima maschera grottesca di una borghesia media mostruosa e degenere, capace di assoggettare alle proprie voglie i corpi interscambiabili e anonimi delle giovani vittime). Sulle macerie della Prima Repubblica spunteranno i “mostri” di Ciprì & Maresco, cantori di un mondo già finito, privati di un ruolo istituzionale (il Sordi uomo medio, impegnato ad arrangiarsi per sfangarla su tutto e tutti), emarginati in un universo vuoto, letteralmente ridotto in macerie (come già aveva capito da un pezzo Marco Ferreri in Ciao maschio!). Da queste lande estreme rinascono le voci alienate di Culicchia o di Aldo Nove, recentemente tornato ai fasti di Woobinda col suo ultimo (bruttissimo come i precedenti, forse di più) romanzo: Anteprima mondiale, appena edito.
 Meglio cercare equivalenze letterarie negli scrittori degli anni ’60, coevi a quei film, oppure perdersi dentro a Fratelli d’Italia(1963), baule informale e tragicomico di Alberto Arbasino – vero doppio de Il sorpasso di Risi – (meta)romanzo-saggio collocato dentro la geografia di un’Italia moderna, tra tradizione e progresso grottesco e finto-ininterrotto procedere per accumulo che contiene già tutto. Fratelli d’Italia è parallelo al cinema di Risi, elimina però le correnti profonde di malinconia esistenzialista che scorrono come un fiume sotterraneo nel cinema italiano dei grandi autori. Arbasino si muove tra festival, prime, eventi mondani, aperitivi e dialoghi che sono già sceneggiatura, un parlar a bocca che annulla il personaggio onnisciente, la terza persona, e contribuisce al racconto macchiettistico del personaggio collettivo, della conversazione gossip provinciale e programmaticamente dissolutoria (ma non nel senso del delirio verbale, come nel caso di un Gianni Celati e dei suoi parlamenti buffi).
Meglio cercare equivalenze letterarie negli scrittori degli anni ’60, coevi a quei film, oppure perdersi dentro a Fratelli d’Italia(1963), baule informale e tragicomico di Alberto Arbasino – vero doppio de Il sorpasso di Risi – (meta)romanzo-saggio collocato dentro la geografia di un’Italia moderna, tra tradizione e progresso grottesco e finto-ininterrotto procedere per accumulo che contiene già tutto. Fratelli d’Italia è parallelo al cinema di Risi, elimina però le correnti profonde di malinconia esistenzialista che scorrono come un fiume sotterraneo nel cinema italiano dei grandi autori. Arbasino si muove tra festival, prime, eventi mondani, aperitivi e dialoghi che sono già sceneggiatura, un parlar a bocca che annulla il personaggio onnisciente, la terza persona, e contribuisce al racconto macchiettistico del personaggio collettivo, della conversazione gossip provinciale e programmaticamente dissolutoria (ma non nel senso del delirio verbale, come nel caso di un Gianni Celati e dei suoi parlamenti buffi).
Dunque, riassumendo, la Commedia (all’)italiana si connota come un’arte di arrangiarsi, un trasformismo a seconda delle occasioni e delle opportunità, una furbizia, cialtroneria famigliare che penetra poco a poco nel pubblico, si coagula nel sociale e lo storpia; il popolo della Commedia (e della realtà dei ’60) aspira per la prima volta a essere come il borghese di massa, non più povero morto di fame, bensì consumista fino allo sfinimento psicofisico; ogni cosa assume i contorni di una allegria della catastrofe che trova il suo apice nelle commedie degli anni ’70, spesso pellicole estreme e sperimentali, al limite e oltre il limite della fine.  Penso a film come Vogliamo i colonnelli di Monicelli, Brutti, sporchi e cattivi di Scola, L’ingorgo di Comencini, Porcile di Pasolini, La proprietà non è più un furto di Petri. Oltre al cinema di Marco Ferreri, vero alfiere della catastrofe, cineasta squisitamente negativo, che supera la satira graffiante, e comunque sempre digeribile, di un Risi. Ferreri, prima di Ciprì & Maresco (o del vuoto di senso di un Davide Manuli) mostra la civiltà del malessere, dove tutto è silenziosa decomposizione e apocalisse; la catastrofe è avvenuta in maniera discreta, banale, lasciando un paesaggio umano di sopravvissuti, anarchici, femministe, vecchi e simboli svuotati di senso (Il seme dell’uomo, L’Udienza, La grande abbuffata, Ciao Maschio!). Ferreri va oltre le maschere dei grandi attori, le spreca potremmo dire.
Penso a film come Vogliamo i colonnelli di Monicelli, Brutti, sporchi e cattivi di Scola, L’ingorgo di Comencini, Porcile di Pasolini, La proprietà non è più un furto di Petri. Oltre al cinema di Marco Ferreri, vero alfiere della catastrofe, cineasta squisitamente negativo, che supera la satira graffiante, e comunque sempre digeribile, di un Risi. Ferreri, prima di Ciprì & Maresco (o del vuoto di senso di un Davide Manuli) mostra la civiltà del malessere, dove tutto è silenziosa decomposizione e apocalisse; la catastrofe è avvenuta in maniera discreta, banale, lasciando un paesaggio umano di sopravvissuti, anarchici, femministe, vecchi e simboli svuotati di senso (Il seme dell’uomo, L’Udienza, La grande abbuffata, Ciao Maschio!). Ferreri va oltre le maschere dei grandi attori, le spreca potremmo dire.
Prendo queste considerazioni dall’imprescindibile Castoro del Cinema scritto sul regista milanese da uno dei massimi studiosi italiani di commedia come Maurizio Grande. Grande ha lavorato a lungo sul genere, tornandoci sopra nel corso di vari lavori. Cito Abiti nuziali e biglietti di banca, edito da Bulzoni nel 1986 e oggi introvabile. In quell’opera Grande analizzava il cinema della commedia italiana evidenziando le modalità oniriche di evasione dei suoi personaggi, parlando di un kammerspiel all’italiana, e tornava su Ferreri e sul suo malessere, ormai sempre meno commedia, o commedia del grottesco, tragicommedia amputata del quotidiano.
 Nel volumetto edito sempre da Bulzoni nel 1992, Il cinema di Saturno, Grande trova il centro della commedia nostrana (diversissima da quella americana, per esempio un Billy Wilder) nell’adattamento sociale dei vari “mostri”, nel tentativo dei personaggi di fingersi quello che non sono e cercare di aderire (in modo frustrante) alle regole del consesso civile. Le maschere dell’adattamento (quelle di Sordi, Gassman, Mastroianni, Manfredi, Tognazzi) sono amputate, pirandelliane, inabili a ricoprire i propri ruoli; spesso è possibile riscontrare una eco, uno scarto tra l’attore e il ruolo, quasi un brechtismo, una divaricazione di significato che porta al pasticcio, a un senso di simulacro, un sonnambulismo dell’io.
Nel volumetto edito sempre da Bulzoni nel 1992, Il cinema di Saturno, Grande trova il centro della commedia nostrana (diversissima da quella americana, per esempio un Billy Wilder) nell’adattamento sociale dei vari “mostri”, nel tentativo dei personaggi di fingersi quello che non sono e cercare di aderire (in modo frustrante) alle regole del consesso civile. Le maschere dell’adattamento (quelle di Sordi, Gassman, Mastroianni, Manfredi, Tognazzi) sono amputate, pirandelliane, inabili a ricoprire i propri ruoli; spesso è possibile riscontrare una eco, uno scarto tra l’attore e il ruolo, quasi un brechtismo, una divaricazione di significato che porta al pasticcio, a un senso di simulacro, un sonnambulismo dell’io.
Altre volte i personaggi/maschere divengono secondari, assorbiti dal contesto, dalla cornice in cui sono collocati, e qui torniamo al cinema di Ferreri e allo sfociare della commedia in una apocalisse tascabile (e qui torniamo a Culicchia e alle sue “voci” nel metrò), segno di fine della società sotto il tracollo delle sue menzogne e dei suoi orrori (insurrezioni, bombe, plumbee concezioni politiche, insensatezza di fondo della vita stessa); in questo è perfetto un film come L’ingorgo di Comencini, scritto da Comencini, Ruggero Maccari e Bernardino Zapponi; l’introduzione apposta alla sceneggiatura pubblicata da Cappelli nel 1979 è illuminante: l’on the road di Comencini non porta a nulla, solo a una occlusione di simboli consumistici e personaggi stereotipati che non significano niente, inceppati su un pezzetto della Fiumicino. Col procedere della narrazione, la sceneggiatura somiglia a certe distopie di Ballard (Condominium, L’isola di cemento, La mostra delle atrocità), dove in un ambiente chiuso avviene una disgregazione sociale, una implosione folle di comportamenti da cronaca nera. L’Italia banale dell’Ingorgo si estingue tra tettucci, parafanghi, cofani polverosi, lamiere già pre-Christine kinghiane, pronte a soffocare Sordi, Mastroianni, Tognazzi e noi coi gas di scarico.






























