Pochi giorni dopo Azela e Barbara si recarono insieme a casa di Armando. Tutto era pronto per il rito e gli ultimi dubbi avevano lasciato il posto alla voglia di far presto per non dover più pensare.
Il santéro non fu sorpreso nel vedere le due donne.
“Ho preparato tutto” disse.
Barbara non aveva idea di cosa fosse necessario per quella cosa orribile, era sconvolta e per calmarsi pensava soltanto a Roberto, non voleva neppure capire ciò che stava accadendo. Una voce interna le diceva che tutto serviva per riaverlo e che lei non doveva pensare a niente, solo al sorriso di suo figlio e a quando lo avrebbe rivisto aperto e sincero, come una volta.
“Noi abbiamo l’elemento fondamentale” rispose Azela.
Tutto era sotto controllo, Barbara come un fantoccio si lasciava guidare e trasportare in un gioco terribile, una cosa che non avrebbe mai pensato di fare in vita sua.
 Attraversarono il corridoio tra le immagini degli orishas e raggiunsero la casupola di legno con la prenda haitiana. Barbara rimase sorpresa nel vedere quello che sarebbe servito per la cerimonia. Vicino alla prenda notò due capretti, uno nero e uno bianco, poi dei gusci d’uovo sbriciolati, delle bottiglie di rum bianco e le teste scarnificate di altri due capretti. Intorno alla prenda c’erano diversi tipi di frutta, riconobbe la guayaba, il mamey, il cocco, la cirimoia e il nipero. Due piccioni neri volavano nella gabbia che l’ultima volta conteneva le colombe bianche. Intorno alla prenda c’era del grasso di serpente, dell’olio di cocco e della meringa. Tutto era predisposto come sopra una tavola in attesa di consumare il pranzo.
Attraversarono il corridoio tra le immagini degli orishas e raggiunsero la casupola di legno con la prenda haitiana. Barbara rimase sorpresa nel vedere quello che sarebbe servito per la cerimonia. Vicino alla prenda notò due capretti, uno nero e uno bianco, poi dei gusci d’uovo sbriciolati, delle bottiglie di rum bianco e le teste scarnificate di altri due capretti. Intorno alla prenda c’erano diversi tipi di frutta, riconobbe la guayaba, il mamey, il cocco, la cirimoia e il nipero. Due piccioni neri volavano nella gabbia che l’ultima volta conteneva le colombe bianche. Intorno alla prenda c’era del grasso di serpente, dell’olio di cocco e della meringa. Tutto era predisposto come sopra una tavola in attesa di consumare il pranzo.
Armando indossò il berretto bianco e i collari che raffiguravano gli orishas, poi cominciò a cantare una nenia africana che di tanto in tanto lasciava intuire qualche parola spagnola dal suono strano. Azela lo accompagnava cantando, gli porgeva l’occorrente per la funzione, e accendeva le candele per tutta la stanza e vicino alla prenda. In un angolo di quella stanza senza finestre stava la statua di Nostra Signora della Misericordia con le offerte ai piedi. Armando si avvicinò, fece un inchino, accese una candela e intonò un canto dedicato a Obatalá. Il rito cominciava sempre così, Armando riponeva tutta la sua forza e i poteri in quell’orisha vestito di bianco. Barbara guardò il santéro preoccupata, la sua pelle nera splendeva illuminata dalla luce delle candele e quel copricapo bianco gli conferiva un alone magico e un aspetto soprannaturale. Gli occhi infossati di Armando cercavano la statua di Obatalá e la prenda, le mani scarne si muovevano tra gli ingredienti che servivano al rito e il cattivo odore che anche la prima volta l’aveva colpita era ancora più intenso. C’era puzza di animali morti e di frutta andata a male, mista a odore di cera e grasso di serpente. Barbara ebbe un conato di vomito, non era abituata a certe cose.
“Fatti forza” le disse Azela “altrimenti la paura ti bloccherà”
“Ci proverò” rispose Barbara, ma stava male fisicamente. L’aria chiusa di quella stanza e l’odore penetrante di carcasse putrefatte l’aveva presa alla gola e non la lasciava andare.
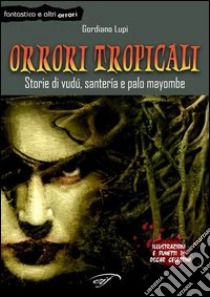 La vista di Armando che si avvicinava ai due capretti la distolse dai pensieri e da quel dolore allo stomaco che si era fatto intenso.
La vista di Armando che si avvicinava ai due capretti la distolse dai pensieri e da quel dolore allo stomaco che si era fatto intenso.
Per un attimo. Poi il dolore fu più forte e la voglia di vomitare ancora maggiore. Non aveva mai visto una cosa simile.
Il santéro, brandendo un machete affilato, aveva sferrato due colpi decisi sul collo dei capretti staccando di netto le teste, che caddero a terra e cosparsero di sangue la prenda e il pavimento. Gli animali non ebbero neppure il tempo di rendersene conto, si accasciarono a terra privi di vita come due fantocci surreali, agitando le zampe negli ultimi movimenti prima di spirare.
“Non posso guardare” disse Barbara appoggiandosi ad Azela “mi fa troppo schifo.”
“Devi farlo, pensa a tuo figlio.”
Era l’unica cosa che le dava coraggio per continuare in quell’assurda cerimonia. La vista del sangue l’aveva sempre spaventata, adesso era fondamentale partecipare al rito, se voleva che Roberto tornasse in vita.
Armando raccolse le teste dei capretti uccisi che erano ancora calde e grondavano sangue e le pose una accanto all’altra davanti alla prenda. Poco distante aveva sistemato gli scheletri degli altri due capretti scarnificati e tutto intorno la frutta, sette coppie di ogni tipo. Spalmò con cura il grasso di serpente sulle teste mozzate dei capretti e l’olio di cocco sugli scheletri. Poi si diresse verso la gabbia e afferrò i due piccioni neri portandoli con sé vicino alla prenda. Questa volta non ci fu bisogno del machete. Armando prese prima un piccione e poi l’altro, li avvicinò alla bocca e con un morso deciso mozzò loro il collo. Il sangue si sparse sulla prenda e Barbara questa volta non ce la fece a fare a meno di vomitare, poggiando la sua mano sulla spalla di Azela. Lo spettacolo era raccapricciante, gli odori nauseabondi, inoltre non aveva mai assistito a una tale carneficina, aveva terrore persino di spellare un coniglio prima di cuocerlo e quando poteva permettersi di comprarlo era un’operazione che lasciava volentieri al macellaio.
Armando proseguì, senza curarsi di quel che accadeva, come se fosse in un’altra dimensione e non potesse rendersi conto degli eventi circostanti. Fece defluire il sangue dei piccioni sugli scheletri e sulle teste dei capretti uccisi, poi sistemò i due volatili davanti alla prenda, in modo che guardassero la testa del capretto bianco.
Armando fece capire alle due donne che il momento era importante. Lui e Azela cantavano, Barbara assisteva spaventata e incredula, disgustata da tutto quel sangue e dal cattivo odore. Una musica africana mescolata ad antiche parole spagnole si diffondeva nell’aria. Il santéro si rivolse ad Azela.
“Dammi quel foglio” disse.
 Azela gli porse un pezzo di carta spiegazzato dove c’era scritto un nome, Armando lo prese e si avvicinò di nuovo alla prenda che conteneva carcasse di animale morto e ossa sbriciolate. Davanti c’erano le teste dei capretti uccisi, gli scheletri e i piccioni decapitati, intorno la frutta. Il santéro alzò le mani al cielo e pronunciò poche parole.
Azela gli porse un pezzo di carta spiegazzato dove c’era scritto un nome, Armando lo prese e si avvicinò di nuovo alla prenda che conteneva carcasse di animale morto e ossa sbriciolate. Davanti c’erano le teste dei capretti uccisi, gli scheletri e i piccioni decapitati, intorno la frutta. Il santéro alzò le mani al cielo e pronunciò poche parole.
“Manolo Higueras Fuente è quello che tu vuoi. Io ti concedo la sua testa. Libera il corpo che stai occupando. Lascialo andare.”
D’improvviso si udì un rumore di cocci, una brocca piena era caduta accanto a una fila di candele accese. Un vento gelido percorse la stanza e Barbara sentì un brivido di freddo nel corpo. Il santéro invece sudava e la pelle nera risplendeva al fioco lume delle candele. Ripeté l’invocazione altre due volte. Si udì un boato, come un tuono a scuotere la notte, Barbara pensò che forse era soltanto la sua immaginazione.
“L’esperimento è riuscito” disse Armando.
E cadde a terra esausto.
 Quello che sento è un vento gelido di morte che mi soffia alle spalle. Confuso inanellarsi di pensieri ai bordi della notte. Comete che cadono da un cielo senza stelle. Il buio accanto a me. Il buio e la morte. Le uniche due cose importanti della vita. Perché è di notte che la vita ci lascia più facilmente, nessuno si accorge che il tempo perduto non va trattenuto tra le mani serrate. Nessuno. Il buio è il momento migliore per colpire e placare la sete. Una sete di odio e una voglia di vendetta che diventa più forte ogni minuto che passa. Confusione e tormento si alternano nella mia mente.
Quello che sento è un vento gelido di morte che mi soffia alle spalle. Confuso inanellarsi di pensieri ai bordi della notte. Comete che cadono da un cielo senza stelle. Il buio accanto a me. Il buio e la morte. Le uniche due cose importanti della vita. Perché è di notte che la vita ci lascia più facilmente, nessuno si accorge che il tempo perduto non va trattenuto tra le mani serrate. Nessuno. Il buio è il momento migliore per colpire e placare la sete. Una sete di odio e una voglia di vendetta che diventa più forte ogni minuto che passa. Confusione e tormento si alternano nella mia mente.
Non so chi sono e cerco annaspando nel vuoto una risposta.
Intorno a me soltanto silenzio. Troppo silenzio.
Mi sento stanco e ho le membra pesanti, sono troppe le cose che non riesco a capire. Afferro i pensieri che restano, lentamente, come se la stanchezza mi indicasse la strada. Mi lascio guidare dall’istinto del mio stesso delirio. Perché la notte è amore, in fondo. Amore è vedere le gambe aperte di una donna e il suo sorriso farsi ghigno di paura davanti alla lama di un coltello. Amore è sentire il battito animale di un uomo in fuga che sa d’essere braccato dal destino. Amore è un tutt’uno unico ed eterno con la morte, il suo doppio e la sua fantastica ossessione.
Se credete di aver segregato la mia anima nel vuoto infinito avete commesso un errore. Perché di me non ci si libera come non si lasciano alle spalle le nostre ossessioni. Non si può chiudere in una gabbia la paura. Non si sconfigge l’odio.
Io sono un incubo che vola libero in una notte di passione. Vola per dispensare destini d’amore e sogni di morte mentre il mare percuote le scogliere.
Io sono l’amore.
Io sono il futuro che tormenterà le vostre notti.
Io sono colui che decide, come sempre.
E quando comincerò a farlo tremerete.
Perché dovrete vedervela contro il mio odio implacabile.
(8 – continua)
































